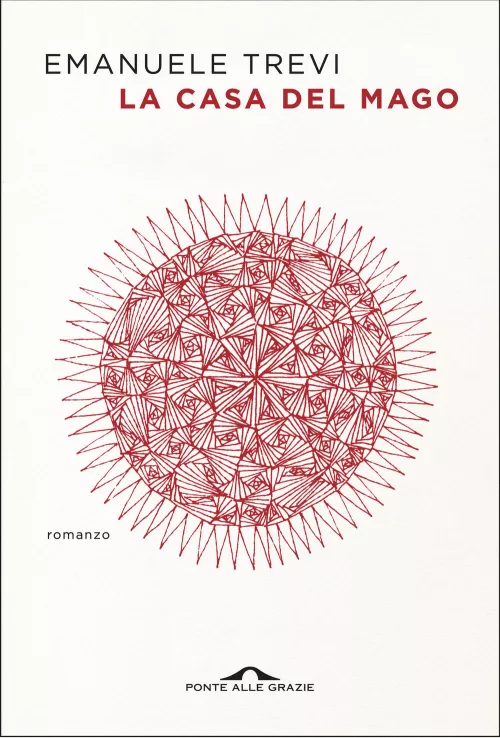Emanuele Trevi: la casa, il padre e il destino
Può una casa cambiare il destino di chi la va ad abitare? Sì, se la casa è stata in passato quella del proprio padre; e se poi questo padre è un celebre piscoanalista e chi vi si trasferisce dopo la sua scomparsa – il figlio – uno scrittore di vaglia, la risposta non può che essere affermativa. Che il “destino” sia uno dei temi principali, se non il principale, di La casa del mago (Ponte alle Grazie, pp. 249), come pure di tutti o quasi i libri di Emanuele Trevi, non c’è dubbio. Ma cosa significa “destino”? Lo dice la radice latina della parola: “volere”, “stabilire”, e persino “ostinarsi”. Da cui deriva l’idea d’una predeterminazione, come comunemente si dice. Che Emanuele sia un predestinato lo si evince dal romanzo biografico che ha scritto, dedicato a suo padre e alla sua eredità edilizia, romanzo che poi è prima di tutto un’autobiografia.
Mario Trevi è il destino di Emanuele Trevi, anche se la prima scena del libro sembrerebbe indicare il contrario, o almeno un destino alla rovescia; ma si tratta solo di uno dei tanti depistamenti posti con abilità – più o meno consapevole – dall’autore medesimo. Portato a Venezia in visita a una Biennale dell’arte dal padre, Emanuele bambino viene istruito dalla madre di non lasciare neppure per un momento il contatto con il genitore: suggerisce di tenersi stretto a lui mediante la cintura dell’impermeabile. Emanuele prova a stringerla tra le mani nelle calli, ma lo smarrisce ben presto nel labirinto veneziano. Per fortuna, consigliato dalla madre, ha conservato l’indirizzo dell’hotel dove sono alloggiati: è stampigliato su una saponetta messa in tasca come i sassolini di Pollicino per ritrovare la strada. Comincia quindi con un disorientamento il primo racconto del Padre e prosegue con un fallimento: il già adulto Emanuele senza volerlo fa sì che i ladri ripuliscano lo scompartimento-notte del treno dove dorme col Padre, privando lo stesso di tutto, scarpe comprese, mentre il Figlio veglia con la sua immancabile sigaretta in bocca.
Certo Emanuele non è Edipo che uccide il padre e giace con la madre, ma qualcosa di quasi mitico in questi due azioni c’è. Insomma, il libro comincia alla grande con un dio chiuso in sé stesso, Mario Trevi, e un aspirante semidio, Emanuele Trevi, che vuole conoscere il segreto del Padre e finisce per mostrare invece la propria inettitudine nell’arco di un decennio, o forse più. La prima parte del libro cerca di rivelare chi sia il Padre: un maldestro, un sapiente, un cesellatore di aforismi, un enigma, e altro ancora. Di certo per il Figlio lui è “l’anima più ferita dell’universo”, salvo poi spiegare che la malattia dell’anima, la ferita, altro non è che “la menzogna, l’illusione fatale di appartenere a questo mondo, di non provenire da nessun’altra parte”. Menzogna è una parola chiave per uno junghiano come Mario Trevi, così come per il suo maestro, il super-famoso psicoanalista Ernst Bernhard. La frase virgolettata termina con un punto interrogativo, ma è evidente che si tratta d’una affermazione. Da dove proviene Mario, e quindi anche Emanuele? Non è questa un’altra perfetta miniatura dipinta a mano dall’autore del libro, così come ha cominciato a raccontarsi a partire da Qualcosa di scritto (2012)? Mario Trevi è un mistero, ma al tempo stesso la rivelazione di Emanuele, il suo avatar nel tempo e nello spazio, un tempo e uno spazio per largo tratto condiviso, che genera memoria, ricordo, commozione, immagini del passato e premonizioni del futuro.
Un libro questo, La casa del mago, che sembra partorito da uno sbadiglio dei precedenti volumi di Trevi figlio, uno sbadiglio che non implica noia, ma solo a volte desiderio d’assopimento, di riposo, perché essere figlio d’un mistero non è sempre una cosa facile da sopportare – per quanto i padri più delle madri siano misteriosi per i figli maschi. C’è da dire che Mario Trevi raccontato da Emanuele somiglia molto a Mister Magoo, il simpatico vecchietto di John Hubley che ha divertito i telespettatori della nostra prima televisione. Certo non c’è solo lo psicoanalista da anziano, quello che Emanuele accompagna ad incontrare i suoi lontani studenti d’un Liceo di Formia. Negli ultimi capitoli, dopo averlo abbandonato per raccontare le mirabolanti avventure della Degenerata e di Paradisa, coprotagonisti del libro insieme al Padre, ci restituisce l’infanzia e la giovinezza del celebre psicoanalista, da cui gli è capitato di discendere – ecco di nuovo il Destino che fa capolino –, compresa la partecipazione alla lotta antinazista, rischi corsi inclusi, come si scopre a un certo punto – gli oggetti nel libro svolgono un ruolo significativo, a partire dalla coperta trapassata da una pallottola di proprietà di Mario, da lui conservata come quella famosa di Linus, già narrata, seppur diversamente, nel libro intervista di Mario ed Emanuele Invasioni controllate (Castelvecchi).

La casa che figura nel titolo non è solo una protagonista parlante; funziona essa stessa come oggetto-contenitore, centro focale della storia, residuo e spoglia del padre medesimo, suo abito da indossare per poter iniziare a raccontare. In questi passaggi narrativi Emanuele Trevi è bravissimo, perché possiede insieme alla focalizzazione del provetto narratore di storie, anche la cialtronaggine di chi le sa far sbandare ad arte, quindi di trascinarle per la coda quando tutto andrebbe preso per le corna. In altre parole, maneggia l’arte dell’indugio problematico e persino quella della creazione di suspence con la figura della Visitatrice, la imperscrutabile presenza che s’introduce nella casa del padre nottetempo, fino al cambio di serratura. L’indolenza è un’altra delle grandi muse di Trevi, insieme al complesso di essere-come-tu-mi-vuoi, che assume a un certo punto le forme di un caso clinico di Jung, Miss Miller, sorta di Zelig che cambia gusti a seconda di chi ha di fronte.
Il punto oscuro di Mario Trevi è quello di fuggire sempre all’interno di sé stesso. Di esserci e insieme non esserci, cosa che non deve aver in alcun modo ottuso la comprensione di pazienti, studenti e devoti. Emanuele-narratore, ovvero artista, dal canto suo confessa di essere in completa balia dei propri stati d’animo. Il punctum appare il desiderio-di essere-amati, per quanto si tratti di un bisogno che non potrà mai essere colmato, simile a un pozzo senza fondo. Il punto più alto della narrazione vagolante del padre e della casa si ha con l’entrata in scena della Degenerata, la donna di servizio peruviana, o collaboratrice famigliare, che si rivela una parassita attaccata al pari di una zecca alla pelle di Emanuele, di cui egli non riesce a disfarsi rivelando così una inettitudine alla Zeno Cosini. Si tratta della parte più bella del libro, perché nella scala delle relazioni Emanuele incontra qualcuno che è socialmente vari gradini più sotto di lui, ma che al tempo stesso lo domina, o almeno lo mette in scacco. Degenerata lo tiranneggia con la sua palese incapacità a svolgere i lavori domestici per cui è pagata: una vera lavativa. La dialettica servo-padrone s’incista nella vita del narratore, ma poi di colpo la storia ha un colpo d’ala con l’introduzione di Paradisa, una prostituta peruviana, portata nella casa del Mago dalla Degenerata, che la getta letteralmente, da pronuba qual è, nelle braccia di Emanuele con grande piacere dello stesso dando vita a una storia sessual-sentimentale tra il commuovente e il comico.
Qui la prosa di Trevi figlio sale di temperatura per la capacità di trasmettere il piacere dell’incantamento che la ragazza gli trasmette, insieme con gli effetti benefici. La Gatta Morta – perfetta definizione di Paradisa – è capace d’una sussurrante mitezza, anche se poi rivela la natura d’ammiratrice dei dittatori sudamericani, una populista quasi fascista, tutto il contrario di quanto era apparsa a Emanuele sin dalla festa di compleanno in cui l’ha adescato. Emanuele Trevi possiede una particolare propensione per un grottesco ben temperato, tratto con cui mette in campo nei suoi libri personaggi esagerati e impossibili come Laura Betti, coprotagonista di Qualcosa di scritto, in cui per altro egli si specchia con mal celata soddisfazione. Lui stesso si rappresenta nei panni, oltre che di inetto, di mascherone grottesco, nel senso pittorico del termine, con accompagnamenti di virtuosismi calligrafici, motivi paradossali, instabilità emotive e improvvise accensioni. La sua è una scrittura manierista senza però utilizzare un linguaggio del genere. Il manierismo di Trevi, come si vede bene in questo godibilissimo romanzo di formazione, consiste più in tropi narrativi che linguistici. Adotta una lingua media mesciata con il parlato colloquiale e sbarazzino dei figli. Sembra, poi, che stia raccontando la sua storia a ciascuno di noi lettori con tono confidenziale che sfiora il sapienziale. A leggere controluce le pagine dedicate a Paradisa, ci si accorge che c’è qualcosa di comune tra lei e il Padre. Entrambi i personaggi sembrano chiusi in sé stessi, presenti in un altrove, anche quando sono lì davanti.
Nel caso di Mario Trevi raccontato dal Figlio l’irraggiungibile, il mistero, è avvolto nelle spire d’un sapere arcano come quello della psicoanalisi junghiana – bellissimi gli enigmatici commenti del Padre a Simboli della trasformazione di Jung –, mentre Paradisa possiede qualcosa di simile ma incarnato nel proprio corpo paffuto e morbido, materno e sensuale. Miss Miller, la Visitatrice e Paradisa, che dorme dolcemente accanto al narratore, portano con sé, scrive l’autore, “un messaggio, anzi una parte di messaggio” che lui dovrebbe ricomporre nella sua totalità. C’è riuscito? Sì, ma quel messaggio resta comunque celato pur nel racconto così intimamente autobiografico del libro. Alla fine nessun mistero viene sciolto, eppure tutto sembra così evidente e chiaro a chi legge. Non c’è mistero? C’è, ma questo fa parte della natura dello scrittore che dichiara di non essere venuto al mondo per sciogliere nodi. Qui i nodi sono tutti in bella vista, e non aperti. Viene un sospetto: che Trevi figlio, parlando del Trevi padre, abbia finito per riscrivere una sua versione postmoderna degli Indifferenti? Lo sfondo su cui si svolge la storia, fondale di cartone, solo appena abbozzato, non è quello del Fascismo storico, ma quello del mondo tardocapitalista attuale, il mondo in cui all’indifferenza l’autore risponde con la differenza, con la storia di un bianco benestante (di sinistra), un vero boccalone, che si fa beatamente truffare da una coppia di donne latinoamericane, e da tutto questo ne trae un piacere molto evidente – piacere sessuale, piacere emotivo, e soprattutto piacere del piacere. Inviato a raccontare per conto di una rivista il CERN delle particelle sottili e del bosone di Higgs a Ginevra nel finale – Trevi-figlio è uno scrittore –, il narratore arriva al punto.
Incontra Paradisa e vicino a lei, che continua ad emanare il suo meraviglioso profumo di vaniglia, scopre la bellezza dell’attimo fuggente, che è poi l’estetica che segna di sé tutta l’opera letteraria di Emanuele Trevi. Ogni momento della vita, scrive, non è altro che “un equilibrio imprevedibile di forze contrarie, una configurazione unica del caso nella fuga degli specchi della possibilità, un oracolo cinese”. Forse questo è anche la spiegazione del mistero di Trevi padre? Non è dato sapere. Ma basta un nonnulla, un battito di ciglia e la realtà “si è già stufata di aspettarci, è andata a giocare da qualche parte”. Questa è l’unica differenza che è data di sperimentare? Risposta non c’è.