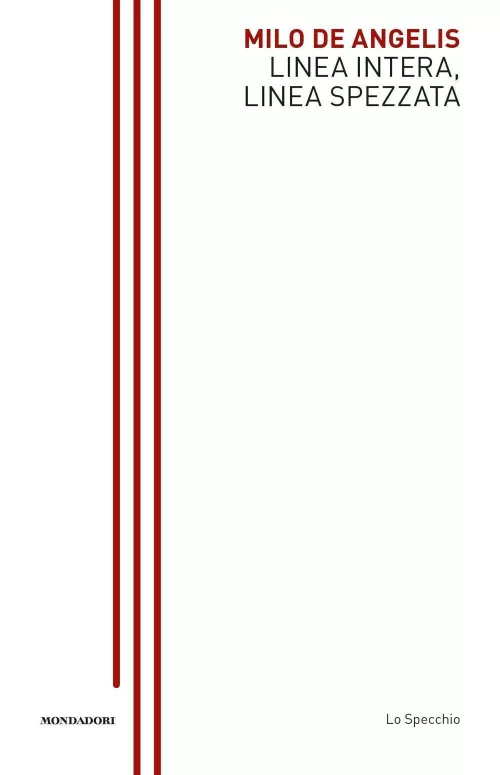Milo De Angelis: Linea intera, linea spezzata
C’è una linea – un confine da valicare, una porta da attraversare – presente da sempre nella poesia di Milo De Angelis, che potremmo chiamare dell’inafferrabile. Sta lì nel chiaroscuro dell’incomprensibile, uno scenario di finestre a volte aperte a volte chiuse, un posto dove non è necessario capire, comprendere, ma è ragionevole lasciarsi andare, seguire la luce che viene dai testi, fermarsi nell’attimo in cui si fa più fioca, attendere perché tra un istante, tra uno o due versi ci inonderà, e l’ombra proiettata sul muro potrebbe essere la nostra, è di certo la nostra, ma non starà lì a lungo, è destinata a sparire, come il muro che si creperà o finirà alle spalle del prossimo angolo, in un pozzo di misericordia, in un ricordo. E per lasciarsi andare bisogna essere consapevoli, De Angelis non domanda abbandono ma coscienza. La capacità di seguire un percorso che non va da nessuna parte, almeno non ci arriva dritto. Averlo letto in tutti questi anni ci fa somigliare di più a qualcuno che stia viaggiando per cerchi, come quelli della 90 e della 91 che seguono la circonvallazione esterna di Milano, solo che il percorso non è mai lo stesso. La filovia di De Angelis ci conduce in un tragitto in cui il tempo non esiste, non rispetta la cronologia, ma si riproduce per ellissi, piccoli vortici, così che il quotidiano e l’immaginario, il passato e il futuro, la vita e la morte, il ricordo e la voglia di dimenticare, siano legati, contigui, e poi dissolti.
«Sali sul tram numero quattordici e sei destinato a scendere
in un tempo che hai misurato mille volte
ma non conosci veramente,
osservi in alto lo scorrere dei fili e in basso l’asfalto bagnato,
l’asfalto che riceve la pioggia e chiama dal profondo,
ci raccoglie in un respiro che non è di questa terra, e tu allora
guardi l’orologio, saluti il guidatore. Tutto è come sempre
ma non è di questa terra e con il palmo della mano
pulisci il vetro dal vapore, scruti gli spettri che corrono
sulle rotaie e quando sorridi a lei vestita di amaranto
che scende in fretta i due scalini, fai con la mano un gesto
che sembrava un saluto ma è un addio.»
Scendiamo alla nostra fermata ma non c’è più il portone d’entrata che avevamo lasciato al mattino, invece troviamo il cancello che stava lì vent’anni prima, una
vecchia sala da biliardo che ha chiuso, un conoscente che credevamo morto e che adesso ci sorride, ci guarda con le rughe profonde, ci interroga con antiche domande. Eccolo lo sgomento, l’inafferrabile, qualcosa di molto vicino eppure distante. De Angelis vuole che stiamo là, vigili e stupefatti, pronti a cogliere quello che non può essere definito, né trattenuto, un antico bagliore, una nuova malinconia, una sorta di grazia, la poesia.
Milo De Angelis ci invita a sostare nella frattura, ad anteporre l’istinto alla storia, a muoverci tra la messa a fuoco e lo sfocato, a fissare un punto che dopo un istante sparirà, perché tutto sparisce e tutto si sottrae. Dipendiamo dai nostri desideri, ma non li conosciamo, la poesia ce li mostra, almeno ai più attenti di noi. Proprio Milo di recente ha affermato: «la poesia ci conduce in un luogo sconosciuto in cui non siamo più noi stessi […] ci mostra ciò che volevamo veramente, non si limita a compiere l’attesa ma ci mostra il lato in ombra dell’attesa, il suo lato nascosto». Ecco, da quando uscì Somiglianze nel 1976, il suo primo libro, vaghiamo a metà tra paura e stupore cercando con le parole di Milo De Angelis il lato celato dell’attesa. Quell’ombra ci è necessaria prima che arrivi «la piccola lanterna nel buio delle nostre cantine» un po’ a illuminarci, un po’ a stanarci, qualche volta a confortarci.
La lanterna si è accesa qualche settimana fa quando per Mondadori è uscito il nuovo libro di Milo (ha ragione Umberto Fiori «Mentre Sereni è Sereni, De Angelis è Milo») Linea intera, linea spezzata, un volume bellissimo che sparge la sua luce di lettura in lettura, facendo più chiarore in un verso, dopo che il precedente ci aveva condotti fino all’oscurità. La capacità di travolgere di queste poesie rende pacifico il fatto che si tratti di testi destinati a essere letti per molti anni, sui quali sarà necessario e bello ritornare, di tanto in tanto, aprendo il libro a caso. Tutte e quattro le parti che compongono la raccolta sono animate dal furore che ha sempre viaggiato col poeta milanese, l’impeto o «l’alta tensione» (come ha scritto in Poesia e destino), e dopo da una lieve forma di malinconica dolcezza, che ci coglie prima ancora di saperne il perché.
«La sera, nella grande stazione dei pullman, è una frenesia
di corpi e di luci, tutto sta iniziando, tutto s’incammina,
tra clacson e fanali, le ruote fremono, si aggregano le ombre
e l’ho trovato qui, l’amico delle feste lussuose, l’amico
dai golf di cashmere e le scarpe di Brigatti, che si avventura
come un fanciullo di mille anni verso un’altra terra
con una ferita che dilaga nel suo corpo e una fuga
che vuole confondersi con il mondo e gioca a nascondino.
“Tu dove vai?” “Non so, non so, il vento
soffia dove vuole” “Vediamoci, una sera a cena,
quando tornerai” “Non lo so, prima devo scordare
tutto, tutto deve essere scordato.”»
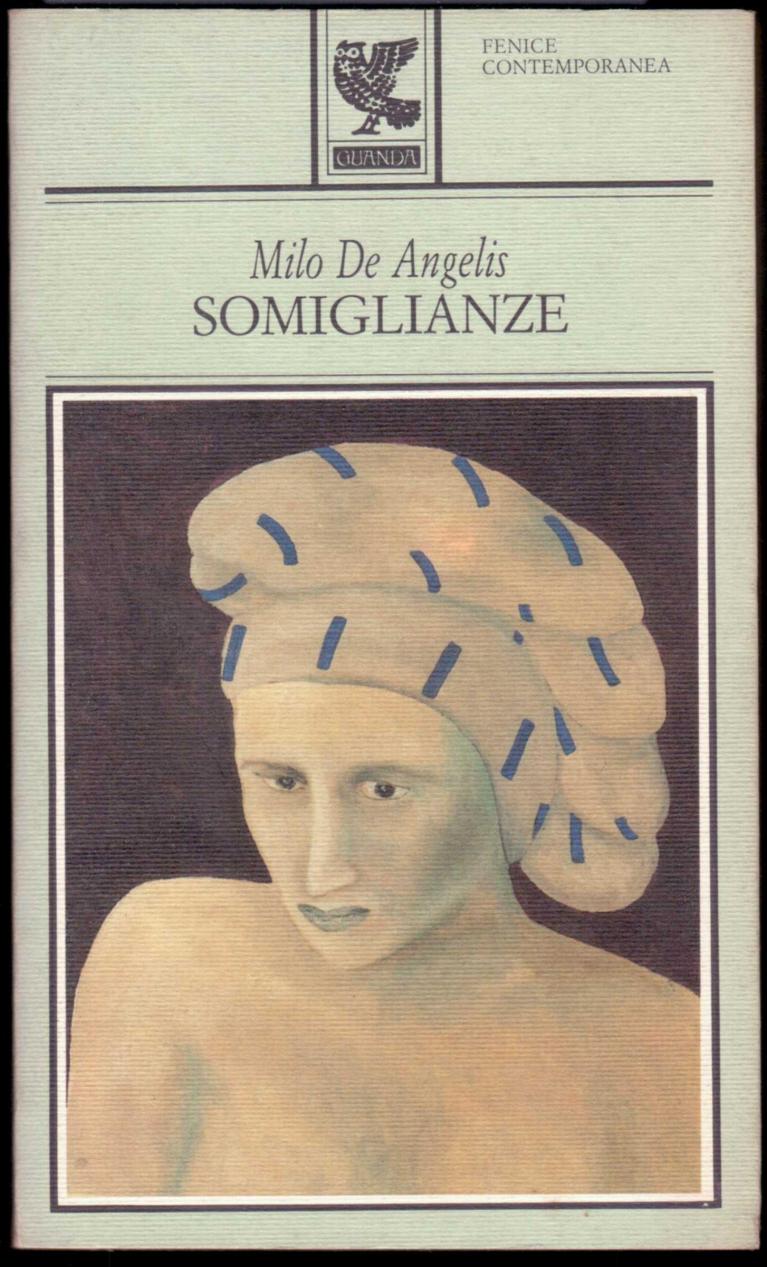
La linea intera per l’I Ching è quella della vita che giunge al suo naturale compimento, quella spezzata rappresenta la vita interrotta, e alle interruzioni volontarie, ai suicidi è dedicata Aurora con rasoio l’ultima sezione del libro. Suicidi per motivi sempre diversi, sempre oscuri, dei quali non conosceremo mai le vere ragioni, ammesso che ve ne siano. I suicidi chiudono il libro perché Linea intera, linea spezzata è fatto di incontri passati o recenti, o rinnovati dalla reminiscenza; è fatto di dialoghi che avvengono in una dimensione a tratti onirica, altre volte più tangibile, quasi che le parole uscite da bocche a noi sconosciute si possano afferrare, trattenere; è fatto di luoghi – ne viene fuori una Milano meravigliosa, quasi nascosta, perduta, salvata – di viaggi notturni, di tram chiamati per numero, dunque per nome, come se quei mezzi pubblici più che portarci da un quartiere all’altro ci tenessero per mano. Ci hanno da sempre tenuto per mano (non è così?). Una Milano che realizza ciò che De Angelis ci aveva annunciato in Biografia sommaria nel 1999: «Ora una città / ci aziona il respiro».
Milo racconta una storia che fugge, che fa avanti e indietro. Poesie fatte di memorie, di sguardi, di vapore, di corse fatte da ragazzi, di assenza, di oblio, di perdita, di ritrovamenti. Si contano legami dei tempi della scuola, delle squadre, di amicizie nate e talvolta smarrite. Volti cambiati dagli anni ma in fondo rimasti uguali, li vedi spuntare dagli stessi cappotti, confortarsi davanti al vecchio tavolo da biliardo di Via Caldamosto o con una palla da bowling tra le mani. Riaffiorare alla piscina Scarioni, sospesi tra il tuffo e la vasca. Donne e uomini che sono fantasmi perché capaci di comparire di soppiatto, come un fulmine, una nebbia. Presenze incontrate a Lampugnano, a una fermata del 14, trattenute per sempre in una stanza di un albergo a due stelle «in fondo a via Porpora, prima delle grandi pianure». Oppure incrociare sé stessi «verso le risaie della Barona», sostare nello specchio dove è rimasta la prima ragazza, là in un Autogrill.
«Arrestiamo, per un attimo, la corsa
ritmata di questa maratona
guardiamo il foglietto del calendario
con i gatti, in cucina. E poi ricordiamo
con precisione la scena. Erano tanti
i ragazzi giunti in casa con le loro mani
desiderose di festa, le tartine, gli amaretti.
Tu guardavi smarrito i ritratti alle pareti
che ti sussurrano non è difficile, non è
difficile non è difficile, basta uscire
sul balcone e fissare una macchina ferma,
fissarla a lungo, tracciare una linea
verticale tra te e lei, chiudere gli occhi.»
L’inatteso di Milo sta, per esempio, nel modo in cui questa memoria si manifesta. Nulla qui è semplice ricordo, ma è riportare noi stessi dove eravamo già stati, per suturare una ferita, ascoltare una frase che non avevamo fissato. Il poeta si orienta alla seconda persona, si osserva da fuori, questo ci consente di scorgere il passato nel presente (e viceversa) così che si annullino le distanze. L’effetto è portentoso e molto spesso commovente. Si ha il cuore grato leggendo quella sorta di sogno che conduce al piano sotterraneo di un garage, dove (lo) ci attende il fratello che gli parla di Liedholm; oppure quando Milo ritorna al Centro Schuster dove ritrova l’allenatore di un tempo, che non se ne è mai andato e ribadisce le regole fantastiche del gioco del calcio (cioè quelle del bene), in alcuni versi sublimi che dovremmo applicare a ogni cosa. Versi che dicono: «Sono soltanto tre, posso dirtelo, le regole del bene, / soltanto tre: portare il pallone nel soffio / della prima altalena, portare ogni dribbling in un balletto / astrologico, trovare in una stella / l'attimo giusto per il calcio di rigore».
Solitudine, silenzio, senso del tragico, stare fuori dallo schema di ogni narrazione, sono alcune delle cose che scorgiamo in questo attraversamento che viene dall’infanzia passa dall’adolescenza, scivola all’età adulta e chiude con la morte. Milo capace di svelare il Novecento portandoci di notte al Gasometro, di osservare la città dall’alto così profonda, notturna e schierata, e ricondurla tutta quanta a un uomo che al bar di sotto racconta a una ragazza vestita di rosso una storia sempre uguale. Alla risposta qui si preferisce il fremito dell’incognita, la notte più che il giorno. Nulla è più vitale del ricordo, niente è più tenace dello smarrimento, della perdita. Le presenze hanno nomi e cognomi, che denotano appartenenza, somiglianza. Poesie visionarie che portano davanti agli occhi del lettore con la stessa rilevanza il fuoriclasse Schiaffino, Gianni Hoffer, l’Esselunga e l’incontro con «Il poeta che fu bello e giovanissimo», i vecchi cinematografi, il compagno con «il viso prossimo alla morte» ritrovato al Parco delle Cave. Tutto è tenuto in unico slancio, come se ci trovassimo ad assistere a una partita mai vista, ma in attesa del ripetersi di quella rovesciata – l’incanto – accaduta una volta sola, quando avevamo ancora i calzoni corti e niente aveva importanza, e tutto poteva ancora accadere. La tribuna dove stiamo seduti non è altro che «il luogo sconosciuto dal quale la poesia ci parla».