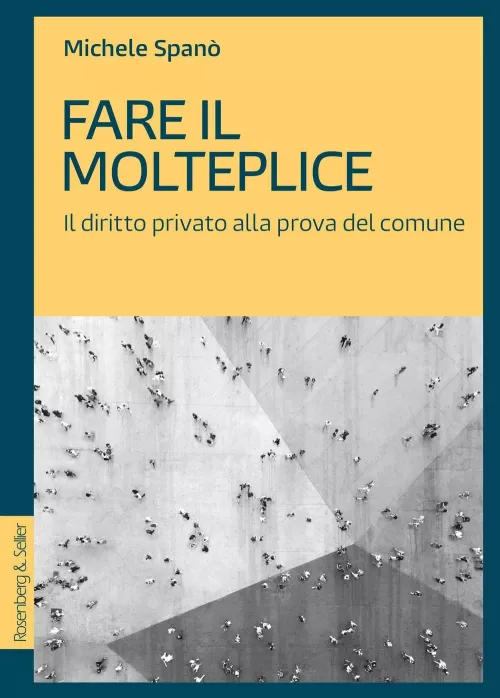Il rimosso della politica moderna / Privati di diritto
Nel micro-romanzo numero 60 di Centuria (Adelphi, 1995) Giorgio Manganelli compendia in una pagina e poche righe la vicenda plurisecolare dell’unico personaggio fantastico la cui esistenza nessuno di noi avrebbe l’ardimento di mettere in questione, pur sapendo, in fondo, che si tratta di una monumentale illusione collettiva: lo Stato. La storia è quella di un uomo “meticoloso ma un po’ astratto” che attende dall’Ufficio Esistenze il certificato che presti validità alla sua presenza in vita. L’arrivo della lettera che preannuncia di lì a breve la felice conclusione della procedura chiama l’uomo a esercizi di circospetta sublimazione dell’ansia che gli deriva dal trovarsi a metà strada tra inesistenza de facto ed esistenza de iure: passeggiate, lunghi sonni, qualche viaggio.
L’ottimismo del cittadino esemplare, che ha tutte le carte in regola per esistere, lenisce per un po’ l’istintivo senso d’inquietudine di chi sa che la sua vita dipende da un tratto di penna su carta intestata. Ma come in ogni storia che faccia suo il principio di realtà, qualcosa va storto. Con una seconda lettera, l’Ufficio Esistenze comunica che non s’erano avveduti di una “omonimia diacronica” (p. 136): un uomo con eguali nome e cognome sarebbe nato di lì a sei secoli. Tutto da rifare, si diceva con la solennità tipica dell’atto pubblico, che s’accompagnava all’imperativo tacito di aderire al comandamento laico della fiducia nella burocrazia. La storia, ahimè, non ha lieto fine, e l’uomo non ha inizio. Tutto è risucchiato nel vortice di un refuso: sul verso di una quarta e conclusiva lettera, il nome dell’uomo presenta una “lieve inesattezza, e in quello stesso istante cessò sia di preesistere che di non esistere” (p. 136).
Questa squisita summa dei princìpi di diritto pubblico svela meglio dei molti manuali e vademecum degni di ossequiosa reverenza il segreto più riposto delle istituzioni pubbliche: il potere senza eguali di conferire esistenza a cose e persone in forza di un atto di riconoscimento. Esperienza di cui nelle cronache di oggi si va parlando spesso in riferimento, ad esempio, a famiglie omogenitoriali che rivendicano diritti ancora di là a venire, lavoratrici e lavoratori non riconosciute/i dalle sigle sindacali che reclamano tutele, gruppi di consumatori che si assemblano per ottenere riparazioni facendo un uso selettivo di pezzi di diritto sovranazionale. Le lotte di soggetti che il diritto pubblico non vede – ossia, non ha categorie giuridiche per descrivere e regolare – sono appunto istanze di visibilità, strategie di avanzamento surrettizio (spesso per tramite di Corti particolarmente avvezze alla creazione legislativa – interdetto atavico della tradizione di civil law) volte a ottenere una qualche posizione nella panoplia di figure cui il diritto pubblico garantisce un attestato di esistenza.
D’altronde, la forma politica per eccellenza che conosciamo col nome di Stato – e che, secondo alcuni storici delle istituzioni, è poco più che un gigante imberbe, con i suoi circa due secoli d’età – ha preteso avocare a sé un potere che nessun essere umano, sino almeno a prima della Rivoluzione francese, avrebbe pensato di poter assegnare a un organismo pubblico, finanche crismato da investitura celeste: determinare la griglia di intellegibilità per cui un individuo, un gruppo di lavoratori, un orientamento sessuale, un genere, possa dirsi dotato di esistenza pubblica.
È quindi in fondo una proposta di auto-etnografia quella che fa Michele Spanò nel suo Fare il molteplice. Il diritto privato alla prova del comune (Rosenberg & Sellier, 2022). E il tempismo è dei migliori: nella recente furia “antimoderna” che pretende di disfare tutte le diadi che hanno innervato il pensiero occidentale degli ultimi secoli (natura vs. società, naturale vs. artificiale, cosa vs. persona e così via), stupisce ci si sia lasciati sfuggire la divisione che più di ogni altra ha modellato il nostro modo di vivere in società: pubblico vs. privato.
La tesi di Spanò chiama a un esperimento mentale che tocca le vertigini di ben più noti argomenti, come quelli di Hobbes, Locke e Rousseau, che ci invitano a figurarci di vivere in una società in cui non c’è ombra di politica: uno stato di natura in cui il potere pubblico è invenzione futuribile e tocca arrangiarsi coi mezzi della sola ragione. E quegli argomenti, alle soglie del moderno, erano tutti volti a far credere che no, non può né potrà mai esistere una società senza un potere pubblico che la istituisca: la costituzione di un potere pubblico è l’unico esito razionale in una condizione in cui gli esseri umani non possono contare su economato, catasto e ufficio dell’anagrafe. Ma, per l’appunto, il non detto del pensiero politico moderno è dar per vera l’ipotesi che voleva dimostrare, cioè che la socialità umana, senza poteri pubblici, è pura ostilità o, al meglio, cumulo di accordi precari rilasciati a umorali contingenze.
Spanò è radicalmente antimoderno proprio nel senso che disfa l’interdetto di una società senza Stato e rintraccia il rimosso di esperienze altre rispetto alla nostra idea consolidatissima di politica. Il libro va recuperando le prove di un inganno tanto patente – quello per cui appunto non esiste politica senza diritto pubblico – attraverso una contro-genealogia del diritto privato. E la strada a me pare quella giusta, se è vero che oggi la sola menzione del termine “privato” genera in noi un’istintiva repulsione, come data da un obbligo morale a biasimare chi si procura il patrimonio a danno del bene pubblico – incarnazione minore di papà Grandet, che traduce i drammi della storia in monete di piccolo taglio e si rintana curvo tra le pareti umide di casa chiudendosi fuori dall’orizzonte millenarista delle imprese comuni. Come per una divisione originaria della semantica morale, “privato” viene a indicare la sfera angusta degli affarucci di casa e “pubblico” l’afflato eroico della rinuncia a sé in nome di un progetto collettivo.

Insomma, quando c’è di mezzo il privato, il timore è sempre quello di rimanerci fregati, mentre il richiamo al pubblico comanda l’affetto rassicurante che l’autobus arriverà: in ritardo, probabilmente, ma comunque arriverà. Fare il molteplice dice che questa ripartizione degli oneri morali a tutto svantaggio del privato è stata funzionale alla costruzione di un’idea di pubblico in cui la politica, quella che appunto ha a che fare con i destini collettivi, s’incista proprio sulla reclusione del privato nella sfera residuale del patrimonio e dei beni individuali. Ma queste immagini sfocate, argomenta Spanò, non sono che i negativi della nascita del diritto pubblico, e se li si portasse nella camera oscura della storia delle istituzioni, si vedrebbe che il diritto privato in realtà non figura mai.
Di quest’orrore morale e civile per il privato ci si libera – questa l’ipotesi del libro – solo con la messa a nudo di una dicotomia che non ha nulla di naturale, vale a dire pubblico vs. privato, per svelare il trucco della creazione pretestuosa di un diritto privato come esclusivo campo dell’azione interessata di un “soggetto sovrano […] anamorfosi metafisica della sovranità politica”. Solo a partire da una controstoria del diritto privato si può capire come “l’infinita sequela di opposizioni polari”, quali individuo privato e cittadino, interesse soggettivo e bene comune, autonomia privata e sovranità pubblica, formino una “discorde unità” che è l’“effetto di questa profonda, insegregabile, unità formale” (p. 12) per cui il pubblico proietta sul privato tutto ciò che il pubblico non vuol essere. Insomma, Spanò denuncia un abuso di autorialità: il diritto privato che noi conosciamo non è che un McGuffin! Un colossale distrattore, che da almeno due secoli è funzionale alla sacralizzazione del pubblico come luogo unico e inaggirabile dell’impegno politico.
Occorre allora ristabilire equità tra le parti in causa e sostenere le ragioni di un altro diritto privato, meglio, un diritto dei privati, in cui “l’autonomia – compresa come messa in forma di interesse e bisogno – è indice del diritto. E non c’è bisogno e interesse che non sia già tra due e il cui tenore, perciò, sia, da parte a parte, politico” (p. 71). Fuori dall’aura sulfurea dei linguaggi tecnici (benché molto felici), l’intuizione di Spanò può rendersi in modo semplice – forse troppo – con il richiamo a un’esperienza tanto comune quanto universale: quando due (o più) persone si danno ritmi di vita, si scambiano affetti, creano aspettative reciproche, organizzano eventi, arredano case, non occorre il riconoscimento del diritto pubblico per certificare l’esistenza di un legame affettivo che ha già inscritto in sé un ordine – ordine che alcuni insigni giuristi del primo Novecento avrebbero senza remora definito “giuridico”, quand’anche non riconosciuto dal diritto statale. Quelle due (o più) persone formano una relazione o una famiglia o qualsiasi termine esse utilizzino per definirsi. Il diritto pubblico non crea quelle forme, ma attribuisce, o meglio, sceglie di attribuire loro certi diritti di fare e non fare cose e certe responsabilità in certe situazioni. Insomma, l’istituzione pubblica non crea, ma distribuisce in forza di una (forse inevitabile) discrezione nel determinare a quali forme esistenti vadano assegnate quali posizioni entro il diritto pubblico.
Ed è per questo che ho definito il libro di Spanò come una proposta di auto-etnografia: basta guardare ad esempi di vita minima per constatare di quante forme organizzative essa sia capace, per avvedersi della pluralità indomita che moltiplica le possibilità d’esistenza. Quelle forme di diritto dei privati sono intimamente politiche, nel senso che creano e sedimentano vite possibili. E sono questi espedienti di auto-costruzione dei soggetti privati che stanno al cuore dell’esperienza sociale dell’essere umano, ben prima che il potere pubblico ne riconosca l’esistenza de iure.
Ma c’è di più. Scrive Spanò che oggi il privato – così inteso – “squisita forma di bricolage” è “la tecnica eminente della cooperazione” (p. 71). Si pensi, come si diceva in apertura, a tutte quelle forme di mobilitazione di soggetti privati, non rappresentati da partiti o sindacati, che costituiscono un collettivo allorché “socializzano” una causa comune e si formano come unità – sempre transitoria – per reclamare un bene: la Luta pela Vida degli indigeni brasiliani in difesa dei loro diritti costituzionali è al contempo un impegno concretissimo a difesa della biodiversità, in un intreccio di privato e pubblico che la bipartizione moderna non saprebbe come ordinare. È lì che il bisogno dei privati dà corpo a un interesse che ha la prepotenza politica di sfidare le istituzioni pubbliche. Insomma, negare la politicità intrinseca della madre lesbica che vuol adottare la figlia della compagna, il diritto del freelance alle ferie estive o la richiesta di una popolazione indigena di fermare l’abbattimento di un albero sacro sarebbe possibile solo a degli abilissimi mentitori, come Hobbes o Rousseau, che ben sapevano che la politica è altro dal pubblico, ma che, per fini al tempo tutt’altro che biasimevoli, avevano bisogno di consacrarsi a un mitologema.
E se Rodolfo Wilcock nel suo formidabile prontuario di scrittura generativa, non creativa, aveva l’accortezza di consigliare a chi scrive di “evitare se possibile che un personaggio si trovi in due posti diversi allo stesso tempo, oppure che un morto riappaia senza offrire le dovute spiegazioni. Vietato modificare il passato” (Il reato di scrivere, Adelphi 2009, p. 35), Spanò rompe ogni protocollo: richiama in vita esperienze giudicate premoderne eppure modernissime di fare politica senza il pubblico, modifica il passato individuandone il carattere di farsa, rimette al mondo il diritto dei privati (nato già sempre prima del diritto pubblico) senza offrire giustificazioni di sorta. Fare il molteplice mostra la praticabilità di una esperienza concreta. Una boccata d’ossigeno per chi, come lo scrivente, ha a lungo atteso che l’istituzione pubblica par excellence decretasse che i coniugi possono liberamente determinare quale cognome debba assegnarsi alla loro prole, nonché in quale ordine i due cognomi debbano essere disposti.