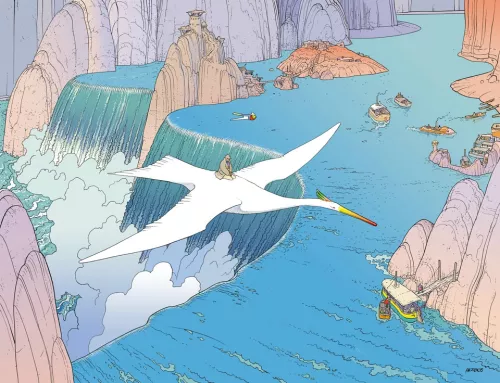A che gioco stiamo giocando? / Ludoteca, di Stefano Bartezzaghi
A lungo, con alquanto cipiglio, s’è parlato di regole del gioco: abile espressione per insistere, più che sul gioco in sé, sulle sue regole costitutive – o, per dirla altrimenti, più sul game che sul play. Inflessibili tutori dell’ordine e sedicenti tali, così come sussiegosi araldi di una morale spacciata per comune, non hanno cessato di invocare la necessità di prescrizioni chiare e distinte, adducendo l’argomento secondo cui più un campo d’azione (economica, finanziaria, commerciale, politica, amministrativa…) è normato, più si delimita lo spazio dei cialtroni e dei delinquenti, dei ladri e di chi ne fa le veci. Una specie di illuminismo legalista tanto speranzoso quanto dubbio, ammettiamolo, che ha fatto presto a mostrare la debolezza dei propri muscoli. È venuto infatti fuori, e c’era da aspettarselo, che invocare le regole è il miglior modo per trasgredirle: più si accumulano lacci e lacciuoli, in qualsivoglia terreno umano e sociale, più riesce a vincere chi se ne fa beffe.
Nascono così sospetti d’ogni sorta, ma è ormai troppo tardi: i giochi sono già fatti; se le regole traballano, eccone di nuove, ancora più determinate e sicuramente più robuste, ed ecco emergere il furbone che sa ancor meglio aggirarle, anzi usarle per fregare di brutto chi, fra l’inconsapevole e il rassegnato, non le controlla fino in fondo (per ridere: si pensi al perdente del Rischiatutto nel Fazio del sabato sera). È il trionfo iperannunciato della burocrazia come fine ben più che come mezzo. A me viene da indicare, idiosincraticamente, i concorsi universitari. Ma pensiamo piuttosto all’Europa, macchina mostruosa che per favorire le lobbies di turno ormai legifera anche sul colore dei capelli delle hostess nei voli low cost.
C’è, per fortuna, chi ha ben chiaro tutto questo. Ed è, manco a dirlo, chi di giochi se se intende con estrema serietà: perché li conosce, li inventa, ci rilette su, e soprattutto ci sa giocare.
Ne La ludoteca di Babele (Utet, pp. 210, € 14) Stefano Bartezzaghi avanza allora una proposta molto precisa: lasciamo stare una volta tanto le regole del gioco e prestiamo semmai attenzione ai modi di giocarlo; non occupiamoci dell’astratta sintassi ludica, per dirla con la linguistica, ma della concreta pragmatica del giocare, di quel che accade quando il giocatore, introiettate le regole, sa come metterle in atto, come gestirle, con adeguata furbizia, senso del contesto, tanta leggerezza e costante considerazione di tutti quegli altri che, in un modo come nell’altro, stanno giocando con lui. Se il gioco – secondo i suoi grandi teorici come Huizinga e Callois, Freud e Wittgenstein, Blanchot e Derrida (ma anche Saussure, Dossena, Eco, Greimas…) – è il regno della simulazione e della casualità, del divertimento scanzonato e delle costrizioni autoattribuite, non per questo esso deve comportare, come troppo spesso si è ritenuto, una totale sospensione del senso della realtà. Al contrario, giocare è sempre, sottolinea Bartezzaghi, tenere sotto controllo il reale quotidiano, reinterpretarlo, dandogli nuovi significati e nuovi valori. A patto di tener presente, appunto, la sua dimensione fattiva, processuale, fortemente passionale proprio perché esasperatamente rigorosa: ossia quel che qualcuno ha chiamato, appunto, il play sbarazzino di contro al noiosissimo game.

Così facendo, il senso del gioco assume tutt’altre fattezze, e permette di comprendere molto meglio una serie di fenomeni della società e della cultura contemporanee. Nelle quali, per esempio, la separazione fra serio e faceto, logica e fantasia, funzionalità e divertimento è venuta definitivamente meno. Le più sofisticate tecnologie smart, per esempio, non sono più al servizio delle magnifiche e progressive sorti dell’umanità ma di una specie di ludicità diffusa che permea, confondendoli, lavoro e svago. Telefoni, computer, tablet e quant’altro sono strumenti grazie ai quali la nozione di utilità – individuale o collettiva – diventa sempre più flebile, a tutto vantaggio di una specie di giocosità permanente che intreccia economia e desiderio, profitto e spreco, individualismo e socialità. Facebook diviene in tal modo il regime politico, surrettizio e inesorabile, del tempo presente.
La trasformazione in atto non è da poco: “nella Babilonia di Jorge Luis Borges le regole delle interazioni sociali – codici, leggi, sanzioni, punizioni, potere politico, legislativo, giudiziario, amministrativo – erano delegate alla riffa. Quella era una antiutopia letteraria. La nostra realtà ora assomiglia più a una ludoteca di Babele, in cui la cultura di massa ha instaurato a tutti i livelli un regime di semiserio che impone di riformulare non solo i rapporti fra gioco e realtà ma le loro stesse definizioni”.
Così Bartezzaghi riprende, modificandone le conseguenze teoriche, un celebre esempio di Huizinga. Un padre s’avvicina al figlio di quattro anni intento a giocare al trenino, seduto sulla prima di una fila di sedie. Va per dargli un bacio, ma il piccolo replica: “Papà, se baci la locomotiva gli altri vagoni non crederanno sia una cosa seria”. E s’allontana sconfortato. Cos’altro avrebbe potuto fare? Continuare nella simulazione, interromperla, rilanciarla, riderci su? In ogni caso, il danno è fatto: a quel genio del figlioletto che sa assai bene oscillare fra realtà e fantasia, ha tolto quella che del gioco è forse la caratteristica fondamentale: la leggerezza. Come poter pensare di baciare una locomotiva?
Il gesto d’affetto si rivela un’intrusione normalizzante, un’ottusa volontà di ritorno al reale duro e puro, cupo e triste. Quel che la storiella insegna, per Bartezzaghi, è che, appunto, il gioco non s’oppone alla realtà ma la integra al suo interno; così come vale il contrario: una realtà ben fatta, una realtà come si deve, non è impermeabile al gioco ma usa le medesime regole, gli stessi principi, e soprattutto le stesse conseguenze. Non a caso, a mediare fra la seriosità del mondo e le facezie del gioco c’è un’attività che è presente in entrambi: quella narrativa. Raccontare una storia non è molto diverso che giocare una bella partita o andare ogni giorno al lavoro: basta saper gestire similitudini e differenze.
Insomma, nella sua essenza il gioco è un ‘campo di tensioni’, una continua oscillazione tra elementi opposti come regolazione e libertà, dovere e potere, necessità e caso, gravità e leggerezza, ma anche, più a monte, tra oscillazione e fermezza. Così le varie tipologie di giochi (per esempio: azzardo, agonismo, simulazione, vertigine) non riescono quasi mai a esaurire l’ampiezza e la complessità dell’attività ludica propria all’animale uomo: incaricata spesso, non a caso, di farsi portatrice di cose come l’umanità, la socialità, la cultura.
Sbaglierebbe pertanto chi pensa che il giocatore, men che mai il ludologo, sia un essere sbarazzino, frivolo, disincantato e disimpegnato. Lo sguardo sull’attualità, che apre e chiude il libro di Bartezzaghi, ne è puntuale testimonianza: non solo oggi il gioco tradizionale si scioglie nel ludico generalizzato presente in ogni nostra attività, ma sembra – ahinoi – aver a che fare con pratiche tutt’altro che spassose: sappiamo che i terroristi sono abilissimi giocatori di videogames. Non è retorica, in questo quadro, la domanda del sottotitolo: a che gioco stiamo giocando?