Tecnologia, saperi, comunità / Il rimedio
Quando si dice, come sosteneva con passione Luigi Pagliarani, che il contrario dell’amore non è l’odio, ma l’indifferenza, si descrive con una certa precisione quello che stiamo vivendo a diversi livelli della nostra esperienza, in questi anni. Non è che ci manchi l’odio, ma perlomeno implica una relazione di negazione dell’altro. Non è un granché, ma istituisce una relazione. Di peggio, forse, c’è quell’insieme di situazioni in cui la presenza dell’altro non fa alcuna differenza. Che ci sia o meno non è cosa che ci raggiunga o ci solleciti in qualche modo. Non c’è mediazione tra noi e l’altro e siamo ridotti alla stregua di monadi, in un’anomia sociale particolarmente diffusa. L'indifferenza può essere considerata come una sospensione eccessiva della nostra risonanza incarnata con gli altri e una neutralizzazione della nostra modulazione intenzionale. Utilizzando le categorie esplicative di particolare efficacia messe a punto da Vittorio Gallese, ci troviamo di fronte a una fenomenologia che per certi aspetti dovrebbe essere impossibile, eppure si presenta così ampiamente manifesta. Le ragioni dell’impossibilità dovrebbero risiedere nel fatto che noi siamo esseri intersoggettivi, connessi gli uni agli altri da processi empatici che rendono paradossale concepire la singolarità senza la noità, un io senza un noi. Eppure, l'indifferenza e la crisi dei processi di mediazione sono sotto gli occhi di tutti. Quella crisi si porta con sé un deficit di particolare incidenza della nostra disposizione all’approssimazione. Approssimarsi, che vuol dire contemporaneamente avvicinarsi e smussare le differenze individuando spazi di riconoscimento condiviso reciproco è, a pensarci bene, una delle basi essenziali della nostra socialità umana. Si tratta di un processo che richiede però una disposizione alla mediazione. Proprio quella disposizione mette oggi in crisi le forme tradizionali della socialità nel momento in cui è rarefatta, compromessa, alienata dalla crisi del legame sociale.
La crisi del legame sociale e quella delle istanze intermedie sono due facce della stessa medaglia, differenziate da una questione di scala. La singolarità e la solitudine sono divenuti due tratti caratterizzanti della società contabile o automatica, come la definisce Bernard Stiegler. A farci difetto è la mediazione, ovvero quel margine tra individui che è il noi. Luogo simbolico e reale dove si produce la socialità, con tutti i suoi risvolti di solidarietà, di cooperazione, di reciprocità, di conflitto tra differenze di punti di vista, di interessi, di valori, il margine è all’origine del bricolage di ogni convivenza possibile. Proprio quella dimensione del nostro vivere, tutt’altro che residuale come la parola margine sembrerebbe indicare, si è come prosciugata, o è stata saturata, lasciando spesso il posto al deserto dell’indifferenza e della solitudine. Una situazione di transizione tra un mondo che non c’è più e uno che stenta a nascere produce intanto un’atomizzazione e un’anomia che riguarda gli ambiti principali della nostra vita. Una varietà di aggregati più che di gruppi o di società compone il paesaggio contemporaneo, con poche differenze tra centri e periferie. I tentativi di elaborazione di un passaggio d’epoca così profondo sono stati interrotti dalla pandemia in corso, che però, a sapersene accorgere, potrebbe divenire un’occasione unica di apprendimento e cambiamento. Soprattutto se si considera che la situazione pandemica con tutte le sue drammatiche conseguenze è un esito e non una causa della crisi di vivibilità che sperimentiamo da decenni. L’impatto di questa situazione lascia fuori pochi aspetti della nostra esperienza e il merito dello sforzo collettaneo di molti autori che hanno contribuito a realizzare il libro curato da Francesco De Biase, Rimediare. Ri-mediare. Saperi, tecnologie, culture, comunità, persone (Franco Angeli, 2020), consiste prima di tutto nel tentare un coraggioso esame di realtà in molti degli ambiti critici delle nostre vite, oggi.
Il rimedio, come esito di processi di mediazione, o di reiterati tentativi di ri-mediare, evoca di per sé la ricerca di esiti sub-ottimali. Allo stesso tempo conferma che quegli esiti sub-ottimali sono di fatto e ad ogni evidenza gli unici esiti attendibili di ogni confronto e di ogni cambiamento particolarmente critici. La polisemia della parola contiene la molteplicità dei sensi delle azioni.
Per mediare di nuovo, per continuare a mediare, è in primo luogo necessario approssimarsi, ridurre le distanze.
Covid ha evidenziato, tra l’altro, sia la crisi del gesto di avvicinarsi che la caduta della disposizione a cercare di ridurre le distanze e le differenze per accordarsi, quella posizione che si orienta a riconoscere almeno una buona ragione o una ragione condivisibile nelle posizioni dell'altro. La pandemia è, infatti, allo stesso tempo un vincolo e un evidenziatore. Da un lato interviene pesantemente nella prossemica e nell’intersoggettività vincolando tutte le pratiche di vicinanza e di approssimazione e trasformandoci in singolarità impaurite e in posizione difensiva. Dall'altro evidenzia fenomeni che sperimentavamo da tempo e che consideravamo tutto sommato con scarsa attenzione, che già contenevano tutti i segni dell'indifferenza e della crisi di mediazione. Il libro curato da De Biase si interroga, appunto, sulla distanza esplorandone la presenza ai molteplici livelli della nostra esperienza di vita. C'è distanza tra classe politica e cittadini, tra élite e popolo, tra esperti e popolazione, tra insegnanti e allievi, tra medici e pazienti, unitamente a quella particolare forma di distanza che è la disuguaglianza sociale, la cui forbice tende ad allargarsi così tanto da somigliare sempre più a una retta.
Il senso di comunità, in crisi da tempo, oggi oscilla tra un orientamento alla chiusura e all'esclusione e una scarsa o nulla capacità di contenimento delle emozioni, dei sentimenti e dei progetti dei singoli. Si auspica da più parti uno sforzo di visione e di pratica che siano in grado di evitare e superare la parcellizzazione a favore di integrazioni e connessioni. In questo libro un ampio gruppo di esperti in diversi ambiti e discipline si occupa di fenomeni macro e di fenomeni micro in cui sono ravvisati gli effetti della crisi di mediazione e la necessità di porvi rimedio. Sono in discussione: il modello di sviluppo occidentale con tutte le sue ingiustizie e distorsioni; l' impoverimento continuo di alcune fasce di popolazione; l' accrescimento delle ricchezze di ristrette élite; i rischi di tutti i processi di disintermediazione in ambito economico, politico, culturale e informativo; la cancellazione del welfare; la riduzione del sostegno alla ricerca, all'educazione e alla formazione; la necessità di coniugare attentamente lo sviluppo delle tecnologie con il bisogno di contatto, socialità e comunità; la continua messa in crisi degli esperti e il non riconoscimento delle competenze e dei saperi; le derive del populismo e le luci e le ombre di molte pratiche di engagement; le forti accentuazioni dell' individualismo e delle differenze contro il senso di comunità e di appartenenza ; la distruzione dell'ambiente. Come si può constatare, l'ampiezza delle materie, fa del libro un’importante occasione di riflessione sul presente e allo stesso tempo un'opportunità per riconoscere e discutere ipotesi e opportunità di intervento, verso un presente e un futuro basati sulla vivibilità sostenibile.
Per affrontare la ricchezza e l’articolazione di questo libro vi sono molte possibilità. Una è quella di prendere un punto di vista e un contributo che il libro propone e farne un punto di partenza per crearsi un proprio sentiero tra le parti. Seguendo un criterio di affinità elettiva è, forse, il concetto di “incivilimento smisurato” che Francesco Remotti pone a titolo del suo saggio che può aiutare a entrare nel valore del libro. Come sempre è la narrazione di storie in prima persona che facilita gli accessi alla conoscenza e alla comprensione. Remotti mette a confronto, all’inizio del proprio contributo, la capacità di un ragazzino del Bukenye, nella Repubblica Democratica del Congo, di accendere il fuoco con dei legnetti, con la propria incapacità di farlo in mancanza di fiammiferi o accendino. Connettendo quella sua esperienza diretta all’analisi esposta da Max Weber in una conferenza del 1917, Remotti giunge a porre la questione del rapporto conoscitivo che le persone intrattengono con le proprie condizioni di vita. Il punto di partenza di Max Weber è la constatazione del divario esistente tra il sapere scientifico sviluppato in Occidente e il sapere scientifico presente tra gli indiani e gli ottentotti: due realtà imparagonabili, essendo evidente la superiorità delle società occidentali in quel campo.
Nella domanda che Remotti pone: “…qual è il grado di conoscenza che ciascuno di noi sviluppa o detiene in rapporto alle proprie condizioni di vita?” [p. 272]. Il gap tra il rapporto che abbiamo con le nostre condizioni di vita e il progresso scientifico ha segnato la vita di noi occidentali e poi, mano a mano che un certo modello di sviluppo è divenuto pervasivo a livello planetario, la vita degli umani sulla Terra. Remotti allora si chiede: “Quanti e quali sono i mezzi di cui facciamo continuamente uso nell’arco della giornata e di cui però non conosciamo per nulla i modi di costruzione e di funzionamento?” La sproporzione tra il progresso scientifico e culturale che contraddistingue la nostra civiltà, e lo scarso sapere di cui ciascuno di noi dà prova in relazione alle condizioni culturali e tecnologiche in cui vive configura un livello di alienazione che finisce per coinvolgere le stesse relazioni interpersonali e il legame sociale.
Anneghiamo nel mare della nostra solitudine, in questo tempo di connessioni illimitate e di relazioni inverse, che tornano come un boomerang verso la nostra singolarità.
Mai come in questo tempo torna efficace la considerazione di Clifford Geertz: “l’uomo è un animale sospeso tra ragnatele di significati che egli stesso ha tessuto”. E non ha neppure senso domandarsi chi sia il ragno e chi sia la preda. Di certo vi è la rete, di cui siamo allo stesso tempo, almeno per ora, vittime e tessitori.
Le generazioni più giovani, che nella rete sono nati, sono forse i soggetti analizzatori più evidenti e i più assoggettati alla condizione esistenziale che stiamo vivendo, come documenta con chiarezza Laura Pigozzi nel libro Adolescenza zero. Hikikomori, cutters, ADHD e la crescita negata, pubblicato da nottetempo, Milano, nel 2019. Esemplificando sui giovani che vivono completamente autoreclusi rispetto ad ogni forma di relazione di esperienza esterna, gli hikikomori, appunto, l'autrice dichiara che un lato dell'incomprensibilità del fenomeno è il suo presentarsi come una sofferenza apparentemente senza un oggetto esterno: droga, alcol, cibo, sono gli oggetti di alcune patologie giovanili. Invece qui l'oggetto è il soggetto stesso, il suo stesso corpo. “È il proprio corpo che viene consunto, murato vivo, reso morto al legame”. Il gioco tra ripiegamento e improvvisa apertura, tra chiusura in se stessi e esplosioni di vita che caratterizza da sempre l'età adolescenziale, sembra un gioco non solo in crisi, ma nella maggior parte dei casi semplicemente impossibile. Nelle adolescenze che si incrociano nel libro di Laura Pigozzi, ad essere azzerato sembra l’etimo stesso della parola adolescenza.
Il verbo latino adolesco significa, infatti, crescere, prendere vigore, ma in un numero non secondario di giovani risulta bloccato proprio lo sforzo di crescere che dovrebbe essere tipico dell’adolescente. La domanda diventa allora: perché, per molti, l'adolescenza non ha più il sapore di un risveglio a una nuova vita? Quand'è che questa seconda nascita non riesce? Il problema, come mostra con evidenza l'autrice, non si ferma ai fenomeni limite come quello degli hikikomori o delle altre manifestazioni ampiamente documentate nel libro, che producono surrogati umani, accanimenti sullo stesso corpo attraverso la lunga teoria di tatuaggi, molteplici forme di devianza e una chiara e pervasiva crisi del desiderio sessuale, ma lo vediamo declinato anche nei fenomeni quotidiani, apparentemente bonari, che invece mostrano una certa psicotizzazione della scena della prima infanzia. Si consideri ad esempio l'infinita fusione col bambino connessa alla crisi nella gestione dei sistemi emozionali nelle relazioni primarie, con un'enfasi eccessiva sulla fase orale del mordere-succhiare-divorare, tale per cui è come se non si verificasse mai lo sviluppo di una capacità organizzatrice di un’individuazione che non può che rimanere frammentata. Ne deriva uno scacco della capacità del bambino di individuarsi come essere separato da una madre che fatica a iniziare un movimento di separazione da lui.
Se a questo si aggiunge la fragilità del lato paterno della costellazione affettiva, indebolito da una crisi dell'autorità necessaria e retto dall’imperativo a godere di ogni merce, merce-bambino compresa, otteniamo una chiarificazione del fallimento dei processi educativi e un procrastinarsi della funzione materna in cui il legame invece di allentarsi si stringe. Siamo, peraltro, di fronte a una questione che viene evitata e che non piace a nessuno affrontare. Per non parlare dell'abisso degli schermi in cui l'adolescente si perde con un’alimentazione, da parte del potere ipnotico di internet, che finisce per alimentare il narcisismo e che di fronte allo schermo vede confermata una declinazione del gorgo diadico come variante del plusmaterno, a cui corrisponde una crisi della funzione paterna. In tutto questo processo la disobbedienza e ogni forma di discontinuità vengono vissute come implasmabilità e come tali vengono trattate. Eppure, a quella disobbedienza e a quella discontinuità Laura Pigozzi consegna ogni possibilità di cambiamento, auspicando che alla fine la creatività e la genesi di un cambiamento possibile passino attraverso la rete.
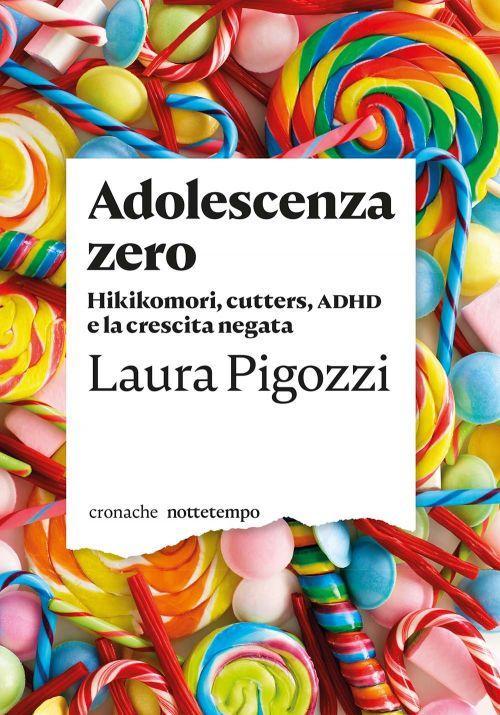
Si avverte, tornando al libro curato da de Biase e al contributo di Remotti, un bisogno di riprendere la misura. Ricorrendo alle straordinarie intuizioni di Giacomo Leopardi, è lo stesso Remotti che parla di cultura “smisurata” dalla quale discende un gap fra tecnica, valori e capacità umane, che oggi con molte probabilità sta alla base della crisi di legame che caratterizza così ampiamente e pervasivamente le nostre esperienze di vita. Francesco Remotti allora fa riferimento a una caratteristica specie specifica di noi umani che può contenere le possibilità di uscita della crisi contemporanea. Quella capacità è la capacità di trascendimento. Scrive Remotti: “Il presupposto è che una cultura non è da interpretare soltanto come un patrimonio acquisito, da conservare e abbellire: è anche un vedere oltre e un fare; è un prevedere e un provvedere. È in questa zona rischiosa del trascendimento, dell'apertura verso il futuro, che si collocano i micro-esperti più significativi e produttivi: siano essi esperti del vedere e della teoria o siano essi resi esperti del fare e dell’agire” [p. 282].
Se quello di Remotti si propone come uno dei più importanti e profondi rimedi, tutti i saggi del libro mirano a questa prospettiva, da un lato analizzando una questione, e dall’altra cercando vie d’uscita, in ogni caso ponendo di fronte a una terra di transizione in cui un mondo che finisce mostra di non lasciare facilmente il posto a uno che dovrebbe emergere, ma stenta a prendere forma. È il caso, ad esempio dell’ambito economico, affrontato da Roberto Burlano, evidenziando l’evidenza scientifica consolidata dell’insostenibilità del modello di sviluppo dominante, sul piano non solo ambientale, ma anche su quello economico e sociale. Il gap, in questo caso non riguarda solo il sistema delle resistenze che la nostra specie oppone al cambiamento di prospettiva, ma vi è anche il problema dell’inadeguatezza delle teorie economiche dominanti e della crisi paradigmatica che le caratterizza. Le molte dimensioni dell’attuale insostenibilità si combinano con la nostra indisponibilità all’apprendimento anche di fronte a quello che viene definito il maggior fallimento del mercato della storia dell’umanità, cioè il cambiamento climatico. La domanda: prima la democrazia o gli affari, si pone in tutta la sua portata drammatica. Tocca a Carlo Petrini riportare le criticità del modello di sviluppo dominante al tema dell’alimentazione e del cibo, con la proposta di dare spazio agli umili del mondo, e soprattutto all’umiltà come atteggiamento, ricordando che la parola umile deriva da humus, e indica coloro che sono vicini alla terra.
L’accoglienza di una posizione e di atteggiamenti più consoni alla condizione umana attuale può avvalersi anche della capacità di mediazione della psicoanalisi, delle cui potenzialità di mediazione e di rimedio si occupa Saura Fornero. Combinando il contributo delle trasformazioni che possono essere perseguite attraverso l’analisi delle proprie resistenze e delle proprie potenzialità, con l’esigenza di nuove forme di cura e di welfare, affrontate nel capitolo che si occupa di medicina, si definisce un’altra importante area della mediazione per rimediare, affermando che ri-mediare è il paradigma del futuro.
Una sezione del libro è dedicata al ruolo di mediazione e ri-mediazione che possono avere le tecnologie, con particolare riferimento alle piattaforme generative e ai modelli emergenti per la distribuzione culturale. L’innovazione sociale può derivare dai social network che possono promuovere la ricerca di un ruolo attivo nelle comunità, favorendo maggiori opportunità di scelta e di azione. Tocca ad Annalisa Cicerchia sviluppare la critica dell’idolatria degli indicatori e delle fake news, al fine di giungere ad una valorizzazione appropriata delle piccole idee per convivere con il sovraccarico di informazioni.
Come si riconosce nel libro, il problema sta nel filtro e nella capacità di utilizzo dei codici per selezionare le informazioni. Senza quei codici si configura un analfabetismo di secondo grado che Marta Maddalon, nel capitolo relativo, propone di affrontare con la rilevanza del linguaggio e dell’educazione al linguaggio. È con il linguaggio che si può affrontare la disintermediazione: “Rimediare significa dare la possibilità alle persone di trovare un accosto e un riparo rispetto alle tante forme di sradicamento nel tempo e nello spazio”, come scrive Alessandro Bollo. Sono le istituzioni culturali che possono svolgere un ruolo di intermediazione e nel libro curato da De Biase viene dato ampio spazio alla ricerca di possibilità di valorizzazione della mediazione della cultura.
Tocca a Ludovico Solima occuparsi in particolare del ruolo dei musei per ri-connettere e per ri-mediare, combinando opere e visitatori in un dialogo la cui efficacia è particolarmente importante per la memoria come via di ri-mediazione.
La sezione del libro che si occupa di comunità è aperta da Ezio Manzini che pone al centro delle moderne comunità il principio di scelta: “Le nuove comunità vanno viste come un intreccio di conversazioni cui le persone partecipano in modi diversi, scegliendo dove, come e per quanto tempo allocarvi le proprie risorse (di attenzione, competenze, disponibilità relazionale). Il loro primo carattere distintivo rispetto alle comunità premoderne sta nel fatto che i legami che vi si intessono sono il risultato di una scelta” [p. 182]. Le comunità sono luoghi dell’abitare e si distinguono per essere in grado di contenere le dimensioni relazionali e culturali, in quanto sono il luogo del “dentro” e del “fuori”, dove intrapsichico e sociale sono strettamente interconnessi, come mostra il contributo di Alice Mulasso. Tra Bologna e Napoli, sono presentati anche casi in cui sono in corso importanti sperimentazioni di ri-mediazione a livello comunitario.
Partecipazione e centratura sulle persone e sul ruolo dell’iniziativa di ognuno sono trattati nell’ultima parte di un volume che si propone di affrontare una delle questioni più critiche della nostra contemporaneità, la crisi di mediazione. Chiudendo il volume si riconosce la complessità della questione, la sua problematicità e la ricerca per cercare di attivare legami sociali all’altezza del nostro tempo.









