Un nuovo libro su Primo Levi / I tedeschi e la colpa
Quando nel ’46 il filosofo Karl Jaspers riprese l’insegnamento in Germania, che era stato costretto ad abbandonare per aver sposato un’ebrea, dedicò il suo corso alla questione della colpa, soffermandosi sulla colpa ‘metafisica’, quella che investe chi non fa nulla per impedire il male inflitto a un proprio simile. È questa la dimensione a cui si pone il confronto che Levi aspira ad avere con i tedeschi. «La mancata diffusione della verità sui lager costituisce una delle maggiori colpe collettive del popolo tedesco, e la più aperta dimostrazione della viltà a cui il terrore hitleriano lo aveva ridotto» (SeS). Le pagine del suo primo libro Levi le aveva scritte senza pensare a un destinatario specifico, come chi sente il bisogno di gridarle sui tetti, ma quando Se questo è un uomo viene tradotto in lingua tedesca nella Germania Federale, dice nella prefazione che ha trovato compimento lo scopo della sua vita, «di portare testimonianza, di fare udire la mia voce al popolo tedesco, di ‘rispondere’ al kapo che si è pulito la mano sulla mia spalla, al dottor Pannwitz, a quelli che impiccarono l’Ultimo, ed ai loro eredi».
In I sommersi e i salvati, dice che, all’annuncio del contratto, gli era diventato chiaro che il libro era sì rivolto a tutti, ma «i suoi destinatari veri, quelli contro cui il libro si puntava come un’arma, erano loro, i tedeschi. Ora l’arma era carica».
In risposta alla sua domanda se sia possibile capire i tedeschi, Levi riceve tra il 1961 e il 1964 una quarantina di lettere dai suoi lettori, che commenta nell’ultimo capitolo di I sommersi e i salvati. In molte si scorge il desiderio di assoluzione, il goffo tentativo di scaricare le colpe su Hitler e la sua demoniaca virtù di persuasione, cancellando o fingendo di ignorare le responsabilità degli industriali di ditte ancora fiorenti che assumevano schiavi affamati, di quanti entravano volontari nelle SS, di quanti utilizzavano i beni strappati agli ebrei. L’interlocutrice con cui si avvia lo scambio di lettere più duraturo e un solido rapporto di amicizia è una coetanea di Levi, Hety Schmitt-Maass, di famiglia anti-nazista, amica di Hermann Langbein, che mette Levi in contatto con Jean Améry. Hety muore all’improvviso nell’83, una scomparsa che rattrista molto Levi; l’esistenza di simili persone, ha scritto Ian Thompson, gli pareva garanzia che un quarto Reich non sarebbe mai nato. È proprio Hety a recuperare l’indirizzo di Ferdinand Meyer, un chimico che aveva lavorato nel laboratorio della Buna, di cui Levi ricorda il comportamento gentile con i colleghi ma anche con i prigionieri. Avrà così inizio una corrispondenza fra i due chimici, che Levi ricostruisce, ‘arrotondandola’ un po’, nel capitolo Vanadio di Il sistema periodico; s’inventa un contenzioso con una ditta tedesca, e dalla corrispondenza emerge un indizio, un lapsus di scrittura che induce Levi a supporre che il suo interlocutore sia proprio il Meyer incontrato in lager. Müller (così lo chiama in Vanadio) era un borghese che, a differenza degli altri, si era rivolto a Levi in modo cortese, lo aveva aiutato e in un’occasione gli aveva chiesto: «Perché ha l’aria così inquieta?», al che Levi aveva pensato fra sé e sé: «costui non si rende conto».
Nella lettera a Levi, Müller sostiene che la IG-Farben aveva assunto prigionieri solo per proteggerli, che ad Auschwitz nulla lo aveva indotto a pensare all’uccisione di ebrei, il che era anche possibile, commenta Levi, bastava non porre domande, né cercare spiegazioni alle fiamme che uscivano dal crematorio, visibili nei giorni chiari anche dalla Buna. A distanza di più vent’anni, valeva ancora quanto Levi aveva pensato allora, «costui non si rende conto». Il personaggio Müller rimaneva «un esemplare umano tipicamente grigio, uno dei non pochi monocoli nel regno dei ciechi»; cercava di far tornare i conti col passato barando un poco. Lo scrittore prepara la minuta della risposta, in cui cita casi di tedeschi che avevano dato prova di coraggio; certo, non tutti nascono eroi, «un mondo in cui tutti fossero come lui, cioè onesti e inermi, sarebbe tollerabile, ma questo è un mondo irreale. Nel mondo reale gli armati esistono, costruiscono Auschwitz, e gli onesti e inermi spianano loro la strada; perciò di Auschwitz deve rispondere ogni tedesco, anzi, ogni uomo, e dopo Auschwitz non è più lecito essere inermi». L’incontro che Müller auspicava non avrà luogo, il chimico tedesco muore all’improvviso a sessant’anni. Levi ne ebbe sollievo: «Mi conosco: non posseggo prontezza polemica, l’avversario mi distrae, mi interessa più come uomo che come avversario, lo sto a sentire e rischio di credergli; lo sdegno e il giusto giudizio mi tornano dopo, sulle scale, quando non servono più» (SP).
«Non comprendo, non sopporto che si giudichi un uomo non per quello che è, ma per il gruppo a cui gli accade di appartenere» (Ses); non è forse questo che hanno fatto i nazisti nei confronti degli ebrei e degli altri popoli inferiori? D’altra parte, Levi osserva in più occasioni come alcuni tratti appaiano specifici della mentalità tedesca. A partire dal tatuaggio, invenzione auschwitziana autoctona, equivalente al marchio che si imprime agli schiavi e al bestiame, in cui si manifestava il tipico talento tedesco per le classificazioni. E lo stesso vale per l’appello-conteggio, cerimonia vuota e rituale, che poteva durare ore, l’emblema stesso del lager, erede della tradizione del Drill, la feroce pratica militaresca prussiana, violenza insulsa che Hitler aveva condotto al parossismo. Retaggio di caserma, simbolo dell’ossessione per l’ordine e la disciplina, era anche il rito di rifare il letto, Bettenbauen, operazione sacrale, da eseguirsi secondo regole ferree. La «grande follia della terza Germania» era una «follia geometrica»: l’efficientismo fine a sé stesso, la mania dell’ordine, il fanatico attaccamento alla legge da applicare rigidamente, il burocratico ordinamento … Il lager è agli occhi di Levi un microcosmo che rispecchia fedelmente il tessuto sociale dello Stato totalitario: vi è instaurato un sistema d’autorità tipicamente fascista, una gerarchia rigida, un sistema d’investiture decise dall’alto, al di fuori di meriti e competenze. L’Ordine deve regnare sovrano, «non c’era luogo più ordinato del lager», un ordine ovviamente senza diritto, scrive Levi in Così fu Auschwitz (1975).

IL MALE
Il convitato di pietra nella interrogazione sul lager è il Male. Nonostante l’accusa si sforzasse di presentare Eichmann come un essere demoniaco, una belva feroce, il pianificatore dello sterminio di sei milioni di ebrei appare ad Arendt un essere mediocre e ordinario, non un perverso o un sadico: il male in lui è banale, estremo ma non inumano, proprio per questo tanto più pericoloso. Nell’esaminare gli ‘stereotipi’ diffusi sul tema del lager, Levi osserva che il termine ‘aguzzini’ appare improprio perché fa pensare a individui distorti, affetti da un vizio d’origine; invece «erano fatti della nostra stessa stoffa, erano esseri umani medi, mediamente intelligenti, mediamente malvagi: salvo eccezioni, non erano mostri, avevano il nostro viso» (SeS). Proprio il carattere ordinario di crimini compiuti da gente normale dovrebbe indurci a rimettere in discussione il ricorso stesso alla categoria di Male, come ha proposto il filosofo francese François Jullien, meditando anche sull’insegnamento di Levi. Il Male è nozione che trascina con sé intonazioni gnostiche e manichee, resta categoria di ascendenza mitico-religiosa, è un concetto levigato dalla tradizione metafisica, lascia supporre uno scontro drammatico con un Bene ideale, se non con un dover-essere trascendente; s’iscrive dentro un pensiero della Salvezza, che vuole redimere l’anima e il mondo, e chiama alla lotta eroica per riprendersi dalla caduta. Jullien propone di ricorrere ad altre nozioni, come abietto, per esprimere la reazione immediata di rifiuto dell’intollerabile, o doloroso, nozione che invita, non tanto a spiegare, ma a com-prendere, cioè a condividere la sofferenza nella com-passione.
La categoria patologica del mostruoso, l’ipotesi metafisica di un desiderio del male, l’emergere del demoniaco in termini religiosi (lettura che il laico Levi rifiuta nella conversazione con Camon) non sembrano darci contributi esplicativi di fronte alla disumanizzazione dei campi. Neppure appare sufficiente la spiegazione che fa appello al fanatismo, perché pochi erano i fanatici, i più erano conformisti, pronti a servire il potere per interesse. L’universo degli assassini si compone di ‘onesti’ impiegati che aspirano a fare carriera, i complici del crimine compongono l’immensa massa della mediocrità umana. Ne abbiamo conferma da indagini storiche apparse negli anni Novanta, che si sono soffermate sulle azioni del battaglione 101o di polizia di Amburgo, composto da impiegati, operai, commercianti, non fanatici nazisti antisemiti, ma soldati della Riserva, chiamati per le necessità belliche. Questi ‘uomini comuni’ (come recita il titolo del libro di Christopher Browning) compiono massacri fra gli ebrei dei villaggi di Polonia e Ucraina, ne selezionano altri per i campi di sterminio; sono I volonterosi carnefici di Hitler (titolo del libro di Daniel Jonah Goldhagen), diventati efficienti assassini non per fede nell’autorità o paura di punizioni, ma per spirito di emulazione, per conformismo al gruppo, per non sentirsi esclusi dai commilitoni. Alla normalità degli assassini corrisponde quella dell’amministrazione; è l’ordinario apparato burocratico della Germania ad aver gestito il genocidio, ma la barriera della coscienza cade nel momento in cui l’atto è inserito nell’ambito rassicurante del lavoro organizzato e pianificato; quando il crimine è collettivo, la colpa degli altri lava la propria, ha osservato Todorov.
Più che i richiami alla malvagità personale, in termini psicologici, Primo Levi invita a una lettura sociale e politica, senza per questo annullare la responsabilità giuridica e morale, di cui solo gli individui sono imputabili: «la massima colpa pesa sul sistema, sulla struttura stessa dello Stato totalitario» (SeS).
Lo stato totalitario ha bisogno di funzionari più che di adepti, chiede pragmatica efficienza e il cinismo di chi non si rivolge più alla coscienza per valutare la correttezza morale delle proprie azioni: il funzionario ideale del regime è giunto all’apatia (in senso letterale, assenza di pathos, di empatia verso l’altro), i suoi comportamenti diventano rigidi, la sua personalità è ripartita in compartimenti stagni che distinguono l’ambito del privato dalla sfera pubblica del ‘lavoro’. Un tratto comune ai guardiani è la rottura schizofrenica fra comportamento e coscienza: «pietà e brutalità possono coesistere, nello stesso individuo e nello stesso momento, contro ogni logica» (SeS). Un’azione malvagia può scaturire da un uomo giudicato buono e convinto seguace di dottrine religiose: Langbein racconta di un kapo particolarmente pio che, dopo aver pregato, bastonava i prigionieri. I membri di un Einsatzgruppe in Russia eseguono in fretta l’ordine di sterminare tremila ebrei e tzigani perché devono recarsi alla messa di Natale.
Il meccanismo della depersonalizzazione agisce nei confronti di sé come dell’altro.
Nel sistema totalitario nazista, essere classificato come nemico equivale a vedersi escluso dall’umanità; se le vittime non sono più uomini, viene a cadere il ritegno verso la loro eliminazione e il genocidio equivale a una gigantesca opera di derattizzazione del mondo: non sono forse topi gli ebrei nel graphic novel Maus di Art Spiegelman? Nel capitolo di I sommersi e i salvati dedicato alla Violenza inutile, Levi si sofferma sulla «inutile crudeltà del pudore violato», sulla costrizione della nudità; in lager si entrava nudi, si era costretti di continuo a spogliarsi pubblicamente, per il controllo dei pidocchi, per le selezioni periodiche. Un uomo nudo e scalzo è una preda inerme, «non percepisce più sé stesso come un essere umano, bensì come un lombrico: nudo, lento, ignobile, prono al suolo. Sa che potrà essere schiacciato a ogni momento». Di fronte a esseri senza più nome, battezzati con numeri, privati d’identità, il guardiano si sente legittimato a trattarli come animali; e tali appaiono, nudi, sporchi e malati, in cerca di cibo, gregge che si lascia condurre al macello. La colpa ricade sulle vittime disumanizzate, sono loro i mostri perché costringono a ucciderli. Di fronte alla vittima degradata, l’uccisore sente meno il peso della colpa, è questa l’unica utilità della violenza inutile.
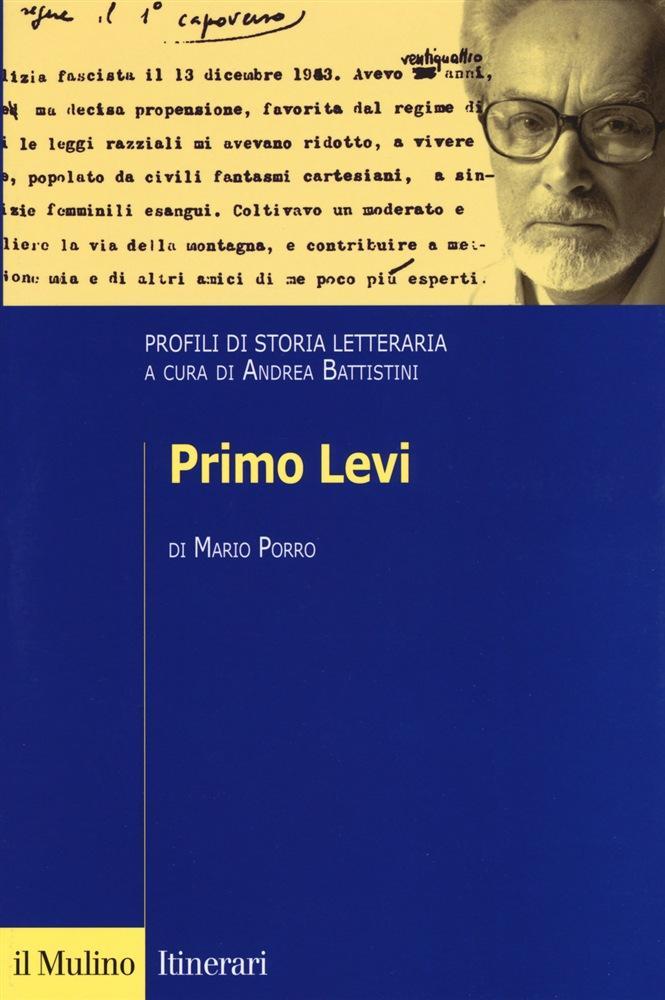
M. Porro, Primo Levi, il Mulino, Bologna 2017.
L’OBBEDIENZA
La formula cara a ogni fascismo, ammissione di castrazione intellettuale, era scritta sui muri delle case nel ventennio del regime mussoliniano: «credere, obbedire, combattere». Dietro la responsabilità dei capi sta quella della grande maggioranza dei tedeschi (e degli italiani) che, per pigrizia mentale, calcolo miope, orgoglio nazionale, hanno assunto l’atteggiamento di docile sottomissione caratteristico degli Stati totalitari. Il leader diviene il detentore dei fini ultimi del cammino a cui conduce quella che Hitler chiamava la ‘dea della storia’. È lo Stato a stabilire cosa siano il bene e il male, l’individuo viene dispensato dal pesante fardello della responsabilità; la condotta dei sudditi diviene strumentale, si limita ad attuare i mezzi per realizzare fini già stabiliti, si riduce ad assolvere gli atti che competono all’ambito ristretto della propria specialità. Grazie a educazione e propaganda, il suddito ‘ideale’ è un passivo, ma efficiente, esecutore di ordini: di qui la ‘tragica fatalità’ per cui brave persone possono diventare carnefici, senza avvertire responsabilità per i misfatti commessi. Uccidendo e torturando, i guardiani si conformano alle leggi del loro paese e agli ordini dei capi; dai crimini nazisti, rileva Todorov, s’impara che coloro che applicano la legge sono più pericolosi di coloro che la trasgrediscono. Il male più che nell’aggressività sta nell’obbedienza, nella remissività, nella disponibilità a eseguire gli ordini: «è una questione di eccessivo ossequio all’autorità, non di esercizio dell’autorità, il male principale», dice Levi (1982, CI). Anche per il Lorenz di Il cosiddetto male le radici del male stanno nel processo di addomesticamento: l’uomo addestrato diventa capace di violenza perché i meccanismi d’inibizione dell’aggressività intraspecifica sono annullati.
Nel Memoriale di Yad Vashem a Gerusalemme, un albero è piantato per ogni gentile che abbia salvato almeno un ebreo dalla persecuzione nazista. Non si tratta di eroi o santi, spesso sono figure ‘ambigue’ come l’imprenditore tedesco Oskar Schindler, che aveva sfruttato la manodopera della Polonia occupata. Anche il bene abita una zona grigia, in cui l’altruismo può mescolarsi all’opportunismo, il coraggio alla fede in ideologie antidemocratiche; ma in ogni caso sta dal lato della disobbedienza o, quantomeno, dell’aggiramento, dell’elusione della legge. Esemplare in tal senso la vicenda di Paul Grüninger, capo della polizia di frontiera del cantone di san Gallo: la Svizzera, a partire dall’agosto del 1939, decise di chiudere le frontiere ai profughi ebrei, ma Grüninger finse di non vedere il loro transito, in qualche caso retrodatò i visti d’ingresso. Già nel ’39 venne licenziato, poi condannato e privato della pensione, subì il discredito dei concittadini e morì in povertà.
In una conferenza del ’79, Levi affronta il tema del pregiudizio razziale e propone una valutazione differente da quella prospettata dal relatore che lo aveva preceduto, Norberto Bobbio. Per il filosofo del Diritto, il razzismo è da interpretare in termini eminentemente culturali e quindi da affrontare con la terapia dell’educazione. Levi, richiamandosi anche agli studi etologici, ritiene che l’intolleranza razziale sia qualcosa di ferino, abbia origini preumane, «addirittura è incorporata in certi istinti primordiali» che ci accomunano ad altri mammiferi o ad altri animali gregari, sociali, come le api e le formiche, con la loro divisione in caste (PS, I). È dal bisogno animale di difendere il proprio territorio che si origina l’avversione verso l’ebreo: il bersaglio naturale, il capro espiatorio ottimale di tutti coloro che si impegnano nella demarcazione dei confini, per il suo essere figura di frontiera, non riconducibile a classi, nazioni o stati. Ma non è sufficiente la spiegazione che interpreta l’esercizio del male come regressione alla bestialità, a istinti primordiali, perché né la tortura né lo sterminio hanno equivalenti fra le bestie. Se è vero che «Hitler ha bestializzato la Germania» (CI), l’animalità non si esprime solo in termini di violenza aggressiva, di ferocia imposta dalla lotta per la sopravvivenza: in La banalità del male, Hannah Arendt scrive che il problema più difficile per gli esecutori della soluzione finale fu di «soffocare […] la pietà istintiva, animale, che ogni individuo normale prova di fronte alla sofferenza fisica degli altri».
Il campo di annientamento è reso possibile dalla macchina organizzativa che riduce le vittime a bestie, una macchina funzionante secondo i criteri della razionalità ‘strumentale’ di una normale azienda che valuta in base a esigenze di bilancio. Zygmunt Bauman, in Modernità e Olocausto, ha sostenuto che lo sterminio è stato possibile perché rispondeva ai criteri dell’efficienza (minimo dei costi e massimo dei ‘benefici’) e dell’efficacia (scelta di mezzi adeguati al fine).
Auschwitz porta all’estremo le caratteristiche del moderno sistema di fabbrica: invece di produrre merci, utilizza gli esseri umani come materia prima e sforna la morte come prodotto finale, con le quantità giornaliere riportate sul rendiconto dei dirigenti. Auschwitz sarebbe in tal senso «un enorme progetto di ingegneria sociale», figlio dell’Occidente tanto quanto le fabbriche di Detroit: precisione, disciplina e insensibilità militaresca convivono con i criteri produttivi del risparmio esasperato e del recupero dei ‘materiali’, in questo caso le spoglie delle vittime.
Al pari della divisione del lavoro di fabbrica, anche la pratica dello sterminio richiede la compartimentazione degli atti. Come altri prima di lui, Eichmann cercherà di difendersi nel processo a Gerusalemme dicendo di non aver mai ucciso nessuno con le proprie mani; in effetti, nei tanti anelli di cui si compone la catena dello sterminio, le responsabilità sfumano fin quasi a scomparire. Al vertice della catena c’è Reinhard Heydrich, collaboratore di Himmler alla guida delle SS, poi Eichmann che si occupa di organizzare i trasporti verso i campi, i cui comandanti controllano che i treni siano in orario e coordinano le selezioni alla rampa. Gli anelli mediani della catena, incaricati dell’arresto di ebrei e oppositori, spesso sono soldati e poliziotti dei paesi collaboranti.
Al termine della catena, un gruppo di detenuti del Sonderkommando convince i prigionieri a farsi una doccia e disinfestarsi; gli esecutori finali, gli unici a uccidere, sono scelti tra le vittime stesse, rese compartecipi del male. Nel romanzo Le benevole, Jonathan Littell affida alle memorie del protagonista, responsabile di un Einsatzgruppe nell’Europa dell’Est, la ricerca di giustificazioni ai crimini cui ha partecipato: chi spara alla nuca di un uomo non è forse solo l’ultimo anello di una lunghissima catena? La vittima gli è stata portata da altri, altri hanno deciso la sua sorte. Chi è colpevole? Tutti o nessuno? «Chi manovra gli scambi della ferrovia, per esempio, è forse colpevole della morte degli ebrei che ha avviato verso un campo di concentramento?». Non fa che il suo lavoro di sempre, non è tenuto a sapere cosa trasporta il treno che conduce. E cosa dire del tipografo che stampa gli avvisi di deportazione, del fornitore di filo spinato o di benzina, e di «Dio, lassù, che permette tutto questo»?
In M. Porro, Primo Levi, il Mulino, Bologna 2017.









