
Gravità, stringhe e quantisti a loop
All’origine della cosmogonia di Esiodo sta il conflitto tra i Giganti e la progenie di Crono: imparentati, eppure destinati a eliminarsi. C’è bisogno di un ordine cosmogonico e cosmologico che predisponga una nuova dinastia divina per il mondo e per l’umano. Come spiega Jean-Pierre Vernant (L’universo, gli dèi, gli uomini, Einaudi 2014), dalla loro i Giganti hanno il carattere dell’ibrido: non sono creature né del tutto umane né del tutto divine; sono giovani guerrieri che fanno da epitome alla cultura della guerra e all’ordine militare, e che per tale ragione sono rosi dal dubbio se non debbano esser proprio loro a detenere il potere assoluto sull’universo. Il loro vigore è tale e tanto che gli dèi di fatto non riescono mai a imporsi, se non con i soliti mezzucci: la furbizia e l’inganno. Rispetto ai Giganti, gli dèi hanno qualità, se non opposte, ortogonali: un’ambizione geometrica, un’invidiabile capacità di fiutare le debolezze altrui e di trarne il massimo vantaggio, un senso della casta che consente, alla fin fine, la distribuzione equilibrata di onori e responsabilità.
Gli dèi saranno vincitori proprio perché capaci, con meno vanagloria, di rendere deboli e fragili tutti i loro avversari. E varrà la pena notare sin da subito che per chi scrive non sarà facile uscir di metafora: abbiamo davanti a noi, come proiettate su un futuro ancora inconoscibile – eppure diversissimo in base a detta proiezione – due teorie che si sfidano in una rinnovata titanomachia: la teoria delle stringhe e la teoria della gravità a loop. Il recente libro di Jim Baggott, Quanti di spazio (Adelphi 2022), racconta della genesi del conflitto e, senza nascondere le simpatie per una delle parti, profila lo scenario di un possibile futuro. Sarà bene in questa sede cominciare dalla genesi.
Com’è inevitabile che sia per ogni questione della fisica d’oggi, è ai rivolgimenti del primo Novecento che si deve far risalire il principio di uno scontro tra posizioni sempre più ramificate e idiosincratiche sul ruolo, lo statuto e il possibile sviluppo della disciplina e dei suoi metodi. Uno dei primi sforzi che accompagnarono la messa a punto della meccanica quantistica fu il tentativo di offrire una formulazione quantistica della teoria classica dell’elettromagnetismo. La prima versione, sviluppata da Werner Heisenberg e Wolfgang Pauli nel 1929, presentava numerosi problemi, risolti solo nel 1947 grazie allo sforzo congiunto di Sin-Itiro Tomonaga, Julian Schwinger e Richard Feynman, che per questo nel 1965 ottennero il premio Nobel. Negli anni Cinquanta, il successo di un’impresa tanto prodigiosa spinse i fisici a tentare di estenderne la portata applicativa, con l’intento di ricomprendere tutte le altre forze allora note.
Prese così avvio una linea di ricerca che avrebbe portato, nel volgere di poco più d’un ventennio, alla definizione del cosiddetto Modello Standard. Quest’ultimo, che ad oggi offre la sintesi più efficace delle interazioni su scala microscopica, definisce una tassonomia imperniata su una bipartizione tra particelle che descrivono la materia (come gli elettroni) e particelle che mediano le forze (come i fotoni). Pur nella sua sontuosa raffinatezza teorica, tale modello non era tuttavia esente da un’imbarazzante lacuna. Un colossale convitato di pietra era alle porte e chiedeva giustizia: un modello che aspirava a offrire una caratterizzazione esaustiva del reale trascurava la formulazione della relatività generale, che pretendeva e pretende tuttora l’ultima parola sullo spaziotempo e sul rapporto inscindibile che lo lega alla gravità.
I tentativi di integrazione della gravità, ben prima e oltre la formulazione del Modello Standard, non erano mancati. Prendendo a prestito una tecnica messa a punto da Paul Dirac per trasporre teorie classiche in quantistiche, si era avanzata una prima formulazione detta di quantizzazione canonica. Una formulazione però che non rendeva alcun conto della natura dinamica dello spaziotempo per come suggerita dalla relatività generale. In un fecondo ma inefficace tentativo di integrazione e superamento, Feynman cercò di adattare le tecniche sviluppate in teoria dei campi per includere la gravità, secondo un approccio detto covariante. Anche in tal caso, tuttavia, il tentativo disattendeva il vincolo tra gravità e geometria spaziotemporale, elemento irrinunciabile della teoria einsteiniana. Di fatto, le due proposte seguivano un percorso speculare ma parimenti inadatto.
Proprio tra chi studiava la natura delle particelle e delle loro interazioni sarebbe giunto un primo grande tentativo di rottura, di totale ricostruzione semantica del problema, che avrebbe cioè portato a una ridefinizione completa dei termini. In uno sforzo colossale per superare l’impasse di un modello quantistico delle particelle che non contemplava la gravitazione, si pensò, con ingenua quanto sagace semplicità, che le particelle non esistono: esistono piuttosto dei filamenti o stringhe, le cui particolari configurazioni si comportano come particelle. La prima intuizione in tal senso risale al 1968, quando il fisico fiorentino Gabriele Veneziano, di stanza come post-doc al CERN di Ginevra, tentava di descrivere le collisioni e la diffusione di alcune particelle note come pioni. Il quasi coetaneo fisico newyorkese Leonard Susskind notò che una tale descrizione equivaleva a ciò che accade quando due cordicelle si uniscono e oscillano per un breve tratto di tempo per poi separarsi (cfr. A Conversation With Leonard Susskind). L’esito teorico, intrigante quanto controintuitivo, fu quello di dismettere l’idea di particelle puntiformi per guardare piuttosto a ciò che le tiene assieme come costituenti di base dell’universo, o meglio, come configurazioni vibrazionali di un unico tipo di corda detta stringa. A ciascuno dei modi vibrazionali di tale elemento fondamentale verrebbe così a corrispondere una tra le particelle che figurano nella panoplia del Modello Standard, come il gravitone, il fotone, l’elettrone. Dopo una prima fase di sviluppo, che va dalla proposta di Veneziano fino al 1973, la teoria delle stringhe venne nel 1974 identificata come possibile esempio di unificazione tra tutte le interazioni fondamentali, inclusa quella gravitazionale.
Rimaneva tuttavia una questione irrisolta, un’indesiderabile implicazione dell’idea per cui una stringa occupa lo spazio in ogni istante del tempo, e che quindi la sua storia nello spazio-tempo possa essere descritta dalla superficie bidimensionale che si chiama “foglio di universo”. In questa ottica, una stringa può essere pensata come un cilindro molto sottile, le cui sezioni rappresentano la posizione di essa in un determinato istante. Di fatto, si continuava a presupporre quello spaziotempo fondamentale ammesso sì dalla fisica special-relativistica ma escluso dalla relatività generale: un qualcosa che è occupato da qualcos’altro, un contenitore di qualcosa che, sezionato, corrisponde via via agli stati della realtà.
Converrà lasciare qui la storia della teoria delle stringhe, su cui si lavora ancora e con alterni risultati, per raggiungere una perfezione teorica certo ancora molto lontana dalla comprova empirica, e passare alla sua ambiziosa avversaria, che per molti versi prese origine proprio dalle difficoltà incontrate da Susskind & Co. All’inizio degli anni Ottanta, Lee Smolin, affascinato dalle promesse della teoria delle stringhe, aspirava a dotarla di un pieno statuto di teoria della gravità quantistica.
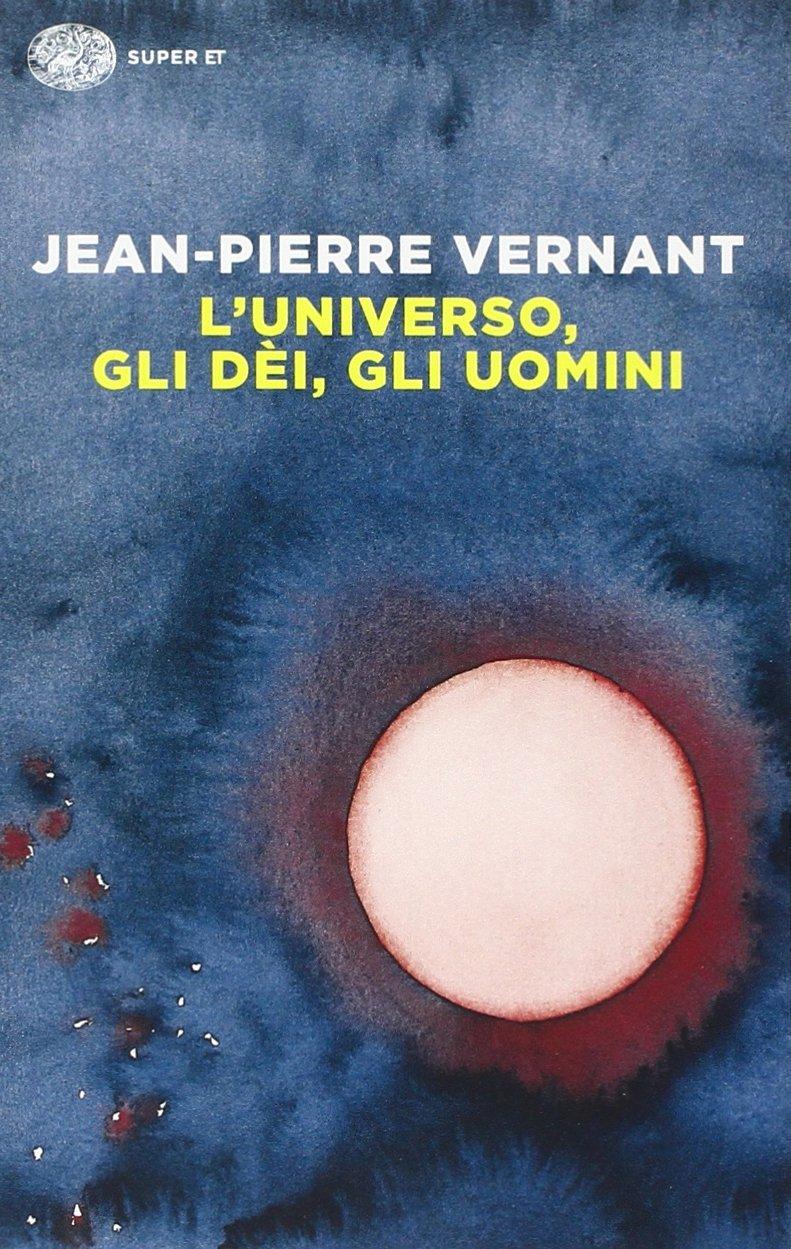
Un punto di svolta si registrò nel 1982, quando un giovane fisico, Amitabha Sen, avanzò una prima proposta tesa a rendere la descrizione dei fenomeni fisici affatto indipendente da uno spaziotempo di fondo – proposta che prende il nome di teoria delle connessioni, in grado di definire una procedura efficace per disancorare le entità fisiche da un sistema di coordinate. Poter applicare una simile strategia alla relatività generale avrebbe significato caratterizzare il campo gravitazionale quale sistema di connessioni non ancorato ad alcuno sfondo. L’idea venne ulteriormente sviluppata da Abhay Ashtekar, quando scoprì che tale riformulazione rendeva la relatività generale simile a una teoria di campo classico – là dove un campo è un’entità matematica che associa a ogni suo punto una proprietà caratteristica (come massa, energia, carica elettrica).
Quando apprese dei suoi lavori, Lee Smolin invitò Ashtekar a tenere un seminario a Yale. Egli si convinse così che quella fosse la strada da perseguire e, assieme ai fisici statunitensi Paul Renteln e Ted Jacobson, riscrisse le equazioni della relatività generale svincolate dal reticolo spaziotemporale, trovando poi con Jacobson una classe infinita di soluzioni. I risultati vennero presentati da Smolin e Jacobson nel 1986 durante le fasi finali di una conferenza a Santa Barbara. Tra gli uditori, Carlo Rovelli, un giovane fisico teorico italiano che aveva deciso, una volta conseguito il dottorato, di finanziarsi un viaggio all’estero per incontrare le figure più rappresentative nel campo della gravità quantistica.
Spazi quantistici, a questa altezza, si trasforma da poema delle origini a Bildungsroman, perlopiù dedicato, non senza qualche nota d’intimismo, al sodalizio più che trentennale tra Smolin e Rovelli. E in questa piega la figura del fisico italiano assume progressiva rilevanza. Rovelli ebbe infatti un’intuizione capace di imprimere una svolta, quella che portò all’idea di gravità a loop – questi ultimi identificabili quali anelli o granuli infinitesimali dotati di specifiche proprietà, la cui interazione sarebbe responsabile dell’emergere dello spazio-tempo: la proposta di Smolin e collaboratori continuava a includere implicitamente lo spaziotempo gravitazionale – presenza manifesta in alcune incongruenze nel cambio di coordinate. Si rendeva necessario un passo ulteriore per sganciare definitivamente la descrizione da uno sfondo di riferimento e includere l’idea di “loop di gravità” indipendente dallo spaziotempo. Dopo alcuni mesi di messa a punto, il risultato fu una teoria che “dipendeva solo dai rapporti dei loop l’uno con l’altro – da come si annodano, si allacciano e si attorcigliano” (p. 167). La coppia di collaboratori presentò il modello prima ad Ashtekar, quindi ad altre figure di riferimento nel campo degli studi, infine a una conferenza su gravità e cosmologia in India: questo il battesimo della gravità quantistica a loop.
Il libro di Baggott, da romanzo di formazione piega sempre più nei toni e nelle forme verso quel microracconto di Goffredo Parise che nei Sillabari prende il nome di Amicizia: la gravità quantistica a loop s’incarna nella biografia gemella di due figure che intesse ardimento e nostalgia. Le pagine del giornalista scientifico britannico seguono le varie peripezie dei due (che certo ebbero a pagare la scelta di occuparsi di un settore tanto di nicchia, con finanziamenti e posizioni massimamente incerte), sempre piegate in modo tale da far sì che gli esiti scientifici potessero trovare vigore, in primo luogo, dall’effervescenza di una relazione personale. Quale esempio plastico della felicità di un tale rapporto, la tradizione delle cosiddette “vacanze di lavoro” italiane – tradizione che venne portata avanti per diversi anni: che Smolin fosse di stanza a Trento, Verona o Bologna, i due fisici fecero sì che si avvicendassero incontri, discussioni, esperienze comuni in cui il dirozzamento della teoria si imperniava e sostanziava della complicità di uno stile che aveva i modi pieni della philia. E il libro, per buona parte, si conclude così, a metà tra cronaca di un’epopea e diario emotivo.
C’è chi, tra i fisici delle generazioni nuovissime, ritiene la gigantomachia di cui sopra un affresco mitico da consegnarsi al passato, perché la corsa a due è diventata una corsa a molti. Ma chi scrive è sempre troppo incline a infestare la fisica con infiorescenze letterarie insensibili al volgersi reale dei fatti. Quindi varrà la pena insistere sul solco del mito, e di Baggott suo novello cantore. E, per concludere questo rapido scritto con un’intuizione che richiama di tutto punto il sotterfugio che concesse agli dèi il primato sull’universo, sarà utile menzionare la ragione per la quale, ad avviso del divulgatore britannico, il primato spetta alla teoria della gravità a loop. Se, com’è noto, fu proprio con il ricorso a Eracle, affetto dal vizio, almeno parziale, dell’umanità, che gli dèi si assicurarono il loro imperio, per una stessa vantata debolezza, secondo Baggott, la teoria quantistica a loop ha maggiori chance di proiettarsi sul futuro: il vizio, a ben vedere virtuoso, di non voler spiegare tutto. La teoria delle stringhe, in effetti, nasce per vocazione come teoria del tutto, cioè modello che pretende di rendere conto del complesso delle interazioni fondamentali e quindi di includere la gravità in una teoria della realtà microscopica. All’opposto, la teoria della gravità a loop ha la più umile pretesa di servire quale “tecnica matematica per riformulare e semplificare notevolmente la relatività generale così da farla somigliare molto a una teoria di campo quantistica” (p. 190). In tal modo, con un gradiente di hybris nettamente minore, questa teoria sfoggia un’inclinazione alla sinergia, tesa non già a scalzare quanto esiste (in particolare, relatività generale e meccanica quantistica), bensì a integrarsi con esso dotandolo di un nuovo linguaggio e di una nuova tecnica.
In scritti come il presente, specie in chiusura, è prassi, oltreché clausola di salvaguardia, prendere le distanze da qualsiasi conclusione, mostrare una tendenza agnostica e confessare di sottecchi neghittose simpatie per chi esotericamente sappia coglierle. Prassi cui in questa sede ci si atterrà col massimo scrupolo. Senza quindi offrire straccio di evidenza, l’opinione di chi scrive è la seguente: rispetto alle professioni di umiltà con cui la teoria della gravità a loop si aggiudica gli esiti della tenzone mitica, confesso le mie simpatie per quei modelli che, con atto di coraggio che lambisce gli anni ruggenti del primo Novecento, ambiscono riporre ogni teoria esistente nell’archivio di storia della cultura e offrire una visione dell’universo radicalmente altra. Se le chance di convalidare empiricamente le proprie pretese di verità sono le stesse, ne guadagna però in modo incomparabile quell’atlante portentoso di mondi possibili che è, e continua a essere, la fisica contemporanea.









