Ritorna "Ungenach" / Il Sessantotto di Thomas Bernhard
Ungenach è una grande, immensa proprietà terriera fatta di boschi, di campi, di frutteti, di case, ulivi, cave, impianti industriali ed estrattivi, cui vanno aggiunte altre proprietà a Vienna e altrove. È il luogo dell’infanzia infelice di due fratelli, Robert e Karl Zoiss, figli del proprietario. Un luogo che somiglia a un incubo, la fortezza del cattivo gusto eretta dalla seconda moglie del padre, la matrigna di Karl, una fortilizio serrato: “… chi arriva a Ungenach senza conoscerla, nota Ungenach solo quando le è davanti; all’improvviso, dopo aver camminato un’ora attraverso il bosco, si trova davanti alle mura, al portone chiuso” e anche se costui è atteso, può capitare che sia lasciato ad aspettare, ad aspettare, e molti di quelli che arrivano e aspettano non sono lasciati entrare…
Simile al castello di Kafka, “luogo perverso”, “teatro di tutti i nostri orrori”, luogo della ripetizione e dell’esilio da sé stessi, Ungenach è il magma nucleare intorno a cui si svolge l’ultimo abrasivo romanzo di Thomas Bernhard ripubblicato in Italia.
Il titolo è quello di quel sito oppressivo, Ungenach, immensa eredità materiale e spirituale di cui sbarazzarsi. Da donare, da liquidare (e il sottotitolo, in bernhardiano stile, è Una liquidazione). Luogo dell’origine dal quale la prima voce narrante, uno dei due fratelli, Robert, fugge il giorno del funerale del suo tutore, verso la casa di uno zio, in Svizzera. Ma il parente non c’è, è proprio al funerale del tutore e – dice Robert – “io sono più o meno abbandonato a me stesso, con tutti i miei pensieri continuamente rivolti a Ungenach, alla sua liquidazione, donazione, eccetera”.
Pubblicato in Italia per la prima volta da Einaudi nel 1993, torna ora per i tipi di Adelphi nella stessa traduzione di Eugenio Bernardi. È un romanzo breve, di poco meno di cento pagine. Come il libro gemello al negativo, Amras del 1964, racconta di due fratelli e della dissoluzione di un universo familiare, simbolo del crollo di un’intera civiltà. In Amras i due congiunti si sono rinchiusi in una torre, “al tempo stesso prigione e rifugio” (Luigi Reitani), dopo il suicido dei genitori; qui Robert e Karl sono fuggiti in angoli lontani del mondo, ma restano attratti da quel luogo infame, Ungenach, come da un’odiosa calamita.
Il ritorno di questo libro sugli scaffali va a colmare un vuoto e testimonia come la lettura delle opere dello scrittore austriaco stia diventando di moda. Bernhard gode infatti in questo momento di una buona e per certi versi sorprendente fortuna in libreria, forse anche grazie alle dimensioni ridotte delle opere presentate da Adelphi e in virtù probabilmente del suo sguardo disincantato, provocatorio, umoristicamente abrasivo su un mondo appena passato che mantiene le caratteristiche del nostro presente, facendo presagire il futuro che ci aspetta.
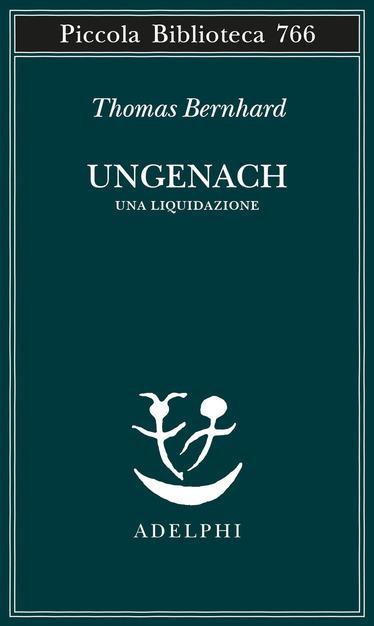
La data di prima pubblicazione da Suhrkamp aiuta a collocare il romanzo: 1968. E lo stesso fanno alcune riflessioni, non di Robert ma del notaio Moro, nella prima parte: sul vuoto della storia – dice – si crede di stendere il cemento della rivoluzione – una frase del “signor tutore”, dice –… l’espressione “uso della violenza” ricorre continuamente nelle colonne degli articoli di fondo… “comunque l’umanità intera vive già da tempo in completo esilio, si è cerimoniosamente congedata dalla natura”… “lei vede che l’Europa si è messa un’altra volta il berretto da buffone… bisogna proprio che la melma passi un’altra volta sopra di noi… ogni venti o venticinque anni”… “dappertutto imperversano queste malattie infettive pseudo politiche”… Eccetera.
Anche questo come gli altri romanzi di Bernhard è composto di voci che si intrecciano, che riferiscono di altre voci, che costruiscono un mondo di opinioni, non di verità, e molto spesso solo di sospetti, di illazioni, di incertezze. Parla Robert, all’inizio, ma poi riporta i discorsi del notaio Moro, un vecchio amico di famiglia, da cui si è recato per liquidare l’immensa proprietà, dopo la morte del fratello, fuggito da Ungenach in Africa, come lui si era rifugiato negli Stati Uniti, dopo la morte del padre, della matrigna, ora del tutore, il deserto delle vecchie relazioni di Ungenach. Parla, Robert, cerca i frammenti degli scritti del fratello, lettere mai spedite, ricordi mai condivisi, fogli di silenti richieste di aiuto vergati da Karl, sfuggito a Ungenach verso un lavoro pratico, in Africa. Mentre lui, Robert, a Stanford insegna chimica.
Arriviamo subito alla fine, alla conclusione. Lo spoiler – crimine letterario principale di questi tempi dove la forza della scrittura risiede solo nella trama, diventando un dato puramente commerciale, di intrattenimento – lo spoiler in Bernhard è assolutamente legittimo, perché la fine è annunciata nelle prime righe e ossessivamente corteggiata in tutta l’opera: in fondo non si può fare altro che ripetere, ripetere, esplorare gli interstizi tra idee fisse e situazioni prevedibili per provare a cercare una verità irraggiungibile:
La nostra indole tende all’anarchia. Tutto in noi desta continuamente sospetto. Dove c’è l’imbecillità, dove, dove non c’è, è tutto intollerabile. Il mondo, da qualsiasi parte lo guardiamo, in fin dei conti è fatto di cose intollerabili. Sempre più intollerabile è per noi il mondo. Se sopportiamo l’intollerabile è per l’attitudine di ciascuno di noi a tormentarsi e a soffrire per tutta la vita, sono un paio di elementi ironici dentro di noi, un idiotismo irrazionale, tutto il resto è calunnia
Che sembra, l’ultima frase, una variante del “tutto il resto è silenzio” di Amleto.
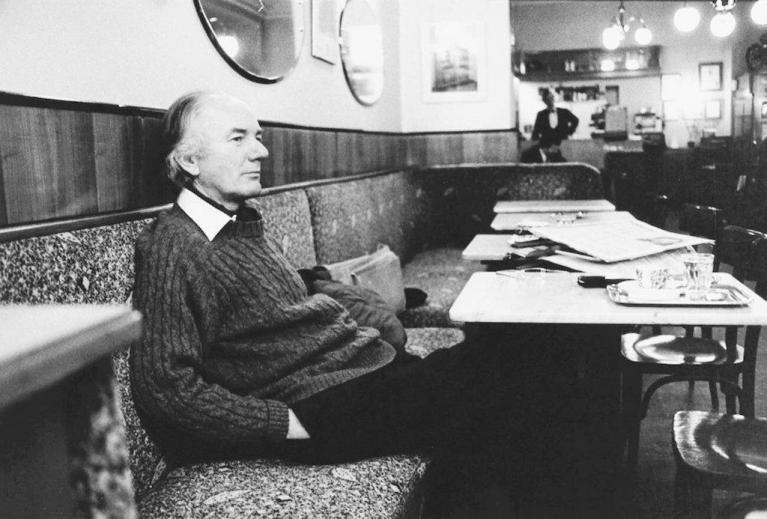
Cosa fa Robert di questa vita insopportabile, che il fratello soccombente, Karl, scappando da Ungenach aveva stigmatizzato nei suoi inani scritti, mai spediti, come dominio del terrore prodotto dal caso, in cui l’infelicità è un’abitudine e la morte è dentro la vita? Cosa fa Robert, che scrive: “La causa della mia morte è dentro me stesso”? Liquida la proprietà, donandola, regalandola, dividendola, suddividendola tra un gran numero di persone, a caso, con un criterio perfido che non sceglie nessun criterio, provando a riscattare l’orrore vissuto, l’impotenza di una vita dominata, trasformandosi in una specie di Dio, o almeno di demiurgo, che distribuisce capricciosamente, senza guardare ai meriti o ai demeriti, i propri doni o i propri anatemi. È questa, come nei Pugni in tasca di Bellocchio, la ribellione sessantottesca, tutta privata, senza illusioni millenaristiche, tutta giocata nell’ambito familiare, tutta contro l’istituzione primaria, quella che forgia e incrina la personalità. La famiglia, come altre istituzioni tradizionali, illudeva forse nel passato sulla possibilità di felicità: deprimeva per Robert (e per Bernhard) sicuramente fin dall’origine, quando già un tempo felice – forse pre-novecentesco, forse semplicemente mitologico – risultava smarrito, per trasformarsi presto nel “teatro di tutti i nostri orrori”.
Nella prima parte del romanzo Robert riferisce il soliloquio o vaniloquio del notaio Moro, cui chiede gli scritti del fratello morto in circostanze violente. Poi introduce l’elenco della liquidazione, della caotica, casuale divisione “creaturale”, il tentativo di riscattarsi con un atto di assurda potenza dalla subordinazione psichica di una vita. I terreni vanno a fittavoli, a matti dichiarati, a criminali condannati e reclusi, i frutteti a uno che parla solo di boschi, altri appezzamenti a topi di biblioteca o ad alcolisti notori, in un beffardo catalogo di umanità inadatta, inadeguata, indegna.
Nella seconda parte del romanzo parla l’assente, il defunto Karl, attraverso quelle lettere o scritti recuperati dal fratello. Ricostruiamo, per frammenti, la sua fuga in Africa, la morte del padre, l’attesa allucinata la notte in cui il cadavere, come nel racconto L’italiano, come in Estinzione, era stato esposto nel casino di caccia della grande proprietà. Racconta il senso di oppressione, l’inquietudine, il vuoto di quel luogo tribunale interiore:
Mi metto la giacca, mi tolgo la giacca, mi metto i calzoni mi metto la giacca, mi tolgo i calzoni, mi metto i calzoni, mi metto il cappotto, mi metto le scarpe, mi tolgo il cappotto, mi tolgo le scarpe, mi tolgo la giacca, mi tolgo i calzoni, eccetera.
In fondo la stessa cosa, con un sorriso grottesco di angoscia, della liquidazione.
proprietà che fanno ammalare. Dover trascorrere l’esistenza, o addirittura meditare in un ambiente odioso significa inquietudine, significa continuo scontro con ciò che è ripugnante, contronatura, con l’ingiustizia, con il caos, per quanto riguarda la natura: con la sua patologia di morte, per quanto riguarda gli uomini: con il loro dilettantismo esistenziale.
Un tale bombardamento nichilista può essere la chiave di un certo successo oggi di Bernhard? Come un controveleno, un antidoto ai nostri tempi apparentemente ottimisti e spensierati, nonostante le sciagure recenti, in realtà profondamente materialisti e sfiduciati. Con in più una caratteristica spiccata: il piacere assoluto nella lettura di un testo che fa respirare, senza una trama di colpi di scena obbligatori, di consolatori finali lieti, di personaggi apparentemente a tutto tondo inseriti in vicende lineari, come la maggior parte degli scritti di oggi. Qui, senza una trama, per sovrapposizione di voci, per frammenti e accumulo di ossessioni, la lettura diventa piacere dello scavo, riflessione attraverso maschere ciniche o deprimenti, marcate nelle profondità dei rapporti di possesso, di dominio, con la morte che diventa non intrattenimento da fumettone noir ma punto di crollo, trasformazione e perdizione.
Thomas Bernhard, Ungenach. Una liquidazione (trad. di Eugenio Bernardi), Adelphi, pp. 98, euro 10









