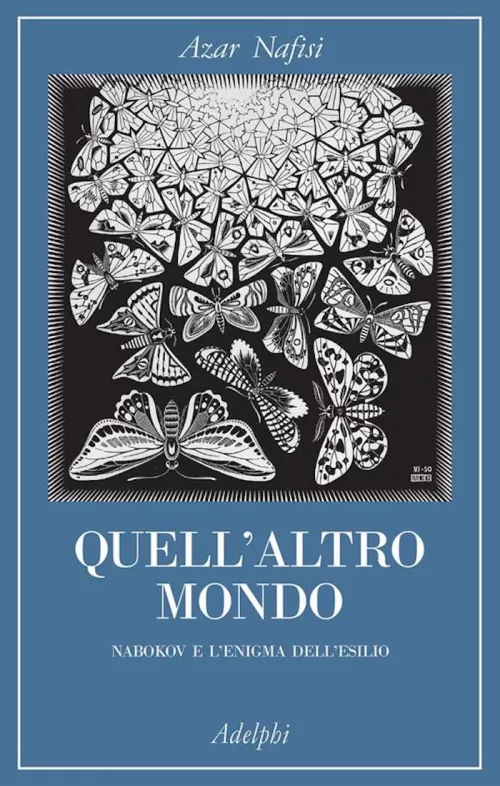L'Iran di Azar Nafisi: diritto all’immaginazione
“Che cosa sono l’uomo o la donna la cui unica arma sono le parole? Cosa c’è in queste parole da renderle così pericolose che alcuni degli uomini più potenti della Terra, con esercito, armi e persino armi nucleari, non possono vivere in sicurezza sapendo che queste persone, costoro – gli scrittori esistono?”.
Così all’indomani dell’aggressione a Salman Rushdie, la scrittrice Azar Nafisi aveva rilanciato il tema della libertà d’espressione rivendicando il ruolo di chi, malgrado tutto, si ostina nel racconto della verità.
E mentre le proteste incendiano l’Iran dopo la morte di Mahsa Amini, 22 anni, arrestata dalla polizia della morale per non aver indossato correttamente il velo, ancora una volta la sua voce risuona in difesa della libertà e del diritto all’immaginazione, così rischiosa per i regimi totalitari fondati sulla menzogna.
In esilio dal 1997, Nafisi ha vissuto sulla sua pelle, come donna e intellettuale, il brutale attacco ai diritti e all’individualità messo in atto dalla Repubblica islamica e l’ha posto al centro del suo lavoro fin dal primo libro, Quell’altro mondo – Nabokov e l’enigma dell’esilio (Adelphi, trad. Valeria Gattei, 448 pp.), da poco in traduzione italiana con un’introduzione aggiornata dell’autrice.
Pubblicato in Iran nel 1994, prima che la scrittrice emigri negli Stati Uniti dove da allora vive, è il volume che precede e prepara il celebre Leggere Lolita a Teheran (2004), il memoir che proietta l’allora sconosciuta Nafisi nelle classifiche di vendita internazionali e le regala una notevole popolarità.
Letto in retrospettiva, è un esordio carico di presentimenti. Vi si ritrovano i temi che segneranno la successiva ricerca dell’autrice e in una progressiva messa a fuoco si vede il suo futuro prendere forma – anche lei come Nabokov destinata all’altrove, alla fatica di un’identità a pezzi e a un confronto serrato con la lingua e la letteratura.
In reazione al classico saggio letterario, Quell’altro mondo racconta lo scrittore attraverso le diverse dimensioni dell’esilio partendo dal vissuto della stessa Nafisi in una dittatura. Ma se leggere Lolita a Teheran è rischioso, scriverne può esserlo ancora di più. Il primo incipit che viene in mente all’autrice, quello che giustifica tanti passaggi, è fuori discussione. “Il primo libro di Nabokov che ho letto è stato Ada. Me lo aveva regalato Ted, il mio ragazzo, con la dedica: ‘Per Azar, la mia Ada. Ted’”.
Oggi suona scontato ma nella Repubblica Islamica una frase del genere non è pubblicabile, ricorda Nafisi nell’introduzione. “Non solo il dissenso e la critica politica, ma anche la dichiarazione pubblica delle passioni sregolate dell’amore giovanile, o dell’amore in generale, erano proibiti”.
Scartata la prima persona, che sarà la formula di Leggere Lolita a Teheran e la ragione del suo successo, l’intreccio fra vita e letteratura si sposta dunque sul piano dello spaesamento e straniamento.
Mentre scrive, l’autrice come tanti compatrioti sente il terreno franare sotto i piedi. È la vita in un totalitarismo, dove lo spazio dei diritti si restringe a vista d’occhio e le regole si fanno sempre più insensate e feroci – uno stato di sperdimento e solitudine, alienazione e perdita.
Nel caso di Azar Nafisi, il dato biografico rende la percezione ancora più acuta. Nata a Teheran in una famiglia colta e benestante – il padre era stato il sindaco più giovane della città e la madre una delle prime donne elette in Parlamento – ha lasciato il paese adolescente per studiare in Inghilterra e poi in America. Quando nel 1979 fa ritorno, un anno dopo il cambio di regime, scopre che tutto è cambiato.
La repubblica dei mullah ha cancellato i diritti, la cultura e lo stile di vita in cui è cresciuta. Per un breve periodo insegna inglese all’università Teheran ma quando rifiuta di indossare il velo è espulsa.
È l’inizio di una presa di coscienza dolorosa. “La confisca della storia iraniana – scrive nell’introduzione – la perdita della mia identità come persona con determinati princìpi e convinzioni (come donna, insegnante, scrittrice e lettrice) mi faceva sentire orfana, senza una casa, nell’amato paese dove ero nata. Non era solo una questione politica, era ormai esistenziale”.
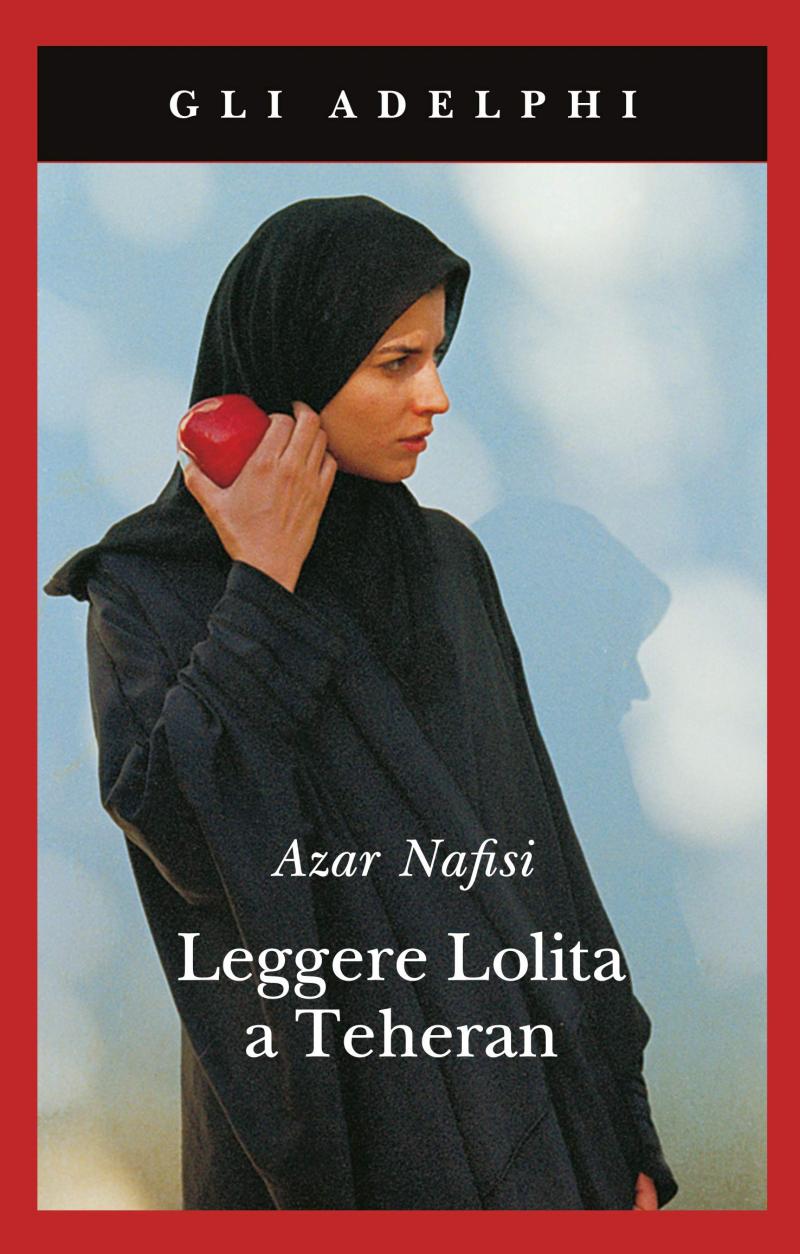
Il rimando a Nabokov diventa presto ineludibile. “Per lui l’esilio non era solo una migrazione fisica. Spesso i suoi protagonisti erano stranieri, in esilio vero e proprio, o esiliati a casa loro, e vivevano un’esperienza di irrealtà, abbandono, isolamento. Personaggi come Cincinnatus e Krug erano stranieri ed esuli nel loro paese, in circostanze simili a quelle che molti di noi conoscevano nella Repubblica islamica”.
In questa dimensione, l’arte e la letteratura non rappresentano un lusso ma una necessità. Sono una boccata d’ossigeno, l’affaccio su un mondo fondato su regole e valori diversi, una chiave per capirsi e capire. “Quando sono diventata cittadina americana – dirà la scrittrice – mi sono resa conto che avevo già una seconda nazionalità, come cittadina della Repubblica dell’Immaginazione, quella grande e irreverente comunità di lettori che non ha bisogno di passaporto per prendere il volo, attraversare le frontiere e condividere un linguaggio comune”.
È il doppio esilio, artistico e geografico, che segna l’identità di Nabokov. Lo scrittore lascia la Russia giovanissimo, vive a Berlino e in Inghilterra, trascorre vent’anni negli Stati Uniti e altrettanti in Svizzera. È una vita in costante transizione, un dialogo incessante di luoghi e lingue, un travaglio creativo che come pochi altri illumina l’oscillazione lacerante fra smarrimento e rinascita che caratterizza le scritture dell’espatrio e delle migrazioni.
In America, Nabokov sperimenta una dolorosa perdita di ruolo e identità. A differenza di altri émigré non si rifugia però nel rimpianto del mondo perduto, rifiuta di farsi vittima e si ricrea nella nuova lingua: l’inglese in cui scrive i suoi capolavori. Non è una scelta scontata per uno scrittore che fino allora ha considerato il russo la sua “casa portatile” e non si nasconde i limiti che comporta. “Ho dovuto abbandonare il mio idioma naturale, la mia lingua russa così ricca, così libera, così infinitamente docile, per una marca di inglese di seconda qualità”, dirà con una punta di civetteria.
È una svolta ormai entrata nel mito letterario e un’ispirazione per tanti autori in esilio – Alexandar Hemon, bosniaco e padre di origine ucraina, che scrive in inglese, racconta ad esempio di aver imparato leggendo Nabokov e compilando liste di parole sconosciute.
Benché spesso se ne parli come di un caso unico, è piuttosto “un caso speciale”, come nota il grande scrittore Norman Manea, che arrivato esule in America a 54 anni, senza sapere l’inglese, continua a scrivere in rumeno. “A 16 anni era già all’estero, veniva da una famiglia molto ricca e fin dalla più tenera età aveva insegnanti di tedesco, francese e inglese ancora prima di avere imparato il russo. Lo si cita a esempio di scrittore che ha cambiato lingua ma non è davvero l’esempio migliore”.

A rendere straordinaria la sua traiettoria è invece la capacità di reinventare in letteratura il suo nuovo mondo. Perdere tutto può essere anche una grande liberazione e l’America, che pure in tanti modi lo ferisce e offende, gli regala una nuova apertura. “A Nabokov, proprio in qualità di scrittore e scienziato, l’America giovava: freschezza, enfasi sul concreto e sul reale, vastità e varietà, innocenza e ignoranza, immaturità e intensità, volgarità e profondità nascoste”, scrive Nafisi.
“Amo questo paese”, dirà lui. “Accanto a precipizi di assoluta volgarità, qui ci sono vette sulle quali si possono organizzare meravigliosi picnic con amici che ‘capiscono’”.
La lacerazione dell’esilio si ricompone così in un’esplosione creativa memorabile. Se Pnin, la risposta di Nabokov a Don Chisciotte e il libro che lo rende famoso degli Stati Uniti, porta in scena la crudeltà, l’autocompiacimento e i filisteismi del suo paese d’adozione, Lolita (“la mia storia d’amore con la lingua inglese”) compone un ritratto folgorante dell’America.
Vi si ritrovano il kitsch di certi ambienti suburbani, la vitalità della sua gente, il consumismo e le pubblicità in technicolor, lo squallore dei motel e la meraviglia dei paesaggi senza fine. Sono gli scenari dei viaggi di Nabokov, appassionato entomologo, che ogni anno insieme alla moglie Vera macina miglia su miglia in cerca di farfalle. È l’America vista da un outsider che spinge lo sguardo oltre la facciata delle convenzioni e fa sua quella realtà così altra e diversa. “Mi ci sono voluti quarant’anni per inventare la Russia e l’Europa occidentale e adesso mi trovo ad affrontare il compito di inventare l’America”, scriverà Nabokov nella postfazione e poche invenzioni letterarie sono state così dirompenti.
Dopo Lolita o Pnin è impossibile guardare all’America con gli stessi occhi ed è la ragione, sostiene Nafisi, per cui ancora oggi è necessario tornare alle sue pagine. “Quanto è importante Nabokov per questa società in un’epoca di crisi così profonda? La risposta è semplicissima: ogni volta che siamo obbligati a giustificare la necessità dell’immaginazione e delle idee abbiamo già dimostrato di averne bisogno più che mai – ragion per cui abbiamo bisogno di Nabokov”.
Dove l’autoritarismo fiorisce la libertà della parola, dei diritti e della fantasia diventano armi micidiali. L’ha dimostrato a sue spese Salman Rushdie, lo confermano ogni giorno gli scrittori, i poeti, i giornalisti e gli attivisti che finiscono sotto attacco e ce lo ricorda la morte insensata di Mahsa Amini.