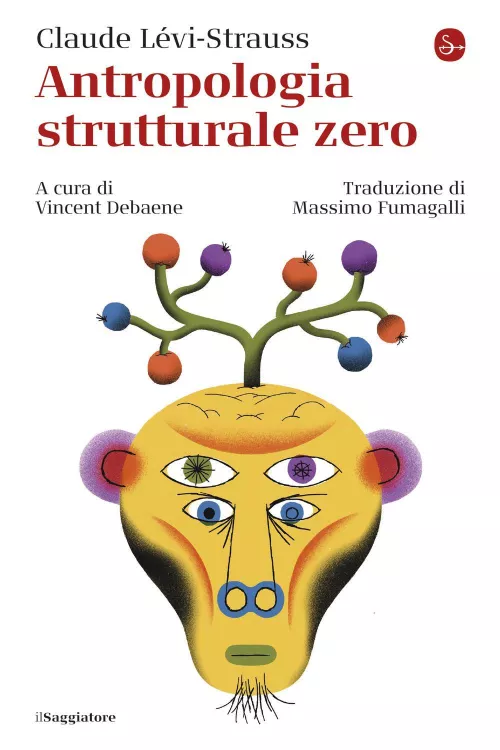Antropologia del presente / Lévi-Strauss e gli scoiattoli
Il resoconto di viaggio negli Stati Uniti è un affermato topos letterario del Novecento: scrittori, filosofi, scienziati, ma anche grafici e artisti, cineasti e sociologi hanno scritto dei loro viaggi in America, con toni variegati e interpretazioni assai diverse, gestendo non senza difficoltà una comune, curiosa mescolanza di meraviglia e ribrezzo, perversa fascinazione e critica feroce. La percezione di un mondo al tempo stesso occidentale e altro, modello da perseguire ma insieme da respingere, ha causato non pochi traumi alla veterana intellighenzia europea, scuotendola dalle millenarie sicumere di un razionalismo tanto raffinato quanto miope, tutto costruito sull’implicita certezza della supremazia antropologica del Vecchio Continente (e già chiamarlo così non è innocente) su tutti gli altri. L’intellettuale europeo a New York – e ancor di più quando si reca nel Tennessee o in California, a Salt Lake City come a Las Vegas – è una figura per certi versi stereotipa, sempre pronto ad alzare il sopracciglio dell’ironia dinnanzi alle patenti contraddizioni della società americana, ma subito dopo ad abbassarlo, quel borioso sopracciglio, grazie al mai sopito sospetto che la semplicità dell’american way of life mal nasconda originali sistemi di senso e di valore, forme di vita e dispositivi politici tutti da capire. Tanto pervasivi quanto problematici.
Ritroviamo nel bel volume Antropologia strutturale zero di Claude Lévi-Strauss, uscito tre anni fa in Francia per la cura di Vincent Debaene e appena tradotto nel nostro paese da Massimo Fumagalli per Il Saggiatore (pp. 327, € 38), un densissimo saggio che va iscritto d’ufficio in questa specie di genere letterario. Quando a volgere lo sguardo verso la cultura americana è un antropologo di questo calibro, le notazioni turistico-sociologiche meritano un’attenzione ulteriore. Per quanto risalenti agli anni 40, quando il futuro autore di Tristi tropici e del Pensiero selvaggio riparò negli Usa per sfuggire al nazismo imperante, queste poche pagine intitolate “La tecnica della felicità” non hanno perduto né d’attualità né di interesse. Anzi, forse, lette oggi ne acquistano ancora di più. Del resto, è proprio Lévi-Strauss ad averci insegnato, senza possibilità di replica, che l’idea stessa di supremazia antropologica è un odioso ossimoro.
Le osservazioni di Lévi-Strauss sugli Stati Uniti sono a 360 gradi, ora discutendo le grandi dimensioni della cultura (politica, religione, parentela etc.) ora soffermandosi su oggetti, gesti, comportamenti della vita quotidiana (dai grattacieli agli scoiattoli nei parchi, dalle gomme da masticare all’igiene corporea…) a partire da uno sguardo – com’egli stesso lo definirà – da lontano, e cioè da una prospettiva eminentemente antropologica che mette insieme etnologia ed etnografia, complessi modelli sociali e segni minuti della quotidianità. Se Antropologia strutturale zero, come chiarisce il curatore nella lunga introduzione, mostra un giovane Lévi-Strauss al lavoro, tra recensioni, schede, interventi a caldo, lunghi e dettagliatissimi resoconti sugli usi e i costumi di una serie di popolazioni cosiddette primitive (soprattutto amazzoniche), questo scritto non è da meno. E difatti inaugura, senza saperlo, quella che diverrà l’antropologia del contemporaneo, sia nella versione semiologica delle Mythologies di Roland Barthes, sia in quella, diciamo così, più poetica praticata successivamente da Marc Augé (che di Lévi-Strauss è stato non a caso allievo diretto) e dai suoi innumerevoli emulatori, sia, non da meno, nelle parodie che proponeva Umberto Eco nel Diario minimo quando immaginava etnologi aborigeni entrare a San Siro, alquanto increduli, la domenica pomeriggio.
Il punto di partenza dell’analisi lévistraussiana è tanto chiaro quanto inaspettato: se pure generalmente si pensa che nelle comunità tradizionali più o meno arcaiche la pressione sociale sul singolo sia più forte che in quelle sedicenti evolute, osservando la cultura statunitense ci si trova costretti a invertire la relazione: qui i grandi modelli culturali soggiogano il soggetto al punto che “la vita del gruppo sembra essere diretta da un determinismo che supera le coscienze individuali, e che l’individuo comprende più facilmente dall’esterno di quanto non faccia partendo dal proprio punto di vista interiore”. Altro che regno dell’individualismo; altro che regime liberale dove l’iniziativa individuale, affermandosi euforicamente, costruisce insieme agli altri il grande sogno americano. Nelle società giovani, spiega l’antropologo, il gruppo ha sempre la meglio sul singolo, il quale deve adattarsi a leggi che, trascendendolo, egli può osservare e, sperabilmente, comprendere, solo estraniandosi da esse. Sebbene in USA convivano, mescolandosi, due opposte forme di folklore – una di derivazione europea (thanksgiving, spirituals, Halloween etc.) e l’altra prodotta dalle apocalissi urbane (Chandler e Hammet, lo swing, certa Hollywood..) –, “la civiltà americana resta ugualmente, e ancora oggi, sottomessa al fatalismo dell’esteriorità; talvolta meravigliata, talaltra spaventata, essa si scopre ogni giorno dal di fuori”. Come dire che, appunto, ognuno deve adattarsi alle leggi sociali, pena l’esclusione, l’isolamento, il ghetto eterno.
Non si spiegherebbe altrimenti, per esempio, il fatto che in America i contadini generalmente non si nutrono dei frutti della terra, ossia del loro lavoro, ma delle conserve che da quei frutti derivano: come dire che viene prima l’industria alimentare, e solo dopo una vita agricola che la foraggia. Analogamente l’industria non produce beni che soddisfino i desideri della gente perché, prima ancora di produrre qualsiasi cosa, essa plasma quei desideri, costruisce i consumatori e le loro (apparenti) aspirazioni. Stesso ragionamento per la vita politica, dove il governo è quasi sempre in posizioni più avanzate rispetto all’opinione pubblica, dovendola in vario modo formare, educare, dirigere e non, come ci si sarebbe aspettato, controllare o contenere. Ancora una volta, non ci sono istanze dal basso che non siano previste in anticipo, di modo che ogni forma di libertà – rivendicata di continuo – è l’apparenza di se stessa, l’individuo surrettiziamente adeguandosi a quanto si chiede da lui.
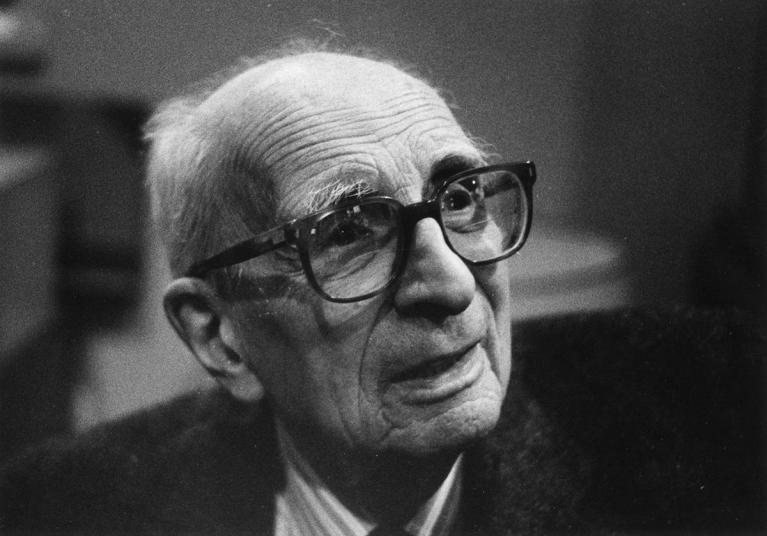
Da questa inversione delle dinamiche legate all’appagamento dei desideri scaturisce quella che Lévi-Strauss chiama tecnica della felicità, ovvero tutta quella serie di espedienti che mirano alla più rapida integrazione possibile dell’individuo al gruppo. Non bisogna far attendere nessuno, tenerlo in sospeso, men che mai insinuare dubbi o sospetti che le cose possano essere diverse da come sono. I bisogni devono essere basici, i desideri prevedibili, le soddisfazioni a portata di mano. E, per far sì che ciò sia sempre possibile, occorre fare d’ognuno un eterno bambino. Laddove in ogni società, semplice o complessa che sia, l’adulto, affermandosi, porta con sé la ferita dell’infanzia perduta, in America non c’è alcun reale rito di passaggio, alcuna sofferenza necessaria per diventare membro della società perché lo si è già da subito, in quanto bambino un po’ cresciuto ma pur sempre con la mentalità, i valori, le istanze, le facili rivendicazioni di un adolescente. Così in Usa la donna è e resta sempre, in qualsiasi situazione, una mamma (mom), così come l’uomo sempre un papà (dad). Vige nel cittadino, anche se ha idee diverse, una deferenza quasi sacra nei confronti del governo, come anche del boss dell’azienda presso cui è casualmente impiegato. Ai suoi occhi non si tratta di persone gerarchicamente superiori ma, più semplicemente, dei ‘grandi’ cui occorre per principio obbedire, come genitori cui bisogna portare filiale rispetto.
Tutto, in tal modo, si tiene: il baseball è meno uno sport che non un gioco infantile; il drugstore è la materializzazione dei castelli delle fiabe; i comics affascinano indifferentemente chiunque; per non dire dell’automobile che, sogno palese d’ogni americano, è la realizzazione spostata dalla piccola capanna che, con materiali di risulta, tutti i bambini costruiscono alla meno peggio nella loro stanzetta. Qualsiasi cosa diventa semplice, a portata di mano, gadget di se stesso. Facilissimo diventare belli, essere magri e slanciati, gestire l’igiene personale, conversare in salotto, essere un nice guy: tutto è raggiungibile senza troppi sforzi e, a supporto, c’è un manuale di istruzioni per qualunque cosa, sia essa un banale passatempo o un serioso impegno della vita. Il sogno americano è sempre a due passi: basta stare attenti a non urtare nessuno, a non ferirlo, a non provocargli un qualche tipo di choc. La buona educazione innanzitutto: e a nessuno è consentito di commettere marachelle. Meglio una gomma da masticare perennemente in bocca, segno di un peccato veniale collettivo, tollerato perché spia di una psicologia spicciola, quella di chi vuole rilassarsi prima ancora di capire perché potrebbe esser nervoso.
E possiamo continuare, saltellando qui e là ma ritrovando in sottofondo la medesima prospettiva consolatoria: la psicanalisi americana “non è tanto spinta del malato verso la libertà bensì accompagnamento alla felicità”; la sociologia è fondamentalmente ottimista perché dimentica di associare la gratificazione materiale alla semplificazione dell’esistenza quotidiana; e in generale qualsiasi lavoratore, in qualsiasi settore eserciti la propria attività, è sempre pronto a dimostrare che per ogni problema c’è comunque una soluzione. Il mito del problem solving, in America, è esperienza vissuta, retropensiero costante, valore collettivo. Una collettività stramba, che antepone al benessere del singolo quello del gruppo, anche quando si tratta di far promozione della propria azienda. Lévi-Strauss osserva con stupore che, in tempi di guerra, le pubblicità – negazione freudiana? – invitino il consumatore a non comprare i loro prodotti ma a investire nei titoli di stato, anteponendo ancora una volta le necessità della Nazione a quelle personali. Insomma, la tecnica della felicità, adottata sin nei più intimi particolari, funziona sempre. “Il suo simbolo più evidente – scrive con grande, stravagante acutezza Lévi-Strauss – è forse fornito dalle migliaia di scoiattoli che popolano i giardini pubblici americani, e la cui sensazione di totale sicurezza tra i visitatori sarebbe la dimostrazione, fino al giorno del Giudizio, di un’infanzia priva di qualunque malizia, di un’adolescenza priva di odio, di un’umanità priva di rancore”.
In questa società dove Cip e Ciop sono dunque i protagonisti taciti, roditori saltellanti tanto carini quanto inutili, la felicità resta, ne conclude Lévi-Strauss, al solo livello dell’individuo, che realizza regolarmente i propri desideri preconfezionati senza di fatto trasformare alcunché della propria realtà esistenziale e politica. Sarà felice il singolo, forse, mai il gruppo cui appartiene, le cui leggi di funzionamento restano sempre uguali. Siamo tutti amici, tutti reciprocamente simpatici (ehi, man!), come scoiattoli sull’albero che accumulano noccioline, ma nulla deve disturbare le regole generali di una società che, dal canto suo, è anzi straordinariamente competitiva. La brutalità degli scioperi e delle serrate è nulla, in questo contesto, rispetto ai conflitti di genere e, soprattutto, a quelli razziali. Tanto più si è felici singolarmente, quanto più si è costretti collettivamente in un mondo che non lascia alcuna reale possibilità di scelta. L’affermazione dell’individuo, quando avviene, è circoscritta, contenuta, non superando mai la dimensione della notorietà locale, sia essa quella del quartiere o del club, dell’istituzione scolastica o universitaria. “A scuola come al college, la preoccupazione maggiore è di essere popular, ossia di avere molti amici, degli appuntamenti, una folta rubrica”.
Ecco spiegata la genesi, e la forza, di Facebook.