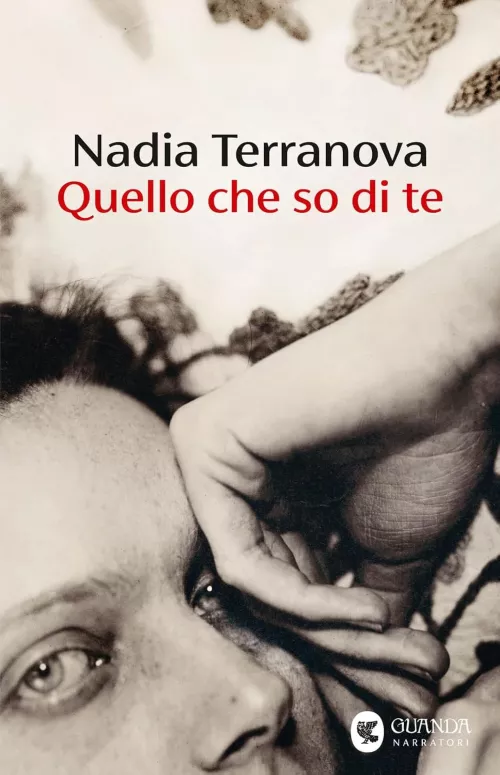Nadia Terranova: bentornata, fantasma
Nel 2018 Nadia Terranova ha scritto un libro intitolato Addio fantasmi (Einaudi Stile Libero Big). In quel libro la protagonista, Ida, tornava nella sua città natale al di là del mare per raccontare una trama al cui centro stava un buco, uno strappo. Era così, Addio fantasmi: tessitura di una storia attorno a un punto che sfugge. Il fantasma, il centro che non è centro, era un padre che non c’era più. Quel romanzo era la prova letteraria di una scrittrice già matura, capace di attraversare con grazia il grumo della perdita, le tempeste di sabbia di certe famiglie scheggiate; capace di sorvolare il cratere del vulcano con la lingua della poesia (l’esergo scelto per Trema la notte, il libro che sarebbe venuto dopo, era una frase di Giovanni Pascoli sullo Stretto di Messina e Reggio Calabria: “Qui è dove quasi distrutta la storia, resta la poesia” – nel mare fiabesco di Cola Pesce fiorisce l’alga acquatica della parola).
Anche la protagonista di Quello che so di te (Guanda 2025), romanzo con una matrice più evidentemente autobiografica (autofiction?), fa ritorno sull’isola oltre lo stretto, a Messina, posto di spettri che parlano il lessico familiare; quasi come Ida ha bisogno di guardare in faccia un ricordo lontano, scrutarlo da vicino, indagarlo attraverso la lente amorosa della letteratura: “Non basta sognare il passato, bisogna andarselo a prendere”.
Chi dice io in questo romanzo è una donna appena diventata madre che osserva sua figlia mentre dorme nella culla. Nata di marzo, creatura nuova, guarda la madre ma non guarda davvero, è ignara del mondo: “In quel momento capisco cosa non potrò più permettermi di fare. Impazzire.”
“C’è nella maternità uno strano potere” scrive Woolf nell’esergo al primo capitolo di questo libro; direi proprio che il potere sia questo: nel generare la vita lo sguardo si sdoppia – da una parte va verso il futuro e dall’altra cerca il passato. Se il primo motore di questa storia è la bambina, luna del futuro, il motore zero è l’antenata, la radice: una donna cui si dà il nome di Venera, la bisnonna della protagonista, internata per undici giorni nell’unico manicomio di Messina nel 1928. È guardando la neonata che la madre capisce di non poter impazzire, ed è alla neonata che promette di interrompere l’eredità di Venera, “tagliare via la pazzia del nostro sangue insieme al cordone ombelicale.” Ma non è una fuga dal passato, quella della narratrice che Terranova costruisce in questo testo – esattamente come non lo era quella di Ida nel romanzo già menzionato. È piuttosto una ricerca smaniosa (la mania ha il carattere dell’irrequietezza, scriveva Daniele Del Giudice) mossa da un intimo bisogno di senso.
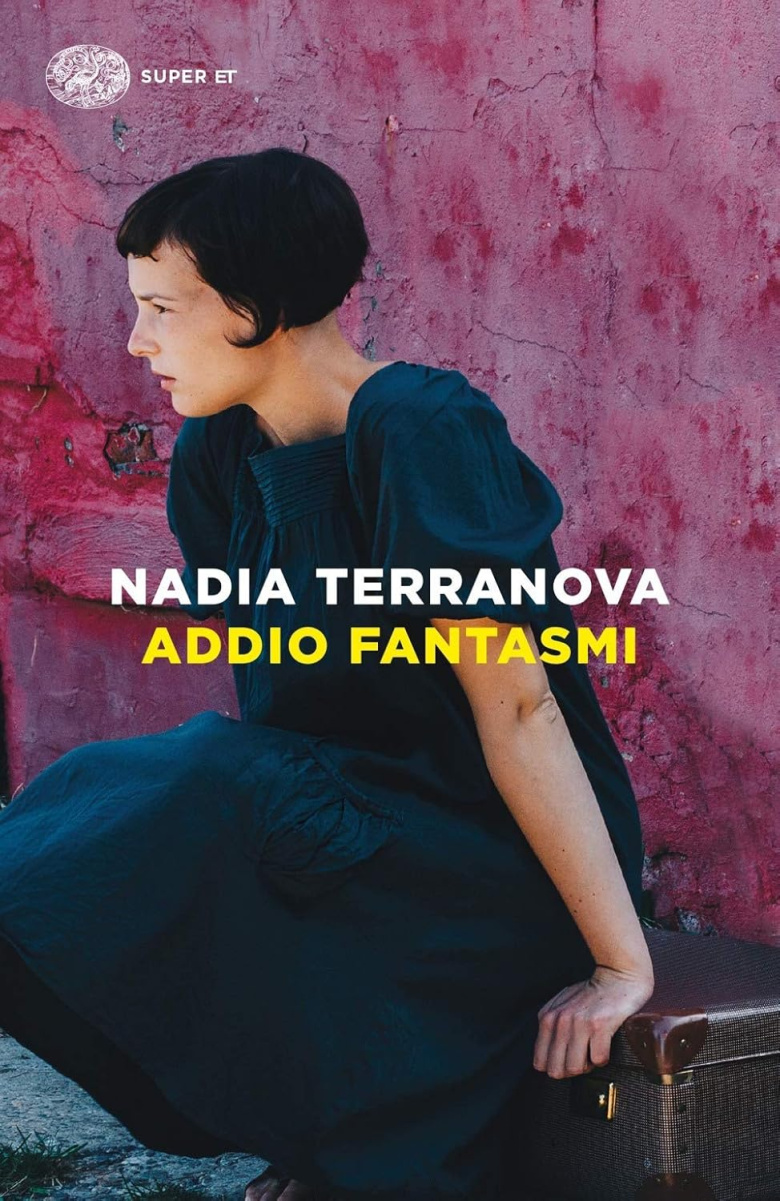
Venera, dunque, e non Venere: lo slittamento vocalico produce un nome originale estraneo alla mitologia classica, il nome di una donna che appartiene a un’altra storia, storia piccola, la Mitologia Familiare – interrogata in questo romanzo come fosse un personaggio capace di occupare il palcoscenico, pervasivo e affascinante: “La Mitologia Familiare furibonda scuote gli scaffali, un dizionario viene giù dalla libreria, mi si slega dal polso il braccialetto di ametista e cade anch’esso sul pavimento: come oso, urlano le cose tintinnanti, togliere la polvere alla storia di Venera? Deve restare segreta, solo nostra.”
Così reagisce questo coro nuovo quando la protagonista si mette in contatto con il Dottor Cavallo, responsabile dell’archivio del manicomio Mandalari. Al di qua della trama, la Mitologia è un dispositivo letterario a cui vengono affidate anche considerazioni di teoria: quanto spesso è il diaframma tra la vita e la pagina?, esistono cose che non si raccontano – la devianza, il corpo malato, il corpo della madre?
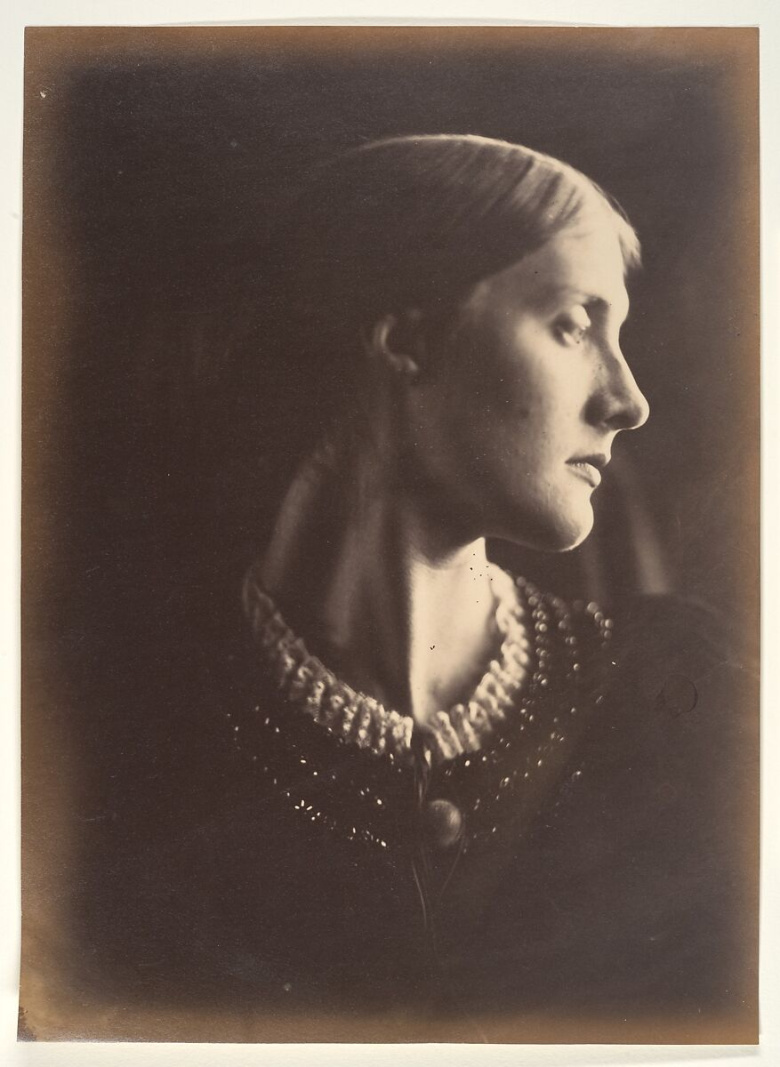
La storia di Venera occupa le pagine di questo libro intrecciandosi a un presente in cui la protagonista fa la sua personale esperienza della maternità, in un movimento speculare alla non-maternità dell’antenata allontanata dalle figlie, internata dopo un aborto spontaneo.
Alla spinta creatrice del racconto si oppone la decostruzione della narrazione consegnata dalla Mitologia Familiare – il campo viene sgomberato dagli inganni del tempo e di un dire cristallizzatosi al passaggio da una voce all’altra.
Ma quella di Venera non è una storia singolare. Il mondo evocato ha un’anima plurale, multiforme e multivoce: è una costellazione di vite irregolari, non solo di donne. “Con il crollo di mio padre, è nata la consapevolezza che i padri impazziscono e non si salvano. […] Sono stati gli occhi di sua figlia a farlo impazzire nei ruoli di marito e di genitore, i miei occhi che non avrei saputo dove altro mettere se non su di lui.” Anche la figura del padre ha un richiamo nel presente, e infatti “Spio mio marito in ogni cosa che fa. Lo spio perché la parola padre, per me, è sconosciuta.”

Lungo tutta la trama corre un filo a cui si annodano, in un nesso inscindibile, la nascita, la morte, la follia, simboleggiate attraverso l’immagine della caduta, dell’inciampo.
Non solo questo nesso costituisce l’origine della narrazione romanzesca, ma si configura come nucleo fondamentale della storia di molti personaggi: Venera varca la soglia del Mandalari dopo l’aborto avvenuto in seguito ad una caduta (“Quando Venera cade, il cadavere non è suo – è un pezzo di sé, un organo, un feto che nasce e muore insieme, una figlia che già non c’è più”). Ma c’è ancora un’altra diramazione di questa storia che porta il segno di un inciampo, anche questa volta fisico: una delle nipoti di Venera, figlia di Rinuccia, il cui nome è taciuto come in un incantesimo, è la seconda “figlia che non c’è più” di questa storia, vittima di un incidente in montagna nel marzo del 1982. “Per riprodurre la verità della sua morte, non scriverò il nome di mia zia. Non ho mai potuto pronunciarlo, messa in guardia dalle apocalissi che avrei causato.” La zia fantasma qui evocata aveva diciannove anni, le piaceva scrivere e leggere. Ancora una volta il tema della caduta fa da raccordo fra il passato e il presente: “Ho imparato ad accettare gli inciampi imbarazzanti di mia madre, la tentazione dell’abisso di Venera, il salto mortale di mia zia […] Solo, non posso accettare che a cadere sia mia figlia.”
Nadia Terranova modella in questo libro la lingua della contraddizione. Perché la malattia mentale, il materno e il femminile non si possono dire diversamente: si sta nel chiaroscuro, nel cono d’ombra delle parole del corpo. Il risultato è la prosa multiforme di Quello che so di te, capace di oscillare fra il lirismo dialettale della voce di Venera, che si esprime in messinese, e l’asciutta lingua della scienza che racconta la sua malattia mentale attingendo al lessico medico. La diagnosi dell’antenata, “psicosi istero-nevrastenica, femminile singolare”, viene tradotta in dialetto: scantàta, scattiàta, strèusa – perché “la medicina deve fare i conti con l’umano che straborda e disobbedisce al dizionario scientifico […] Per muoversi non occorrono solo studi e lauree, ma una sensibile prudenza, la capacità comprovata di non cercare solo se stessi nelle storie degli altri, l’apertura a una lingua che non esiste ancora.” Attraversare le parole fino al seme, attraversare una storia fino all’origine: l’indagine di Terranova ha il carattere rigoroso della filologia (“Filologia, lavoro pulito / Come quello del radiologo in medicina” ha scritto Vittorio Sereni) ed è mossa dall’amore per le storie, per il racconto.
Su un piano ulteriore questa voce narrante si fa mimetica, capace su un primo livello di una metamorfosi che sa assecondare il corso degli eventi: i periodi che seguono le svolte nell’indagine sono evidentemente più ritmati; ma ancora, quando la voce della narratrice diventa quella di Venera, in una sorta di sdoppiamento segnalato dal corsivo tipografico, l’andamento cambia ancora ed è quasi quello della ninna nanna popolare – “Matri, matricedda, matruzza mia, me matri, bedda matri. Mia madre a lei sì datele le bambine.”

Questo libro, io credo, è uno dei più riusciti di Terranova per molte ragioni di natura diversa. Direi innanzitutto per la complessità e le sfaccettature della voce narrante, e per il modo in cui viene costruita la storia, intreccio di mondi in bilico fra passato e presente.
Perché mette al centro una verità grande e preziosa: guardare la propria figlia e capire di non poter più impazzire significa riconoscere la propria responsabilità emotiva di genitore; non provare a risolversi – che è un’utopia – ma accettare di riconoscersi nella propria mancanza, nella propria incompletezza ancestrale. È per fare questo, d’altronde, che la protagonista di questo romanzo cerca la sua origine (femminile, plurale: il rovescio della diagnosi di Venera).
In un’intervista a La Stampa, Terranova ha detto che “Un romanzo non risponde, non arriva a nessuna verità, si risolve nel racconto”: ecco perché tornano i fantasmi, ecco perché torna Venera – non per garantire una pacificazione che sia data una volta per tutte, ma per mostrare che le storie, come la vita, sono animate da un movimento incessante di ricerca.
C’è una tessitrice all’ombra di idda (eccolo, l’altro slittamento: manca una d soltanto al nome Ida, l’altra cacciatrice di fantasmi) il vulcano femmina, l’Etna: inventa storie che annodano passato e presente, cerca la radice e guarda al futuro. È madre e figlia, nipote e sorella. Canta ancora, e mentre canta e racconta e scrive intesse reti: è proprio vero che siamo tutte, in fondo, la macchia sul viso di qualcun’altra.