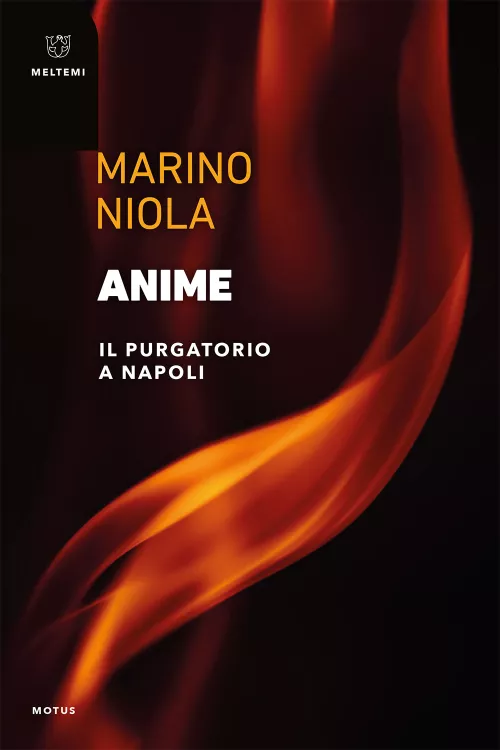Napoli: dove i vivi parlano con i morti
Nascita e morte sono categorie astratte, a segnare idealmente inizio e fine di qualcosa che, però, nell’esperienza vissuta – reale o immaginaria, tangibile o simbolica che sia – non ha tempo, non conosce scansioni millimetriche, successioni cronologiche, destini ineludibili. E dribbla, tale esperienza, ogni senso del susseguirsi inevitabile, dell’andare macchinalmente in avanti: senza posa, senza soste o ritorni all’indietro. L’emersione della condizione umana, e forse non soltanto umana, la costituzione d’ogni forma di civilizzazione o se si preferisce di cultura ha lavorato per dare alla vita e soprattutto alla morte un senso, dunque un linguaggio, un modo di esprimersi e di dire ancora, nonostante tutto, e possibilmente per sempre.
Il doppio trauma del decesso, per chi sparisce e per chi resta, s’è trovato così a negoziare con il desiderio d’immortalità, condizione fantastica dalle ricadute assai concrete, dove il campo variegato della memoria s’è fatto terreno di scontro e dialogo, di accordi e di conflitti fra percezione della fine e sogno di perpetuità. L’immaginario umano e sociale ha così moltiplicato le forme di compromesso e di ibridazione che, per il fatto d’essere assurde logicamente o impossibili scientificamente, non sono state meno operative per gli individui e le collettività. Figure come quelle del non morto e del revenant o principi come quello dell’eternità temporanea hanno, per così dire, funzionato assai bene, dando adito a speranze più o meno illusorie, a rituali fortemente praticati, a storie e leggende cui la gente ha caparbiamente creduto. Cosa che vale, con pari dignità e labili differenze di fatto, sia nella cultura popolare sia in quella d’élite – ammesso che questa distinzione abbia un qualche senso.
Così l’invenzione del Purgatorio (che da aggettivo sanitario s’è fatto nome proprio di luogo) è stata, come ha spiegato anni fa Jacques Le Goff in un suo libro geniale, una delle soluzioni più creative della cultura occidentale cattolica, non senza basilari derivazioni da culti precedenti cosiddetti pagani, e, soprattutto, con numerosissime trovate successive che, consapevolmente o meno, da quel luogo immaginario hanno preso le mosse. Il Purgatorio è spazio di redenzione violenta e di purificazione ignea, dunque di speranze tanto caparbie quanto flebili, giusto forse per tenere in contatto l’anima del defunto, più che con l’immagine divina, con le coscienze di chi quel defunto piangerà per sempre e anche dopo.
Difficile dire chi soffre di più, se i trapassati o i persistenti, in un sentimento di compassione che, alla fine, la fa da padrone: in tutte le direzioni possibili. Elaborare il lutto diviene una forma di vita o, forse, la forma stessa della vita, dove il rito funebre, segno di reciprocità umana, si prolunga ben al di là di se stesso, come una ferita che si fa cicatrice.
Il nostro folklore, se considerato in modo non folkloristico, ha in questo senso tantissimo da insegnarci, giusto in un’epoca come la nostra dove – come ricorda Marino Niola in apertura al suo bellissimo libro intitolato Anime. Il Purgatorio a Napoli (con un’antologia di testi letterari curata da Elisabetta Moro, ed. Meltemi, pagine 191, € 18) – si tende a cancellare la morte dall’orizzonte di vita, con una pretesa di longevità di massa tanto ingenua quanto vincente che fa del perire stesso, appunto, quasi una colpa.

Aldous Huxley, nel Mondo nuovo (1932), immaginava una società del futuro dove la malattia terminale e la morte erano bandite, e bisognava appartarsi in apposite strutture ospedaliere per poterselo permettere. Una distopia letteraria che si è ampiamente realizzata, ammettiamolo, come da ultimo hanno testimoniato le vittime del Covid, eclissatesi senza possibilità di ricevere l’ultimo saluto da parte dei loro cari.
E alle vittime della pandemia è dedicato non a caso il libro di Niola riguardante il culto napoletano dalle anime purganti di antichissima tradizione e tuttora presente in alcuni quartieri popolari della città partenopea. Dalle edicole votive disseminate a ogni angolo della città, arricchite con figurine di terracotta in atteggiamento estatico o sofferente, agli ipogei di moltissime chiese dentro e fuori le mura storiche, strabordanti di teschi di morti senza nome (le cosiddette “capuzzelle”), sembra che a Napoli ci sia tutta una popolazione di ombre, di spiriti dolenti che, come anime del Purgatorio, vengono adottate dai vivi in cambio di una qualche richiesta miracolosa: guarire da una malattia, vincere alla lotteria, trovare marito…
Appestati, appiccati, decollati, marinai, pezzenti, reietti della società che non hanno trovato degna sepoltura e che vagano per il mondo alla ricerca di pace e di salvezza. Il cosiddetto cimitero delle Fontenelle, gigantesca grotta-ossario che si trova sotto il celebre rione Sanità i cui cunicoli giungono fin sotto la collina di Capodimonte, straripa di crani messi in bella mostra a uso e consumo dei devoti. Costoro se ne prendono cura, danno loro un nome e un’identità (celebre per esempio la figura del Capitano, sicuro antesignano del Commendatore, convitato di pietra nel dramma di Tirso da Molina), abbreviando il tempo della pena da scontare in Purgatorio.
Ogni lunedì, da più di un secolo e mezzo, nonostante i diktat della Chiesa ufficiale che ha da sempre provato a interdirlo, parte un mesto pellegrinaggio per gli Inferi, modo per mantenere aperto il colloquio fra i vivi e i morti, i disgraziati di qua e quelli di là, in nome di un diffuso sentimento di pietà verso il prossimo e il distante. Non a caso ancor oggi i mendicanti che chiedono l’elemosina dicono di farlo non per se stessi ma per le anime del Purgatorio.
Così, ciascun fedele sceglie un’anima dolente da curare in funzione della sua attività onirica: è in sogno che le anime tornano da questa parte del mondo per chiedere sostegno, concedendo le grazie richieste loro. “Pochi snodi della cultura napoletana (scrive Niola) appaiono cruciali quanto lo è la devozione popolare che attraversa – e ne è riattraversata – tutti i piani, pubblici e privati, della vita della città: dall’ambito familiare a quello sociale, da quello individuale a quello comunitario”.
Troppo facile, e sostanzialmente fuorviante, parlare dunque di ‘residui’ di culture popolari arcaiche, come molti studiosi hanno detto e scritto. Certo, i sincretismi fra religioni, simbologie, immagini, credenze sono sempre e comunque all’opera: cosa che, appunto, turba le istituzioni ecclesiastiche. Piuttosto, argomenta Niola, è al presente che occorre guardare per interpretare e comprendere questo genere di pratiche rituali, ai sincretismi del nostro tempo, alle contraddizioni della contemporaneità, dove, appunto, i riti funebri troppo umani cedono sempre più spesso il posto ad asettiche istituzioni sanitarie.
Cosa che è stata ed è ben compresa da scrittori e artisti che ha tempo hanno guardato con sgomento e curiosità alle capuzzelle napoletane. Herman Melville visitò il cimitero delle Fontenelle già nel 1857, seguito da personaggi come Gide, Grogorovius, Herling, come anche Roberto Rossellini, che vi ambienterà una scena del suo Viaggio in Italia. Ancora: Andy Warhol, Robert Mapplethorpe, Joseph Beuys, Francesco Clemente se ne sono occupati da vicino, ripresi in questo da diverse artiste e artisti contemporanei.
Del resto, ricorda Niola, Walter Benjamin scrisse il suo Dramma barocco proprio a Napoli, “forse soggiogato da questa dimensione ipogea dell’essere, questo metaverso della socialità, dove si incrociano la vista e la visione, il sogno e la realtà, la ragione e la figura, la presenza e l’assenza, l’ethos e il pathos, il dolore e il valore”. Qui i vivi parlano coi morti, e viceversa. Fanno male? Il timore è che i turisti se ne accorgano, e scassino tutto.