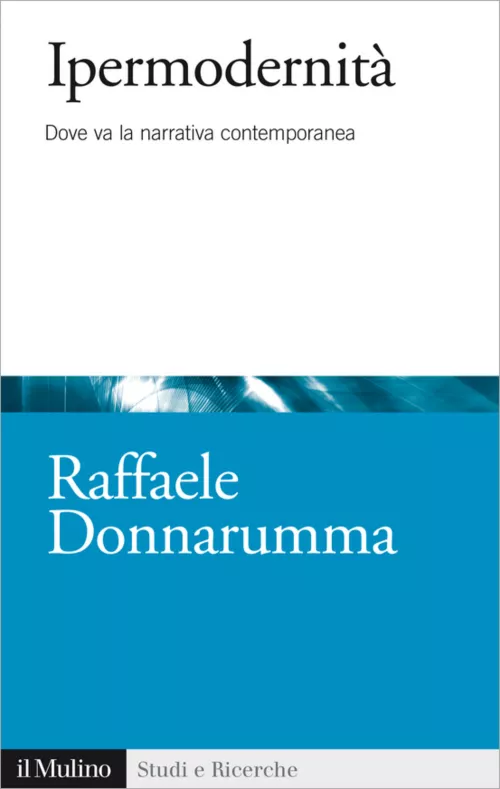Raffaele Donnarumma. Ipermodernità
Cominciate dalla fine. Per apprezzare la mossa critica compiuta da Raffaele Donnarumma in Ipermodernità. Dove va la narrativa contemporanea (Il Mulino, 2014), tradite senza indugi la metrica del testo, partendo dall’ultimo saggio (Storia del presente e critica militante. Una conclusione), che assieme al primo (Misurare le distanze. Un’introduzione) incornicia le cinque parti di cui si compone il libro (I. Postmoderno italiano; II. Nuovi realismi e persistenze moderne; III. Ipermodernità: un congedo dal postmoderno; IV. Angosce di derealizzazione. Non fiction e fiction; V. ‘Storie vere’).
Proprio ai bordi estremi di questo bilancio sulla narrativa italiana degli ultimi decenni si trovano infatti le pagine più belle, ma soprattutto più significative, perché qui l’autore ammette, con passione e «onestà» (l’ultima parola che leggiamo prima di chiudere il volume), lo spirito e gli intenti della propria ricerca: l’uno e gli altri sfidano a ripensare, anche a ridiscutere, un rinnovato concetto di critica letteraria militante.
Nel senso che la militanza non sarà da intendersi come performance, antagonismo di maniera, fenomeno di costume o forma narcisistica di contrapposizione di un great man fiero, ma, al contrario, intende porsi come ostinata espressione di inappartenenza e di inattualità, perché vuole cercare udienza rendendo ragione anziché producendo stupore o piagnistei; perché l’arbitrio, se, come è inevitabile, c’è, non è effetto di un capriccio voluto e affermato come privilegio, ma è la variabile quasi necessaria di un’idea di critica come professionalità, come “lavoro”, anche faticoso; come «sforzo di onestà», insomma.
Dentro questo concetto e questa pratica di serietà (che per una sorta di legame destinale così tanto somigliano alla categoria di realismo sviluppata nel libro), proprio la storiografia della contemporaneità si pone allora come l’esercizio tanto più paradossale quanto più autentico di critica militante.
Si tratterà, infatti, di comporre una storia del proprio presente tentando di mantenere distanza dalla storiografia come lettura unilineare e essenzializzante («se lo storico letterario generalizza, è per trovare dominanti, che, del resto, servono a far sbalzare meglio ciò che alle dominanti non si riduce»: pp. 225-226); per tentare così la strada di un’ermeneutica capace di pluralità. Ispirandosi esplicitamente a L’essere e l’evento di Alain Badiou – ma a tratti risuona anche il principio speranza, di Bloch – lo sguardo sul presente trova un nuovo, prepotente slancio di orientamento futuro: unendo teoria e storia, rinunciando al canone – anche con una disponibilità, bisogna ammettere più unica che rara, all’autosuperamento.
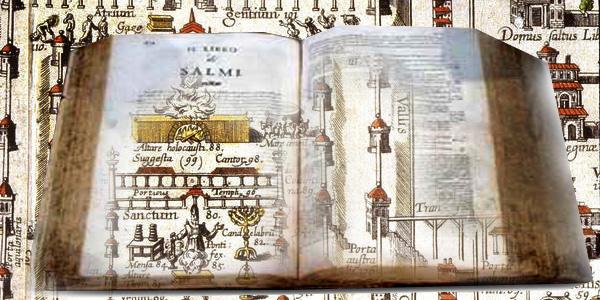
Tutto questo viene compiuto per consegnarsi alla discussione, per una forma di inattuale passione – e ideologia – del famigerato dibattito, e così anche a questo livello Pasolini esce confermato come il vero autore totemico di Ipermodernità: il demone con cui non chiudono mai i conti non solo i due scrittori più citati e discussi, cioè Siti e Saviano, ma Donnarumma stesso.
Tre, essenzialmente, sono le armi con cui il libro si butta nella lotta: attraverso il gesto radicale e il tono perentorio – che avanza per antitesi e pronuncia “perché” in maniera inappellabile; costruendo e difendendo un metodo storiografico che, recuperando una terminologia già brevettata da Daniele Giglioli in Senza trauma, profila una costellazione narrativa e cronologica attenta pressoché esclusivamente a campionature “sintomatiche”.
Non si tratta cioè di antologizzare e canonizzare, tant’è vero che sono molte, talvolta troppe, le assenze; ma di diagnosticare la presenza o meno di una costante, vale a dire, e siamo arrivati al terzo e più importante strumento di combattimento, la presenza del realismo, che consiste nella capacità di testimoniare il presente (con echi di Quel che resta di Auschwitz, di Agamben). Proprio questa fedeltà al reale diventa la linea divisoria per tracciare scarti e inclusioni – ma su questo punto torneremo più avanti.
Partendo dunque dalla conclusione di Ipermodernità si perde il gusto romanesque della scoperta di come va a finire, ma l’irriverenza gioverà a non confondere la postura ferma e l’assunzione di responsabilità (quella che distingue il discorso critico dall’astratto furore egotista), vedendone semmai il pathos – senza schiacciarlo sull’ideologia, che pure c’è: vuole esserci; e consentirà altresì di non sperimentare soltanto come riduttive certe esclusioni (per esempio: Falco, Vasta, Pugno, certa Ballestra, Sarchi, Le rondini di Montecassino di Janeczek, Quelli che però è lo stesso, di Dai Pra’, Tempo di imparare, di Parrella, o soprattutto Piove all’insù, di Rastello, che per quel che mi riguarda è la narrazione più bella sugli anni Settanta, assieme a Lettere a nessuno, di Moresco, e in parte Proprietà perduta, di Cordelli).
Seguendo meglio la traiettoria della lunga durata, non prenderemo alla lettera certi passaggi troppo veloci; o certe categorizzazioni forti (modernismo, postmoderno, realismo) che certo vanno discusse, ma nel senso che vogliono premeditatamente creare discussione – e per farlo le contraddizioni tra realtà e utopia vanno patite fino in fondo – come si dice di Petrolio (p. 56).

Ripartiamo allora da quello che mi pare uno dei passaggi forse meno evidenti ma più importanti del libro: Ipermodernità assume una volta per tutte, sistemandola con parole e argomentazioni chiare (soprattutto nel capitolo quarto) – e andando oltre la mappa eterogenea degli «oggetti narrativi non identificati» a suo tempo tracciata da Wu Ming 1 in New Italian Epic – una situazione della narrativa da troppo tempo rimasta opaca e indefinita – come già lasciava intendere anche il titolo di un saggio di Cortellessa (La terra della prosa, 2011). Vale a dire: il campo odierno della narrativa ha ancora al suo centro, certamente, il romanzo, ma questa egemonia non poggia più sull’opera di cannibalizzazione degli altri generi a suo tempo descritta da Bachtin; il romanzo non è più il genere unico che dopo aver assimilato gli altri generi domina il territorio.
Piuttosto esistono altri esperimenti di narratività non romanzesca (tra cui Affinati, Saviano, Mozzi, Sortino, Trevi, Arminio) che non si possono intendere solo come satelliti del romanzo, a cui applicare confusamente, per via di perifrasi e approssimazioni, le medesime categorie usate per il novel: non sono romanzi, non vanno valutati, nel bene e nel male, come tali. Siamo in presenza di forme ibride di volontaria alternanza di fiction e non fiction, che non presuppongono una deriva postmoderna del referente nell’infinito gioco dei significanti, ma, al contrario, intendono usare la narrativa proprio per riavvicinarsi alla realtà.
Al centro di questa rimodulazione del campo letterario si mette Gomorra, di Saviano che buca il senso comune postmoderno perché «rompe la trasformazione di ogni discorso in fiction» (p. 79); proprio discutendo le prossimità e le differenze con Pasolini, Donnarumma usa Saviano per mettere la punteggiatura, per così dire, cercando di definire, pur attraverso le cesure, una traiettoria di lungo corso. «La mia ipotesi – si legge a p. 116 – è che modernismo, postmoderno e ipermoderno siano le età culturali in cui si articola in modi diversi una modernità mutevole ma perdurante».
Per riesaminare i passaggi sintomatici del trentennio 1965-1995, il primo capitolo distingue anzitutto tra postmodernità («cioè quell’epoca storica che, iniziata intorno alla metà degli anni Cinquanta, non si è ancora esaurita»), postmodernismo («cioè quella produzione artistico-culturale […] che negli Stati Uniti ha interpretato quella svolta storica e le ha voluto dare una forma»), e postmoderno, «cioè quell’epoca culturale che, con una molteplicità di atteggiamenti e senza elaborare poetiche comuni, ha risposto ai problemi posti dalla postmodernità» (pp. 25-26), e che in Italia produce come testi più importanti Fratelli d’Italia, Hilarotragoedia, le Cosmicomiche. Su queste in particolare fatico a rimanere dentro uno scenario unicamente postavanguardistico o antiavanguardistico: Calvino rinuncia al conflitto con i fenomeni culturali nostrani non necessariamente in nome di una ritirata, ma per confrontarsi con saperi e modi espressivi situati altrove, e grazie ai quali, per esempio, le Cosmicomiche a tutt’oggi non è un libro ormai vecchio, al contrario de Il nome della rosa.
Dentro la progressiva tendenza a sottomettere la storia al discorso, tanto i libri di Sciascia quanto Petrolio, sia pure da sponde opposte, raccontano un analogo destino di separazione da ogni possibilità di mediazione collettiva, e di conseguente solitudine. Gli anni Ottanta segnano una frattura nel senso di un passaggio ormai consumato alle logiche della postmodernità (Tabucchi, Del Giudice, De Carlo, Celati, come pure l’autore sociologicamente più interessante, cioè Tondelli).

A partire dagli anni Novanta, invece, come si discute nel capitolo secondo, dopo la moda dei cannibali e la falsa genealogia a suo tempo stabilita con la linea Gadda (p. 61), torna piuttosto a farsi strada una nuova attenzione al racconto come «strumento di analisi della società presente, della vita interiore, del mondo materiale». La cronaca torna a ispirare le storie: accade negli autori più legati al postmoderno internazionale (Lagioia), come negli scrittori di noir di successo (esempi: Lucarelli, Vichi); e, ancora, nei reportage di Affinati e di Nove, come nelle opere di Pascale e Covacich, Trevisan.
Insomma, «al contrario di quanto accadeva negli anni del postmoderno […] in molti libri di narrativa italiana recente ricorre il pathos della presa diretta e della denuncia sull’attualità» (p. 83). Il terzo capitolo finalmente spiega il titolo del libro: «ipermodernità» difatti è il termine, ripreso dai linguaggi della sociologia e della psicanalisi, che può aiutare a capire e nominare la contemporaneità, visto che il termine postmoderno sempre più appare insoddisfacente.
Siamo dentro un fenomeno marcato di «svolta verso il referente» – recuperando un’espressione di Hal Foster per le arti figurative a partire dai primi anni Novanta. Rispetto a questo fenomeno di ritorno alla realtà, come Donnarumma già aveva discusso qualche anno fa, incontrando anche decise critiche come quelle di Carla Benedetti in Disumane lettere, l’ipermodernità può essere la parola migliore per accantonare le velleità del postmoderno nella sua pretesa di fuoriuscita da una modernità a cui invece adesso ci si può di nuovo riferire.
Al tempo stesso, attraverso l’ipermodernità si può riuscire a guardare e capire meglio l’immaginario attuale: «l’ipermoderno riprende la volontà critica e autocorrettiva della modernità, ma dando per scontato che nessuna rivoluzione è più possibile» (p. 105). Del resto, dell’attenzione a nuove possibilità di resistenza al naufragio nella finzione fine a se stessa, che sono compiute di solito attraverso il mescidamento di fiction e non fiction (categorie a lungo discusse nel capitolo quarto), di questa nuova attenzione all’extraletterario sono sintomatici gli stessi libri di Wallace e Bolaño, con l’ibridazione di saggismo e racconto e per l’uso finzionale di un io biografico che prende la parola; mentre anche in Italia la volontà esibita di «esaltare iperbolicamente le potenzialità del racconto, e insieme di forzarne i limiti» (p. 159) va verso l’autofiction (Siti), l’epica (Moresco), il saggismo finzionale (Frasca).
La scrittura saggistica funziona anzitutto grazie alle domande interessanti che riesce a produrre: in tal senso può persuaderci anche laddove le sue risposte non ci avessero persuaso del tutto. Al termine della lettura di Ipermodernità, la domanda più forte che continua a lavorare, perfino disturbandoci, è “ma insomma: che cos’è il realismo”? Come in altri interventi qui già citati, in molti dei lavori critici usciti negli ultimi anni – penso anche a Realismo e letteratura, di Bertoni, a Teoria del romanzo, di Mazzoni, e al recentissimo Letteratura e controvalori, di Casadei (Donzelli, 2014) – questa domanda, che sia esplicitata o no, sembra essere, anche in assenza, “la domanda” “sintomatica”, per l’appunto, della critica contemporanea – è la domanda fantasma a cui risponde il titolo di Siti Il realismo è l’impossibile; in un certo senso è pure il segreto di Goya di cui scrive Belpoliti; è il nodo culturale e letterario attorno al quale si forma il sistema di valori, e di relativi limiti, della società letteraria di questi tempi.

Il rischio più forte che Ipermodernità sembra correre rispetto a questo interrogativo è, direi, la possibilità che il concetto di realismo assunto da Donnarumma possa talora apparire, nella prassi della discussione dei testi, meno vicino di quanto si dichiari al concetto lacaniano di “reale” – da cui arriva, evidentemente, il lessico della sintomatologia: convincente a metà, direi, perché ancor prima di Lacan l’idea del sintomo evoca l’immaginario legato a una condizione di perdita di salute.
Ma, si diceva, il senso del realismo come alterità che buca la membrana di ciò che è famigliare, a tratti rischia di confondersi con le categorie lucacciane del rispecchiamento – senza considerare che, come ha mostrato Pellini nei suoi lavori sul Naturalismo, già nell’Ottocento questa categoria era opaca e, non dimentichiamolo mai, tutta interna a un progetto di romanzo “sperimentale”.
E se certi lavori usciti da una certa Neoavanguardia han creato più equivoci e oscurità che altro impugnando feticci categoriali come la cosiddetta “barriera del naturalismo”, adesso che, anche grazie ai precedenti lavori di Donnarumma sul modernismo, certe rigidità sono più databili, conviene pensare al realismo come restituzione di un sentimento della realtà non necessariamente assente, per esempio, anche nei libri che non si propongono come scritture impegnate sul presente: dichiarare l’impegno non basta; non dichiararlo non sempre lo esclude (il discorso vale ad esempio anche per le migliori narrazioni distopiche).
Del resto, la stessa “autofiction” non è soltanto un modo espressivo o una postura attraverso la quale squilibrare il rapporto tra realtà e menzogna, dando in ogni caso per acquisita la capacità di distinguere sempre i due àmbiti. Può anche essere un atto, non di rinuncia ma di interesse, per lo scambio paradossale e irredimibile tra storia e invenzione (Carrère); o può essere, ancora, un esperimento di riflessione e di scrittura intorno ai modi in cui la nostra percezione del mondo è contaminata di irrealtà, come accade in Anatomia di un istante, di Cércas.