Rovesciare gli occhi
«L’artista-alchimista organizza le cose viventi e vegetali in fatti magici, lavora alla scoperta del nocciolo delle cose, per ritrovarle ed esaltarle (…) L’opera e il lavoro che s’identificano con la vita (…) l’immobilità come possibilità di uscire dalle circostanze contingenti per immettersi nel tempo; l’esplodere della dimensione individuale come comunione estatica e simpatetica con la natura; l’incoscienza come sistema di conoscenza del mondo; la ricerca dei turbamenti psicofisici per una vita plurisensitiva e plurilineare; la perdita d’identità con se stessi, per un abbandono del riconoscimento rassicurante, che ci viene continuamente imposto dagli altri e dal sistema sociale (...) L’importante è (…) stupirsi per conoscere il mondo, esser disponibili a tutti i fatti della vita (la morte, l’illogico, la follia, la casualità, la natura, l’infinito, il reale, l’irreale, lo sviluppo, la simbiosi) (…) Un lavoro, un’arte, una politica, un pensare “poveri”, impegnati con l’inscindibilità di esperienza e conoscenza (…) L’intenzione dichiarata, di gettare alle ortiche ogni discorso univoco e coerente (la coerenza è infatti una caratteristica della concatenazione del sistema)». Era il 1969 quando Germano Celant scrisse queste riflessioni, quasi una sorta di manifesto, per presentare ancora una volta l’Arte Povera in un libro edito da Mazzotta.

Courtesy L’artista e Collezione Maramotti, Reggio Emilia.
Un’arte che Celant aveva già lanciato, come un sasso nello stagno, nel 1967, in una mostra alla galleria La Bertesca di Genova (città in cui il critico viveva) e con un articolo pubblicato dalla rivista più importante dell’epoca, “Flash Art”, il cui titolo significativo suonava così: Arte povera. Appunti per una guerriglia.
Ora, una grande mostra, presentata in anteprima a Parigi in collaborazione con lo Jeu de Paume e Le Bal, e adesso esposta finalmente alla Triennale di Milano, ci rimanda alle opere degli artisti di quell’“arte povera” teorizzata e sostenuta da Celant, ma anche a quella di altri autori innovativi, impegnati nel medesimo periodo inquieto ed effervescente, compreso tra la metà degli anni Sessanta e i primi anni Settanta. Curata da Quentin Bajac, Diane Dufour, Lorenza Bravetta e da Giuliano Sergio, cui si deve l’ampio e approfondito testo del catalogo (disponibile in inglese o francese, edizioni Atelier EXB/Éditions Xavier Barral, pp. 416, € 55,00) la mostra della Triennale, Reversing the eye. Fotografia, film e video negli anni dell’arte povera (fino al 3 settembre 2023) propone le opere di ben quarantanove artisti.
Diversamente rispetto a quella di Parigi – divisa su due sedi e con quattro precisi filoni tematici: corpo, esperienza, immagine, teatro – qui l’esposizione si snoda in modo più fluido e libero seguendo una logica in parte cronologica, in parte tematica. S’inizia negli anni Sessanta con il filmato scherzoso e ironico di Piero Manzoni che, in stile po’ fotoromanzo e cine-giornale, si sforza invano di imitare con un palloncino gonfiabile le forme di una signora piuttosto “in carne”. Si finisce con la ben più intellettuale e quasi preveggente opera di Fabio Mauri, in cui proietta, proprio sul corpo “sacrificale” di Pier Paolo Pasolini (era il 1975 e lui sarà ucciso poco dopo), il suo film Il Vangelo secondo Matteo.
Quando si pensa all’arte povera vengono subito in mente quelle opere, fatte con terra, legno, ferro, stracci e scarti industriali, che caratterizzavano i lavori più iconici del composito e mobile gruppo di autori che, in quegli anni, si opponevano al “sistema” dell’arte e alla consueta triade costituita da: artista creatore; opera da contemplare negli spazi nobili dell’arte; spettatore che osserva passivamente. Eppure – come rivela questa mostra realizzata con grande rigore – notevole (anche se meno evidenziato) è stato pure l’uso, da parte di molti artisti dell’epoca, di media allora considerati “poveri” come la fotografia, i film e i video, questi ultimi creati spesso a bassa risoluzione. Media usati, da questi artisti, come un nuovo campo d’interrogazioni proteso a decostruire la logica di un’arte auratica, affermativa, dunque facilmente utilizzati anche in modo volutamente “sbagliato” o “anomalo”. Ecco ad esempio Mario Cresci che srotola per strada un lungo rotolo di fotografie dedicate a una manifestazione contro l’inerzia dello Stato in seguito al terremoto del Belice. Ma distrattamente carica due volte la stessa pellicola.
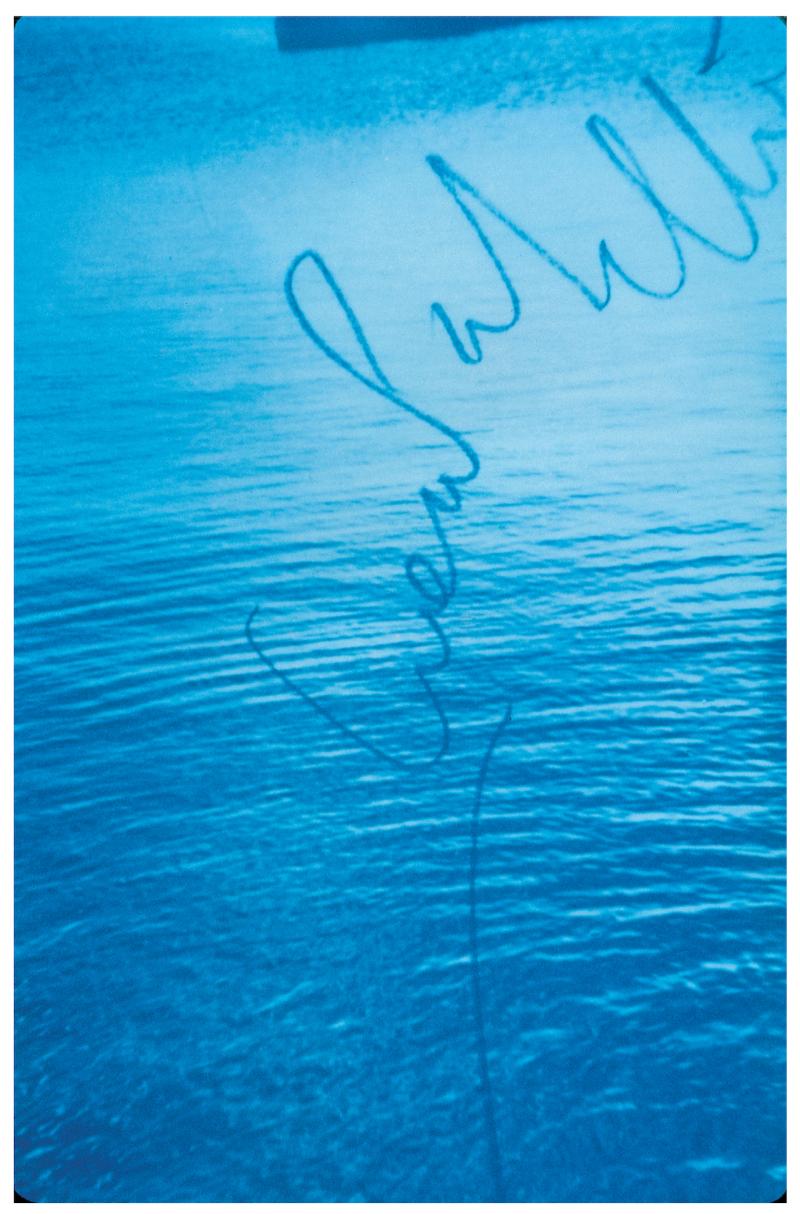
Certo, l’ha fatto solo per sbaglio, ma poi lui decide che va bene così, perché l’effetto è più concitato, non c’è più una netta divisione tra uno scatto e l’altro: la manifestazione scorre tra slogan e rabbia, e pure le sue immagini-rotolo si susseguono l’una sull’altra, quasi volessero assorbire e riflettere il flusso della folla. Mentre Paolo Gioli, “artista-alchimista” (per tornare a Celant), intreccia aspetti magico-scientifici, fotogrammi cinematografici e fotografie, gesto e opera, in un sistematico proposito di oltrepassare le logiche prestabilite dei media. Lui infatti li utilizza sì, ma per così dire “al contrario” o “di sbieco”, a volte usando la cinepresa come una macchina fotografica, per poi ingrandirne i fotogrammi. Luca Maria Patella si cimenta con tecniche imprecise e obsolete come il foro stenopeico o il laborioso procedimento di Louis Ducos du Heuron (1837-1920), pressoché misconosciuto inventore delle prime fotografie a colori. Patella allora risuscita quel metodo dimenticato e desueto fino a creare immagini dai toni un po’ fuori dal tempo, un po’ stranianti.
Giulio Paolini, con il video Unisono (Art/Tapes/22), del 1974, presenta in rapida successione, pressoché una sull’altra, novantadue sue opere, cancellando così ogni possibilità di contemplazione e identificazione delle singole immagini, e scardinando l’allora diffusa retorica del tempo reale dei video. Al piacere “retinico”, già aborrito da Duchamp, viene così dato un decisivo scacco matto.

Quando però questi artisti dovevano fissare e documentare le loro effimere performance, ecco che chiamavano in soccorso “veri” fotografi, che divengono loro complici, amici e compagni di strada. È il caso di Claudio Abate (le cui immagini sono anche esposte, fino al 4 giugno, nell’antologica Claudio Abate superficie sensibile, a cura di Ilaria Bernardi e Bartolomeo Pietromarchi, MAXXI, Roma) cui si deve, ad esempio, la celebre immagine dei dodici cavalli vivi esibiti da Jannis Kounellis per inaugurare la Galleria l’Attico di Roma, non a caso ricavata in un enorme garage decisamente délabré; ma anche lo scatto, del 1968, con Pino Pascali che imita giocosamente la posizione di un ragno sotto la sua giganteggiante Vedova blu di nylon e pelo acrilico; e pure la serie con Gino De Dominicis che getta sassi in acqua nel tentativo di creare onde quadrate: perfetto esempio di quel voler “gettare alle ortiche ogni discorso univoco e coerente” (Celant) rimanendo coerenti nell’incoerenza. In mostra, quindi, ci sono anche ricerche di fotografi che, grazie alla loro vicinanza e amicizia con gli artisti di cui documentano le opere, iniziano a riflettere sul loro stesso mezzo e a creare opere lontane dai reportage sociali di quegli anni.
Vediamo così le immagini di Ugo Mulas che – dopo anni spesi a fotografare artisti italiani e americani – crea, con le celebri Verifiche, nuove opere che si presentano volutamente come ragionamenti sia scritti sia visivi sulla fotografia. Ma va anche ricordato che – tra i tanti altri autori impegnati a documentare le azioni e le opere degli artisti – c’era pure Mimmo Jodice, il quale, agli inizi della sua carriera, collaborò con gallerie/studi, come quelli di Lucio Amelio, Peppe Morra, Pasquale Trisorio e Lia Rumma: tutti galleristi che esponevano gli autori più innovativi dell’epoca e con cui spesso Jodice costruì proficui rapporti di confronto. E infatti vediamo Jodice scattare un’immagine dell’azione di Kounellis Il viaggio di Ulisse (1969); e poi modificare questa stessa immagine con una sorta di strappo. Ebbene, sarà proprio a partire da questa prima opera che Jodice inizierà a riflettere su rapporto verità, illusione e finzione nella fotografia.

Courtesy Galerie Karsten Greve St. Moritz, Colonia, Parigi, © MIMMO JODICE.
Ma torniamo al titolo significativo della mostra: Rovesciare gli occhi. È questa una voluta citazione, con micro variazione, dell’opera-icona di Giuseppe Penone Rovesciare i propri occhi (1970). In tale opera performance, fissata in svariate registrazioni fotografiche, Penone esibiva lenti a contatto specchianti che lo rendevano cieco, mentre riflettevano il paesaggio che gli stava davanti. L’artista, cioè colui che rende “visibile il visibile” grazie al suo sguardo, al suo gesto di dipingere o fotografare, ora (proprio lui!) perde la vista e con essa si dissolve l’io dell’autore, il quale, proprio in quanto autore, dovrebbe autorialmente scegliere ciò che vuole inquadrare o raffigurare.
Quella di Penone vuole dunque essere un’opera senza autore, ma dove il corpo dell’artista si offre quasi fosse una scultura vivente, una sorta di mago dotato di una cecità profetica e inquietante. «L’immagine riflessa è il confine tra la realtà e un mondo di sogno o un’apparizione; non ha sostanza ed è l’istante che segue i cambiamenti della realtà» – raccontava appunto Penone. A sua volta Eliseo Mattiacci, in Pensare il pensiero (1973), si acceca (con una bendatura spessa e giganteggiante) e si cimenta nel creare un’opera che sembra effettivamente sgorgare solo dal suo pensiero, dalla sua energia vitale. Pure Michelangelo Pistoletto, con i suoi tableau-specchio – dove immagini fotografiche sono incollate su superfici riflettenti – crea, di fatto, opere che “rovesciano lo sguardo”. Egli ci mostra spesso personaggi visti di spalle, che sembrano invitarci a osservare ciò che gli sta di fronte, ma appena proviamo a “seguire” il loro sguardo ci troviamo davanti a noi stessi e alla realtà che si muove attorno a noi. Invece di entrare visivamente nell’opera, è l’opera stessa a guardarci riportando concretamente l’arte nella vita di chi la osserva.

Tali sue serie sovrappongono volutamente il passato dell’immagine fotografica, con l’incertezza del presente dello spettatore. «Lo specchio ci spinge in avanti, nel futuro delle immagini a venire, e nello stesso tempo ci risospinge nella direzione di un’immagine fotografica che è stata fatta nel passato» – scrive Pistoletto. Questa fluidità tra passato e presente/futuro, tra chi guarda e chi è guardato, tra spettatore e autore, si ritrova anche in un’altra celebre opera di Giulio Paolini: Giovane che guarda Lorenzo Lotto. Grazie al titolo dell’opera e alla banale riproduzione fotografica di una foto del quadro Il Ritratto di giovane¸ appunto di Lorenzo Lotto, qui è il giovane ritratto a guardare noi e Lotto, e non lo spettatore a contemplare un dipinto, di cui egli mostra solo una riproduzione in bianco e nero.
L’opera di Lotto non è più chiusa nel suo passato ma si nutre dei nostri sguardi che s’intrecciano con quelli di questo giovane del Rinascimento, il che ci spinge a immaginare, a vedere di là dai limiti contingenti e temporali. «Ho tentato di ricondurre immagini antiche in nuove opere, che mettessero in gioco lo spettatore e l’autore come polarità presenti» – racconta l’autore stesso (Giulio Paolini, a cura di Francesco Poli, Lindau, Torino, 1990). A “rovesciare i nostri occhi” Paolini contribuisce anche con Antologia (1974): ovvero il retro di un quadro da cui spuntano seminascoste foto-ricordo che fanno immaginare storie e vissuti sconosciuti. Come in uno specchio ideale (e rieccoci al tema dello specchio) l’oggetto della riflessione di Paolini si rivela essere l’arte stessa: le sue procedure linguistiche, i suoi stessi materiali, i suoi canoni, ma analizzati nelle loro pieghe, a “rovescio”, oltre i limiti del consueto.
Un altro aspetto che in questa mostra pare dipanarsi come una sorta di file rouge, è la necessità, per molti autori, di riattualizzare il passato dell’arte, di renderlo nuovamente vivente grazie al corpo stesso dell’artista. Così Salvo, in Autoritratto (come Raffaello), si autoritrae come uno spaesato Raffaello perché privato del sontuoso contesto in cui un tempo si era dipinto il sommo artista del Rinascimento. Luigi Ontani con i suoi tableau-vivants, da lui definiti “Quadri Viventi”, dà corpo, con un tocco ludico e autoironico, a personaggi che spaziano dalla mitologia alla pittura, dalla letteratura alla storia, spesso «scegliendo radici indigene come alibi territoriali» – così dichiara in un’intervista fatta da Adriano Altamira.

Non a caso, in una mostra a Torino degli anni Settanta, io stessa l’avevo conosciuto in perfetta versione Gianduia, maschera della città piemontese. Ma egli crea anche grandi fotografie come simulacri della pittura «nella simpatia dell’Arte-Vita o VitaArte, con Citazioni (…) libertariamente a memoria ambigua, come per il Bacchino, che ricorda tutti i precedenti e nessuno, oppure Dante, Pinocchio, Leonardo…come viaggio d’identità» (sempre in: Adriano Altamira, La vera storia della fotografia concettuale, Area Imaging, Milano, 2007). Mentre Carlo Alfano, con Eco (1977), mostra l’immagine rovesciata del Narciso di Caravaggio che si specchia nell’oscurità più totale. Condannato a inseguire la sua immagine, ciò che appare a Narciso, nell’opera di Alfano, è una sorta di spazio di silenzio, dove la sua figura diviene altro da sé e si moltiplica nei vari autoritratti dell’autore mettendo in evidenza l’incertezza della nostra identità.
L’eco non è quindi mai un doppio, né un’unità, ma una condizione di ambiguità, una somiglianza/dissomigliante, una portatrice di memoria. Invece Ketty La Rocca fotografa ossessivamente le proprie mani per fissarle come immagini della vita, per creare gesti nuovi, creativi, e poi però corrodere queste stesse mani sovrapponendo a esse tracce di scrittura che finiscono per far quasi sparire quelle mani da cui l’artista era partita. E sempre le mani, nel suo video Appendice per una supplica, assumono una misteriosa valenza sacrale, rituale, archetipica, quasi volessero riattualizzare un linguaggio dei gesti arcaico e ormai scomparso. Ma in una dimensione tra rituale e sacro si colloca pure un raro video di Jannis Kounellis, dove dall’oscurità l’artista avanza con una maschera di Apollo e una lanterna che, più che illuminare, pare ulteriormente suggerire un’atmosfera indecifrabile, carica di mistero. L’azione di Kounellis diviene così una sorta di apparizione divina che emerge da un passato irraggiungibile e potente, capace di lambire come un’ombra oscura la nostra vita, trascinandola lontano da ogni ordinaria quotidianità, per portarla in un regno dove s’intrecciano i destini degli dèi e dei mortali.
Per finire, facciamo, per così dire, un altro bel salto tra passato e futuro. Ma questa volta un salto vero e proprio. Confrontiamoci dunque con il Tentativo di volo di Gino De Dominicis (ripreso in video da Gerry Schum) che, da una collina, balza nel cielo a braccia spiegate come se volesse levitare nell’aria verso il lago che s’intravede in lontananza. L’uomo è pesante, come se dovesse sempre rimanere ancorato alla terra, ma il suo pensiero punta verso l’alto, al di là del possibile. De Dominicis si slancia, agita le braccia come un volatile, e fallisce; allora riprova e di nuovo fallisce miseramente. Ma così facendo dispiega, anzi fa alzare in volo un sogno profondo che ci ricollega al mito di Icaro e ai disegni delle macchine volanti di Leonardo Da Vinci con tutte le loro implicazioni magiche e religiose.
L’arte, sembrano volerci dire le opere ancora attualissime di questi autori, può anche essere un inane tentativo di liberazione da sé e da ogni vincolo mentale e reale, ma così facendo ci invita a cambiare, a rapportarci al mondo in modo diverso. Ci offre interpretazioni aperte che sollecitano nuove emozioni, inattesi pensieri. O può invitarci a immergerci nella natura, come fa Giovanni Anselmo nella giganteggiante fotografia Entrare nell’opera, dove l’artista corre libero e vitale dentro il paesaggio fino quasi a fondersi con la sua vastità, fino a spingersi oltre i confini dell’io: verso l’inesplorato della mente, la totalità, l’infinito.









