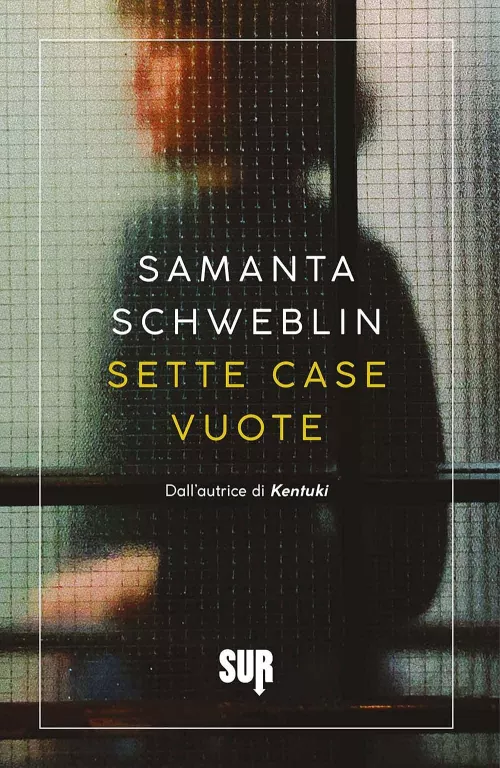Samanta Schweblin, qualcosa di perturbante
Die Unheimliche: due parole per rendere un concetto sfuggente. Un paesaggio della mente che in italiano si può tradurre in molti modi: il perturbante, il sinistro, lo spaesamento. L’oscura idea, insomma, che Sigmund Freud, nel suo saggio del 1919, provava a definire così: “Il perturbante è quella sorta di spaventoso che risale a quanto ci è noto da lungo tempo, a ciò che ci è familiare”.
Ed era partendo da un racconto dello scrittore E.T.A. Hoffmann, “L’uomo della sabbia”, che il padre della psicanalisi riuscì a stabilire “la scoperta dell’inconscio, nella letteratura romantica fantastica, quasi vent’anni prima che ne venga data una definizione teorica”, annotava Italo Calvino.
Da allora, molti rabdomanti della critica letteraria hanno provato a mettere a fuoco un po’ meglio queste prime intuizioni. Arenandosi spesso, come ha fatto Tzvetan Todorov con il libro La letteratura fantastica, nella palude di categorizzazioni troppo rigide. Ma, al tempo stesso, sfuggenti. Se pensiamo che il saggista francese di origine bulgara credeva di avere individuato l’insorgere del fantastico nella scelta affidata al lettore di decidere tra una spiegazione naturale degli eventi raccontati e un’altra del tutto sovrannaturale.
Al contrario, molti scrittori, da Tommaso Landolfi a Georges Perec, da Jorge Louis Borges a Bruno Schulz, da Dino Buzzati a Murakami Haruki, sono lì a dimostrare che è la realtà stessa ad albergare in sé i semi del perturbante, dello spaesamento. Soprattutto nell’era moderna, dove la scienza e la tecnologia, l’invadente presenza delle macchine e l’elaborazione di spiegazioni logiche sempre più stringenti, finiscono per centuplicare il desiderio di irrazionale. Insinuano l’ipotesi che sia possibile mettere da parte le sterili certezze per addentrarsi, come impavidi speleologi, nelle abissali sorprese della vita quotidiana.
Tra gli scrittori contemporanei, Samanta Schweblin è senza dubbio una delle più brave nel contaminare la realtà con i germi del perturbante. Argentina di nascita, con origini italiane da parte di madre, definita dal “New Yorker” un genio della narrativa del terzo millennio, inserita da “Granta” tra i 22 migliori autori di lingua spagnola, debuttando nel 2002 con El núcleo del disturbio ha convinto perfino un uomo poco avvezzo ai complimenti come il Premio Nobel Mario Vargas Llosa.
Ritmo e tensione sono i punti cardinali che guidano la scrittura di Samanta Schweblin. Innamorata della forma racconto, ha già pubblicato due raccolte di storie brevi: il già citato El núcleo del disturbio (tradotto da Maria Nicola con il titolo La pesante valigia di Benavides per Fazi nel 2010) e Sette case vuote (pagg.135, euro 15), tradotto l’anno scorso sempre da Maria Nicola per le edizioni SUR. Ma la scrittrice di Buenos Aires, che vive a Berlino, è riuscita a modulare la stessa voce narrativa limpida, tesa, priva di sbavature, che trasmette al lettore una scossa potente, anche nei romanzi Distanza di sicurezza (Rizzoli 2017; poi nella nuova edizione SUR, 2020) e nell’acclamato Kentuki (SUR, 2019).
Sette case vuote è un viaggio nel cuore di tenebra della realtà. Come se ci fosse un metronomo a scandire il tempo del narrare, Samanta Schweblin costruisce sette racconti che entrano in punta di piedi nel perimetro della vita. E, poi, fanno deflagrare un dettaglio indecifrabile, un atteggiamento che cambia il corso degli eventi in maniera anomala.
In “Niente di tutto questo” una ragazza si trova a invadere la vita privata di altre persone, a frugare nelle loro case, per assecondare le stranezze di sua madre. In “I miei genitori e i miei figli” un marito lascia che la moglie creda di avere perso i suoi bambini, pur di non rivelare che stanno nel prato dietro casa insieme ai nonni cultori del nudismo. In “Sempre così in questa casa” una donna trova ogni giorno i vestiti del figlio dei vicini, morto da tempo, sparsi alla rinfusa nel suo giardino. In “Il respiro cavernoso” la protagonista è ossessionata dalla morte e deve classificare tutto prima di arrivare all’appuntamento.
In “Quaranta centimetri quadrati” una suocera racconta al marito di sua figlia come abbia perso il contatto con lo stare nel mondo dopo avere venduto l’anello di nozze per trenta, inutili dollari. In “Un uomo sfortunato” uno sconosciuto accompagna una bambina al supermercato ad acquistare un paio di mutandine con i cuori, approfittando del fatto che i genitori sono impegnati in ospedale ad assistere l’altra figlia intossicata dalla candeggina. In “Uscire”, una ragazza si allontana di casa nella notte perché non trova le parole per esprimere al compagno ciò che prova.
In tutte le storie di Samanta Schweblin, nei racconti, nei romanzi, il perturbante prende forma in una raffinata danza degli equivoci. Dove sono sempre le parole a dettare il ritmo della narrazione, a costruire con grande originalità i dettagli che porteranno allo sgretolarsi della realtà.
Quest’anno la scrittrice argentina è stata ospite del Salone del Libro di Torino, presentando negli spazi del Lingotto i racconti della sua raccolta più recente: Sette case vuote. “Mi piace molto giocare con l’idea di controllare. Mi rendo conto che, detta così, può suonare come un’affermazione ambigua – spiega, sorridendo, Samanta Schweblin –. Io, ovviamente, mi riferisco al controllo delle parole, della scrittura, perché cerco sempre di usare il linguaggio in maniera corretta. Ogni parola ha il suo significato, deve trovare il posto giusto all’interno delle frasi.

Sono le parole a dettare l’insorgere delle storie?
Succede qualcosa di meraviglioso, quando metto una parola dopo l’altra. Perché, spesso, quelli che ci sembrano luoghi comuni della vita di ogni giorno, nella narrazione diventano punti di forza. Come in un incontro di sumo, dove è la staticità a preludere all’esplodere della fisicità. Potrebbe capitare, ad esempio, che io scrittore dica: “Sono in spiaggia, sotto il sole, con mamma e papà”. E il lettore attribuisca quelle parole a un ragazzino, a un personaggio adolescente. A una situazione idilliaca.
E invece?
Devo sorprendere il lettore. Cambiare la sua prospettiva. Posso dire che sono in spiaggia con mamma e papà, lui ha appena compiuto ottant’anni, è notte, nevica. Proprio lì, nel punto di intersezione tra quello che il lettore si aspetta e quello che la letteratura gli propone, si crea una tensione narrativa potente. Qualcosa di straniante. Ecco, per me le storie iniziano proprio lì.
La sua è un’officina di letteratura potenziale, come quella di Raymond Queneau?
Sono convinta che la letteratura sia un gioco a due. È come un ballo che coinvolge sia il lettore che lo scrittore. E in questa danza ci sono molti movimenti, difficili da controllare. Non mi riferisco ai passaggi esplosivi, come quando all’interno di una storia si afferma ‘ecco, è lui l’assassino’. Penso, piuttosto, ai momenti della narrazione in cui si procede lentamente. Con grande precisione e attenzione.
Ha capito in fretta qual era la traiettoria narrativa che voleva seguire?
Avevo vent’anni quando ho iniziato a inventare storie. Frequentavo diversi laboratori di scrittura. Gli amici mi chiedevano: perché sei fissata con gli autori nordamericani, ti piace la letteratura fantastica? Dicevano che avevo lo stile di un Ray Bradbury ossessionato dalla lucidità di Raymond Carver. A me, però, non interessava scrivere classici racconti di paura, dove si finisce sempre per mettere in scena il mostro.
La realtà inquieta più dei mostri?
Quando si manifesta qualcosa di anomalo, all’interno della realtà, per lo scrittore tutto diventa più facile. Nel classico racconto fantastico, se devi creare una sensazione di spaesamento, di turbamento nel lettore, basta che il fatto straordinario accada. Più difficile è trovare il lato oscuro in pieno sole, nella normalità. E proprio in quella ricerca, gli scrittori nordamericani mi sembrano insuperabili.
Davvero crede che il realismo possa essere più fantastico del fantastico?
Di tutti i generi letterari, quello che concede più libertà allo scrittore è proprio il realismo. Perché accoglie in sé la possibilità della finzione. All’apparenza, scrittore e lettore si parlano da due mondi distanti: ci sono io con le mie storie e tu con la tua vita. Ma quando uno dei due entra nello spazio dell’altro che cosa trova?
Questa è una delle ossessioni tipiche del nostro tempo?
La nostra società ci spinge a esplorare lo spazio degli altri. Ma in maniera superficiale. A me affascina guardare i personaggi più da vicino. Dare voce a quelli che, secondo i canoni della normalità, vengono visti come folli. Perché la loro stranezza, quasi sempre, è soltanto un personalissimo modo di vedere le cose, di comportarsi.
La letteratura permette di interpretare il qui e ora?
Ci illudiamo che la realtà sia una sola. E che da quella visione unica debba arrivare una risposta chiara, immutabile. Ce ne siamo accorti soprattutto in questi ultimi due anni. Prima sembrava che ci importasse solo la minaccia della pandemia. Adesso ci troviamo a gestire l’idea di una guerra che nessuno si aspettava, e che non sappiamo come andrà a finire. Risulta sempre più difficile accettare il concetto che ciò che accade è legato a infinite possibilità di interpretazione. A innumerevoli risposte. Forse, solo la letteratura può permettersi una narrazione più lucida, meno ingabbiata dentro schemi rigidi.
Il peccato più grave per uno scrittore: deludere il lettore?
Prima di iniziare la loro danza, lo scrittore e il lettore firmano un contratto. Un patto che dev’essere rispettato. Chi inventa le storie ha un obbligo: quello di conquistare chi legge. Non può barare.
Scrivere significa esplorare il lato emozionale della realtà?
Scrivere significa accompagnare chi legge lungo un percorso costellato di emozioni. Per farlo si deve partire da una situazione reale. Poi, per esplorare l’oscurità, gli aspetti più inquieti del vivere, è necessario sintonizzarsi con il lato emozionale dei personaggi. Per questo uso spesso la metafora della danza. Bisogna avere davvero voglia di ballare con il lettore per consegnargli una storia che lo coinvolgerà.
Nella scrittura lei è più metodica o più anarchica?
Sono ossessionata dai metodi di scrittura. Ne sperimento sempre di nuovi. Ne ho bisogno, ma finisco per cambiarli ogni volta. Viviamo tutti un tempo che ci bombarda di stimoli, di suggestioni. Spesso è davvero difficile riuscire a concentrarsi.
Però, nel momento in cui una storia chiama, riesce a entrare in una sorta di trance?
Quando raggiungo la concentrazione assoluta, mi riposo. Molto meglio che andare in spiaggia o passeggiare nei boschi. Anche perché, prima, devo fare tanta fatica per raggiungere quello stato di trance. È una lotta contro tutte le suggestioni che mi assillano. Per allontanarle, per chiuderle fuori della mia testa. Però, quando sono pronta, scrivere diventa bellissimo.
Ama più costruire romanzi o racconti?
Non ho dubbi: gioco per la squadra dei racconti. Solo quando una storia breve si dimostra fallimentare, allora decido di allungarla a romanzo.
Che cosa fa Samanta Schweblin quando non scrive?
Leggere è, senza dubbio, una mia grande passione. E poi amo dipingere. I miei nonni materni erano due pittori classici argentini. Da quando avevo sei anni mi hanno formata perché imparassi anch’io a esprimere il mio talento con tele, pennelli e colori.
Hanno iniziato prestissimo.
Mio nonno Alfredo de Vincenzo, di origine italiana, un giorno ha telefonato a mia madre. Liliana, le ha detto, è ora che Samanta impari a dipingere. Quindi dai 6 ai 16 anni mi ha svelato tutto quello che poteva servirmi nel campo dell’arte. E non solo. Per essere una vera pittrice mi ha insegnato anche a viaggiare sugli autobus senza pagare il biglietto. E poi, a rubare libri, a prendere oggetti antichi nei mercati per poi rivenderli e usare i soldi incassati scommettendo sui cavalli, andando a teatro, visitando i musei. Però, credo che questa sua educazione non abbia prodotto il risultato che sperava. Non sono diventata una brava pittrice. Ho scelto la scrittura.