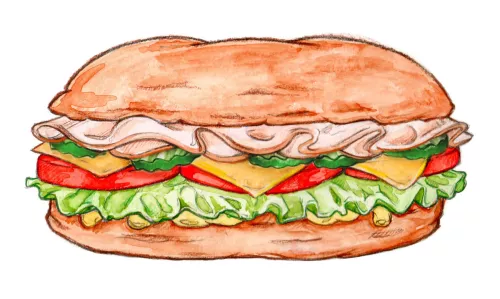Sulla questione scolastico-alimentare / Voglio il panino libero!
La battaglia per il panino libero, com’è stata battezzata dai giornali la recente questione scolastico-alimentare ipertorinese presto sfociata in complesse beghe giuridico-amministrative a valenza nazionale, solleva una serie di questioni di varia natura: etiche, politiche, economiche, ma anche letterarie e gastronomiche. Da una parte sembra roba da faits divers, atta a riempire le pagine dei quotidiani talvolta sguarnite di news più allettanti. Dall’altra è faccenda che non può non toccare chi a vario titolo s’occupa di scuola o di alimentazione, di pubblica amministrazione, di salute collettiva, come anche di filosofia morale o di controversie politiche. Per non parlare del fatto che, ovviamente, chi ha figli in età scolare si sente subito investito dall’antinomia shakespeariana tra panino e non panino, mensa e non mensa. “Mamma, la minestra della scuola fa schifo! Voglio il tuo panino con wurstel rosolato e tanto ketchup!”; “papi, mi compri la merendina al bar qua sotto? a mensa ci danno cose vomitevoli!”. Tutto un rimescolamento di istanze valoriali collettive e dover vivere quotidiano, grandi programmazioni pedagogiche e capricci dell’ultimora.
Alla fine, l’abbiamo letto, dopo lunghe battaglie in tribunale – tre anni e passa – l’hanno vinta quelli del panino portato da casa (preparato cioè dai genitori, per forza di cose dotati di competenza culinaria a corrente alternata), a discapito di chi, arcignamente, sosteneva che la mensa uguale per tutti sarebbe stata non solo comoda per il tran-tran scolastico quotidiano, ma un etico toccasana per le pari opportunità degli stomaci – e delle papille – degli allievi d’ogni ordine e grado, come dire d’ogni classe sociale e conseguente dotazione economica. Liberalismo contro collettivismo? Deregulation all’italiana contro post-sovietica organizzazione totale? Fantasie gastronomiche contro appiattimento delle esperienze di gusto? Epifanie idiosincratiche familiariste contro istituzioni comunale, regionale o statale? Rivendicazioni low cost contro sperperi amministrativi appaltati agli immancabili furbetti del quartierino? Locale contro globale? Tutto annesso e connesso, compreso e ricompreso, fatalmente approvato.
Vengono in mente Albano e Romina (“un bicchiere di vino / con un panino / la felicità”), la cui ricerca vintage della semplicità mal nascondeva un’ideologia populista evergreen. Ma sono soprattutto Marcovaldo e la sua pietanziera a esser convocati d’ufficio in situazioni come queste. Si ricorderà come in un racconto della celebre serie di Italo Calvino (letto, fra l’altro, in molte scuole simili a quelle di cui stiamo parlando) il manovale Marcovaldo (ma/ma) apra ogni giorno con curiosità il recipiente metallico in cui la moglie ha riposto il suo pranzo. E vi ritrova, immancabilmente, gli avanzi irranciditi del giorno prima, che ingurgita con crescente disgusto. Finché un giorno scambia il proprio desinare (salsiccia e rape) con quello di un ricco bambino moccoloso affacciato alla finestra (cervella fritte). All’uno piace il cibo dell’altro, ed entrambi lo mangiano con gran soddisfazione. Ma quando l’improvvisato commercio viene scoperto dalla governante del pargolo, manca poco non lo prendano per un barbone pedofilo. E scappa via, triste e pensieroso.
Rileggere questa storiella suscita, rispetto al nostro problema, almeno due osservazioni. Innanzitutto (sarà banale, ma chissà perché nessuno lo ricorda mai) non ci sono soluzioni assolute, provvedimenti validi sempre e comunque: a Marcovaldo piace la cervella, al bimbo la salsiccia. Bastava averli uno dinnanzi all’altro per far scattare la troppo umana reciprocità, lo scambio etnologico che rende pari chi non lo è. Salvo essere represso dall’istituzione e dalle gerarchie sociali pregresse. Inoltre, sembra che la cosa migliore, anche per evitare conclusioni preconcette, sia quella di mettersi dal punto di vista dei ragazzi, cioè di chi, al di là dell’aspra contesa fra genitori e presidi, deve poi, giorno per giorno, dedicarsi al suo pranzo. Qualcuno ha chiesto agli studenti cosa preferiscono mangiare? se il panino di mammà o la refezione del Comune? La tanto sfoggiata libertà di scelta è quella delle famiglie (ossessionate dall’igiene), delle scuole (distrutte dalla burocrazia) o dei ragazzi che, insieme, fanno parte di quelle famiglie e di quelle scuole? Che ne so, magari una messa in comune dei beni gastronomici – familiari e no – nelle stesse mense potrebbe essere, se non la soluzione, almeno una via da sperimentare. La pratica della condivisione non l’hanno inventata i social network ma, assai prima, le tavole imbandite. Occorre sottolinearlo?
Resta il fatto che, sotto sotto, si tratta di battaglia simbolica. Il panino libero non è in senso stretto, cioè ontologicamente, un panino imbottito ma qualsiasi cosa possa farsi segno di una gastronomia familiare portatrice di valori tradizionali, culinari e più generalmente culturali. Che vengono però troppo spesso isterizzati da chi se ne fa portatore. Analogamente, la mensa scolastica non è necessariamente costituita da maccheroni insipiditi, collosi e rifreddi, come dire la zuppa di Gian Burrasca con la ciabatta dentro, ma un cibo uguale per tutti, magari da perfezionare per quel che riguarda i gusti e i costi: uno strumento per costituire comunità nuove, allargate, serene. Lo scontro torinese cela un conflitto più profondo fra sistemi di valori. Mettere a tavola tutti insieme potrebbe perciò aiutare. Poniamo: genitori a pranzo alla mensa coi figli, e soprattutto con i loro compagni di scuola, forsanche con i docenti e i bidelli; oppure nelle cucine scolastiche a imbottire panini per tutti. Se non a riscaldare cervella e salsicce da spartire. Panini liberi sì, insomma, se condivisi.
PS: nel Meridione, va ricordato, questi problemi non ci sono: mancano le mense scolastiche; come dire che, laggiù, il panino è prigioniero: unico cibo possibile per sfamare i ragazzi a scuola.