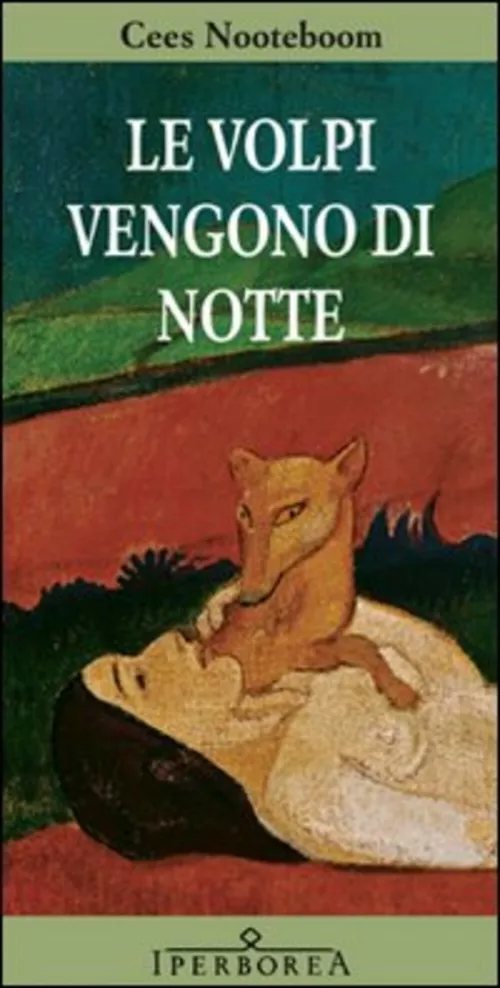Cees Nooteboom. Raccontare la fotografia
Una coppia litiga perché lei è tutta concentrata nel fotografare i lampi, dopo poco lui viene colpito e ucciso da un fulmine. Uno scultore, che osserva la donna e sembra voglia trarne una scultura, alla fine ne fa una dell’uomo fulminato.
Uno dei libri più belli sulla fotografia uscito nel 2010 è la raccolta di racconti di Cees Nooteboom Le volpi vengono di notte (Iperborea), uno dei quali ho riassunto qui sopra. Tutti hanno la fotografia come argomento, una o più fotografie, la fotografia.
Nooteboom non è nuovo alla faccenda, aveva già scritto un bel romanzo breve con protagonisti un fotografo e la sua modella giapponese, Mokusei, e il bellissimo testo in appendice a Hotel Nomade dedicato al fotografo Eddy Posthuma de Boer che lo ha accompagnato nei suoi viaggi, ma questi racconti sono una sorpresa e scoperta dopo l’altra.
La fotografia non vi è come pretesto o puro spunto narrativo, Nooteboom ha proprio voluto scrivere un libro sulla fotografia. Tutto di ciò che si narra, di ciò che si legge, diventa come se si potesse dire lo stesso della fotografia. Per esempio, in Paula, il gioco della roulette, incentrato sul “Rien ne va plus” e insieme sul “metterci molto tempo a perdere”, diventa come lo scatto fotografico che “uccide” metaforicamente ciò che fissa e insieme il perdersi nei dettagli, nella quantità di reale che la fotografia inesorabilmente cattura.
La fotografia in un racconto è il senza senso stesso del mondo, fissato appunto senza selezione in quel disordine che di fatto è; in un altro è il modo in cui i morti parlano a noi vivi, a ciascuno di noi, dandoci del tu e facendoci credere di essere solo per noi; in uno è l’evocazione di un fantasma completamente dimenticato; in un altro è la nostalgia del proprio corpo, che realmente non è mai stato “mio”.
La morte e il tempo c’entrano molto, sempre anzi, in ogni racconto, ma non soffocano la complessità. Ne risulta una gamma di sentimenti, di atmosfere, quali solo la fotografia suscita, con cui è quasi identificabile.
Nell’ultimo racconto – toh!, vezzo da scrittori – non vi è cenno a nessuna fotografia.
Qualcuno parla di un’isola e della sua punta più lontana, battuta dal vento e dalle onde, finché si capisce che a parlare è una donna, dunque non lo scrittore. È una delle donne che erano dentro le foto, negli altri racconti: parla da dentro una fotografia. La metafora è quella del “punto estremo”, che dà il titolo al racconto, che finisce così: “Ho perso la tramontana, diciamo noi qui. He perdido la tramontana. Questo naturalmente significa che non sei più consapevole, ma non è così, io sono molto consapevole. Ero felice, ma non c’è nessuno cui possa dirlo. Devo aspettare che la tempesta e il mare mi richiamino al punto estremo. Questo è l’accordo”.