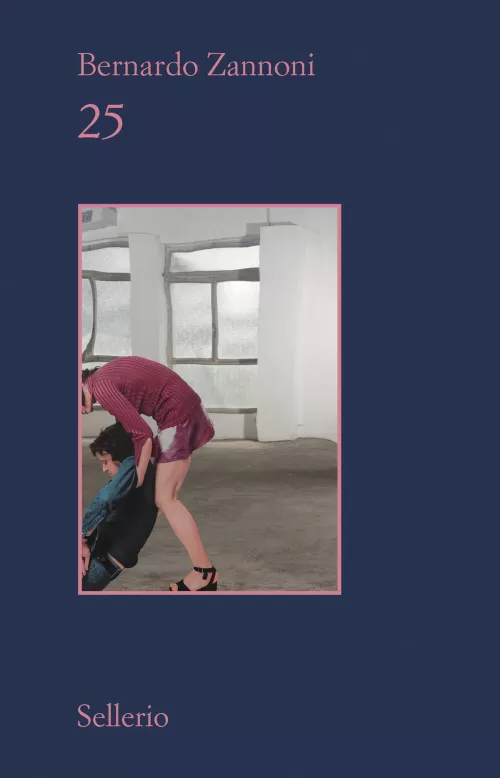Zannoni: il tempo interrotto dei 25
25, di Bernardo Zannoni (Sellerio 2023) è una soglia, o meglio un’anticamera, uno spazio interstiziale tra una vita vecchia, da cui ci si ritrova sputati fuori senza troppo preavviso, e una vita nuova in cui entrare per non perdersi, e di cui però non si trova il varco, la chiave. È un tempo interrotto, che dei regni di mezzo ha il senso di disorientamento, attesa, paura, rabbia, nostalgia.
25 sono gli anni di chi inciampa in questo vuoto di nebbia, che chiede un passaggio o una resa.
25 sono le candeline che dovrebbero stare sulla torta di Gerolamo, tra una settimana, e il racconto si srotola lungo quel piccolo spazio di una manciata di giorni.
Gerolamo vive nella villa in collina che era stata dei nonni, una casa piena di stanze e vuota d’amore, in cui si ritrova solo, scivolato un passo alla volta dentro l’abbandono. L’unico appiglio per Gero è la zia Clotilde, che vive nello spazio raccolto di un piccolo appartamento saturato dal rumore della tv sempre accesa e da uno sgradevole odore che non va mai via e che è l’unica nozione di famiglia con cui Gerolamo ha dimestichezza.
Gero lo vediamo per la prima volta mentre torna a casa di notte, barcolla sotto il ronzio dei lampioni, tra i filari di alberi neri, con la testa invasa da mostri, alcol e domande troppo difficili.
Gerolamo non è più un bambino, “il suo tempo fa ombra” e la vita comincia a disseminare la sua strada, che sembra arrotolarsi su sé stessa e inghiottire il futuro, di piccole frane, crepacci, scosse che piegano le ginocchia e minacciano l’equilibrio.
Gero si sente chiamato a entrare in una fase della vita diversa, la vita degli adulti, dell’autodefinizione, dell’indipendenza, delle relazioni mature, intuisce di dover fare i conti con le aspettative degli altri, con il proprio futuro, con gli anni che lo attraversano e si stendono davanti a lui come un vuoto da riempire, eppure intorno a lui tutto sembra ristagnare, nella sua casa (“grande, vuota e distante: non c’era amore. A quel modo gliel’avevano lasciata, e lui ci viveva dentro”), così come fuori, lungo le vie buie di una cittadina schiacciata contro il mare, sotto le insegne di bar che illuminano malamente sciami di anime mosse, avvolte da un costante brusio, diluito nell’alcol e nell’abulia.
Gero li chiama “gli ignavi”, senza escludersi da quell’insieme di voci, corpi e meccanismi inceppati, che “vivevano di niente, diretti da nessuna parte rosicchiavano nella realtà giorno per giorno. Tutti avevano qualcosa che non andava. Tutti soffrivano di ansie paure e angosce, nascoste sottopelle, dove se ne intravedevano i contorni, e loro le coprivano con il cappotto. Andavano dallo psicologo, facevano corsi di yoga meditativo, bevevano. [...] Stavano tutti fermi, anche se respiravano. Era un annaspare sul posto. Gero non sapeva dire se gli ignavi fossero esistiti anche in altre generazioni; forse non in quel modo, non perduti fino a questo punto.”
Emerge, resa esplicita nella scrittura, una crisi esistenziale, marcatamente generazionale, che impasta la storia e funziona come agente paralizzante e che, per quanto essi si muovano, tiene i personaggi bloccati nello stesso punto, costringendoli a cercare vie di fuga illusorie, mentre franano dentro un malessere profondo, nel dolore di non esistere davvero.
“Sai, Gero, tu non hai odore” gli aveva detto una delle ragazze che aveva frequentato e “quella frase gli si era incisa nel cervello, non se ne era più liberato. [...] Senza odore, era come se non ci fosse”, e Gerolamo non si sente “sicuro di nulla, gli pareva di essere fatto di fumo. L'unica cosa reale erano i suoi problemi, tutti intorno a lui, che non poteva toccare né spostare, essendo un uomo di niente.”
Sembra essere in atto un graduale processo di sparizione, come per le “ombre”, quel gruppo indefinito delle compagnie occasionali che costellano i luoghi che Gero frequenta, e compaiono e scompaiono come fantasmi. “Che senso aveva vivere per non essere niente? Che senso ha contare i giorni, attraversare le stagioni, se non si ha nulla da ricordare, nulla da prendere? Erano tutti perduti. Andavano a vuoto. Occupavano solo spazio.” La difficoltà di diventare adulti sembra stare tutta nell’uscire da quello spazio interiore per incarnarsi ed esistere in quel mondo che appare separato, ostile, triviale, spietato.
Gero scandaglia la massa di individui che come lui galleggiano in quell’indolente angoscia, e se le osserva più da vicino le vede rompersi, a una a una.

Tommy, con la sua bella vita e la sua apparente sicurezza, che improvvisamente implode, si sottrae alla vita gettando l’anima nel bagno di un locale; Amon, di cui Gero invidia la capacità di autodeterminarsi e di scegliere e che invece esplode, con una pioggia di schegge di rabbia, mostrando tutta l’incapacità di stare nelle relazioni, la paura di sentirsi vulnerabile e perso.
Così accade anche ai personaggi che il confine dei venticinque anni l’hanno superato da un pezzo, come Martin, che alla vita adulta di operaio, marito, futuro padre, decide di abdicare, nascosto dentro la consolazione di sogni artificiali con tariffa oraria. Persino Barracus, il bellicoso e prepotente proprietario del bar frequentato da Gero, lascia trasparire una mal sopportata solitudine e ammette che a volte “gli traballa il cuore”.
I personaggi che popolano le pagine sono figure tagliate di netto, poco scolpite, perché si muovono dentro un mondo che coincide con lo sguardo del protagonista, incastrato nel passaggio tra l’adolescenza e la vita adulta. Un mondo letto attraverso una lente ancora più ricca di contrasti che di sfumature, carico di simboli, di ideali. Nelle riflessioni dei giovani protagonisti si legge la riluttanza nei confronti di una realtà edificata più su dubbi e compromessi che su verità integre e luminose, il bisogno ancora urgente di definire il mondo e le cose attraverso leggi e giudizi universali, sentenze tanto più inappellabili quanto rassicuranti: “viviamo in una grande gabbia” spiega Amon “e tutto quello che ci rende felici, invece di liberarci, è restringerla ancora di più”, e l’idea trafigge Gero da parte a parte, perché “calzava perfettamente le sue paure, definiva ogni suo dubbio con una precisione spaventosa”.
Anche il linguaggio e l’estetica del libro rispondono a questa visione, e i luoghi del romanzo si stagliano sulla pagina come allegorie, strappati dalla scena di un film dalla fotografia spenta e i contrasti forti: il mattatoio Kilhdren sotto la pioggia scrosciante, enorme monolito di cemento, con le lettere in ferro che campeggiano sul cancello, il suo parcheggio con la “marea di rottami a perdita d’occhio”, una distesa punteggiata di relitti e carcasse metalliche addormentate, a contrasto con l’assordante “giungla di metallo” all’interno, nell’ampia sala in penombra, con il “grande cubo che ruggiva instancabile, sputava sul nastro orrori di ogni tipo, schegge di vite appena scomparse, sfatando sangue e puzzo di adrenalina”.
O il Pillola Blu, una sorta di albergo a ore nascosto tra le colline, che vende esperienze oniriche e realtà alternative a poco prezzo, con le luci fioche e le file di oblò pieni di sogni e tormenti sopiti.
O ancora i bar malamente illuminati, la villa decadente di Gero tra le colline nere, l’appartamento di zia Clotilde, le strade notturne da attraversare in macchina, il ponte sul mare color pece nella visione onirica di Gero: tutto è coperto da un filtro scuro, metafora che risponde in modo simmetrico al buio in cui si muove il protagonista, replicato ancor più apertamente nel buio che invade la casa di Gero sin dalle prime pagine e lui ci rimane dentro, finché qualcun altro non trova il modo di riaccendere la luce.
Così accade lungo tutta la sua evoluzione narrativa: contagiato dall’indolenza che sembra riconoscere in tanti dei suoi coetanei, Gero procede nella storia come un antieroe a cui piovono in testa occasioni, chiamate all’azione che non gli lasciano scelta. La realtà di quel mondo a cui sfugge lo tira dentro a strattoni, urti e collisioni, mentre il mondo ordinario in cui si crogiolava fino a qualche momento prima gli si sgretola via via sotto i piedi. Viene trascinato dentro a un nuovo lavoro, obbligato a prendersi cura del pappagallo di Barracus, viene suo malgrado investito del compito di ritrovare Martin e di riportarlo a casa: viene in qualche modo costretto ad assumersi responsabilità, guadagnare indipendenza, farsi carico di azioni di cura nei confronti di qualcun altro, mantenere promesse, scegliere di rispondere alle attese degli altri, anche quando è scomodo e difficile.
Gero fallisce, non sa come fare, non ha strumenti, fiducia, pensa troppo e la testa si fa insopportabilmente pesante. Vorrebbe sottrarsi, rimandare ancora il momento di crescere, ma crollano uno dopo l’altro tutti i punti di ancoraggio e non può fare altro che andare avanti, verso il “punto di rottura”, lo squarcio da cui la vita, improvvisamente comincia a fluire, o, come spiega Amon, “è quando non ti nascondi più. Adesso non senti niente ma è tutto lì, deve solo trovare il suo momento”.
“Era già tutto lì, – pensa anche Gero – dietro i suoi occhi, pronto ad esplodere al momento opportuno. Si chiese se la sua età fosse lo scattare di una nuova fase, un inevitabile giro di boa: a venticinque anni ti vedi per quello che sei, e il mondo ti si presenta con il suo vero aspetto. È lì che si comincia a sperare. Si spera che vada tutto bene.”
Scorre, attraverso le pagine, questa latente speranza, che in qualche modo le cose, a un certo punto, vadano a posto da sole, come se mancassero altre soluzioni di fronte a un’endemica incapacità di agire sul mondo: “tutti vanno avanti e rannicchiati dietro questa idea: che vada tutto bene. Senza una speranza non avrebbe senso fare le cose che si fanno ogni giorno. Non ci si crede perché è qualcosa di concreto: ci si crede perché si deve credere in qualcosa, altrimenti chiunque avrebbe chiaro di stare solo respirando, di essere insignificante”. Si illumina, intermittente, la possibilità di un’altra vita possibile – un matrimonio, una famiglia, un lavoro che non uccida fino all’ultimo sogno – come un’aspirazione innestata da qualche parte che non gli appartiene del tutto, ma che suona come una possibilità desiderabile, una via sicura per dare forma al suo desiderio, che è ancora un groviglio scuro di voci indistinte, un mare di pece in cui lasciarsi cadere.
Ma nel piccolo arco narrativo del romanzo il nodo non si disfa, anche se in qualche modo le cose vanno a posto e Gerolamo sembra salvarsi, per il momento, da quel mare buio che minaccia di inghiottirlo.
E così risuona come una profezia il refrain di zia Clotilde, “vedrai che qualcosa succede”: il nastro si riavvolge e alla fine qualcosa succede davvero, un’altra possibilità regalata, una piccola eredità da coltivare, ma quello che viene dopo, è ancora tutto da scrivere.