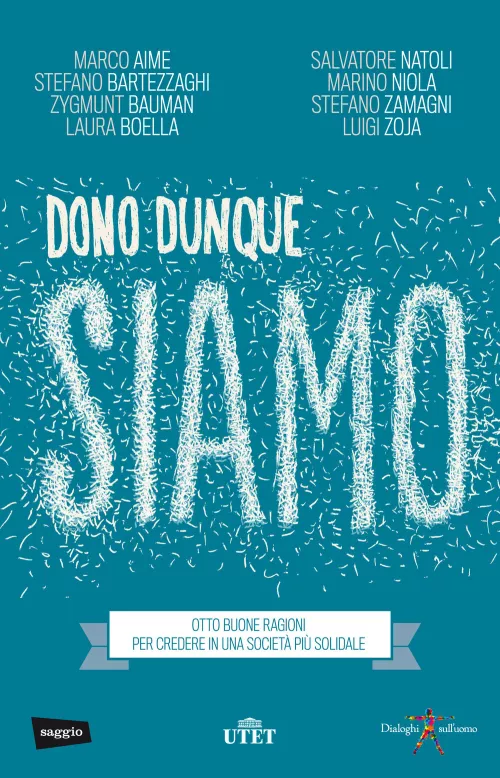Eppur si dona
Chissà se il grande etnologo francese Marcel Mauss, mentre all’inizio degli anni venti si accingeva a scrivere il suo Saggio sul dono, avrebbe mai immaginato che a distanza di un secolo quel suo apparentemente semplice modello teorico del dono sarebbe stato non solo ancora evocato, ma anche applicato all’economia occidentale. Lui, che aveva costruito la sua teoria soprattutto su dati etnografici provenienti dall’Oceania, mescolando atti sociali e credenze magiche, si sarebbe forse stupito a sentire come, in questi anni di crisi del modello capitalistico-finanziario, l’idea di una società basata non solo sull’utilitarismo venga sempre più spesso evocata come via d’uscita.
Il valore della teoria di Mauss sta nella sua semplicità. Cosa spinge gli uomini a donare è stata la prima domanda che si è posto, cosa spinge chi riceve un dono a contraccambiare la seconda. Questioni quasi banali all’apparenza, che però nascondono una forza incredibile.
Se poi pensiamo che uno dona mentre l’altro riceve e ricambia, viene quasi da chiedersi dove stia la differenza rispetto a uno scambio commerciale. Anche in questo caso uno offre mentre l’altro riceve e paga. La differenza, abissale sta nella libertà. O meglio, nelle libertà: libertà di ricambiare o meno, libertà del tempo in cui ricambiare, libertà del modo in cui lo si fa. E la differenza sta anche nel rischio che si prende quando si dona: non c’è alcuna certezza di essere contraccambiati.
Il valore del dono sta nell’assenza di garanzie da parte del donatore. Assenza che presuppone una grande fiducia negli altri. Il valore del controdono sta nella libertà: più l’altro e libero, più il suo gesto avrà per noi valore, perché non sarà dettato dall’obbligo (come nel caso dello scambio commerciale), ma dalla sua volontà di prolungare nel tempo quel rapporto, avviato con il dono.
Ecco che in questo caso il dono diventa promotore di relazioni. Ciò che spinge a donare è la volontà degli uomini di creare rapporti sociali, perché l’uomo non si accontenta di vivere nella società e replicarla come gli altri animali sociali, ma deve produrla per vivere.

L’antropologia ci ha offerto molti esempi di società all’interno delle quali il dono ricopre il ruolo di elemento fondante. In particolare, il “marchio” del dono viene invece assegnato all’Oceania, grazie agli studi pionieristici di Bronisław Malinowski, che per primo si interrogò sul valore sociale di certi scambi, non finalizzati al guadagno, inteso in senso materiale. «Nel sistema melanesiano per essere un uomo prestigioso bisogna “avere”, certo, come dappertutto. Il prestigio sta nel donare, donare molto e donare dappertutto. Il contrario del mondo capitalista!» sosteneva il leader kanak Jean-Marie Tjibaou, mettendo in evidenza un tratto importante della cultura del suo popolo. Donare è importante, ma perché? Per instaurare relazioni.
Mettendo l’accento sulle differenze, l’antropologia classica ha spesso indotto a creare dicotomie che, contrapponendo “noi” a “loro”, attribuivano a ciascuna di queste categorie caratteristiche reciprocamente estranee. Così il confronto è stato reso più facile: esistono ancora società che hanno preservato la loro armonia tradizionale, presso le quali lo scambio di doni rappresenta la quotidianità. Queste popolazioni ci vengono spesso dipinte come fortemente solidali. Tutto il contrario che da noi, dove, dopo Adam Smith, l’economia e alcune correnti della filosofia concordano nell’affermare che, affinché la società funzioni bene, ciascuno deve egoisticamente perseguire il proprio interesse – tant’è vero che nella società moderna si tende talvolta a considerare il dono come un’ipocrisia.
L’opposizione tra un’idea di società basata sulla solidarietà e quella di un mondo dove ognuno, per natura, persegue solo i propri interessi, non solo ha diviso il pensiero degli studiosi, ma ha anche dato vita a una sorta di dicotomia geografica. Se c’è qualcuno che dona per creare le basi di una convivenza, non siamo certo noi occidentali, razionali e utilitaristi. L’utilitarismo dominante nel pensiero occidentale e nelle scienze sociali, infatti, ha relegato il dono in un dominio etnografico, congelandolo in ambiti esotici e impedendo una sua ricontestualizzazione nel mondo occidentale e la sua riattualizzazione in epoca moderna.
Ma è davvero così? Da noi, i doni si fanno e si ricevono generalmente a Natale o in occasioni stabilite, come compleanni o eventi particolari. Insomma, non è considerato normale fare regali senza un motivo che lo giustifichi. Il dono è un’eccezione alla regola, dove la regola è invece tenere le proprie cose per sé e ottenerne altre tramite l’acquisto o lo scambio esplicito. È ciò che accade quando si confonde il dono con il regalo, quello impacchettato e infiocchettato, con tanto di biglietto d’auguri. In realtà il dono assume molte e diverse forme…
Prendiamo il caso del Nord Est di casa nostra, celebrato quale esempio del boom della piccola industria, della cultura del lavoro, dell’ideologia capitalista convertita a livello familiare. In questa terra, che vanta i redditi medi più alti d’Italia, segnala Paolo Rumiz ne La secessione leggera, ci si attenderebbe di incontrare gente ossessionata dal lavoro e dal guadagno, che passa il tempo a parlare di schei. In parte è senz’altro così, ma proprio qui, nella patria della famiglia trasformata in azienda, si riscontra la più elevata concentrazione di attività di volontariato. In una società che sembra avere collocato l’ideale del guadagno e dell’ottimizzazione del profitto in cima alla propria scala dei valori, ritroviamo numerose testimonianze di un impegno che non ha nulla di remunerativo, se analizzato in chiave utilitaristica. Che cos’è il volontariato se non un dono sotto forma di servizi? E che dire dei moltissimi donatori di sangue e di organi che consentono di salvare numerose vite, senza alcun guadagno materiale?
Anche noi doniamo. Il problema è perciò un altro: non ce ne rendiamo conto. Il nostro immaginario è stato talmente condizionato dall’ideologia del mercato che ci sembra impossibile uscire dagli schemi dominanti. Il dono si nasconde nelle pieghe delle nostre azioni e non ci accorgiamo che molte di queste non sono affatto mosse da logiche utilitaristiche. Intendiamoci, “non utilitaristiche” non significa “gratuite”. Come sottolinea Mauss, il dono non è mai gratuito. Chi dona si attende un controdono, ma la differenza tra donare (e contraccambiare) e scambiare è proprio l’assenza di contratto.
Il dono, come abbiamo visto, implica una robusta dose di libertà. Certo, c’è l’obbligo di restituire, ma modi e tempi non sono rigidi. Il valore del dono sta nell’assenza di garanzie da parte del donatore. Un’assenza che presuppone una grande fiducia negli altri.
Il dono, sostiene Alain Caillé ne Il terzo paradigma, diventa in questo caso promotore di relazioni. Ciò che apre la strada al dono e la volontà di instaurare rapporti sociali, perché l’uomo non si accontenta di vivere nella società e di riprodurla come gli altri animali sociali, per vivere deve proprio crearla.
Quando facciamo un regalo, scegliamo qualcosa che ci fa piacere regalare, ma al contempo teniamo conto dei gusti e della personalità di chi lo riceve. Pertanto, in quel dono ci sarà qualcosa di noi e qualcosa di chi lo riceverà: gli oggetti, in fondo, sono ricettacoli di identità.
Nella nostra società si presentano però anche occasioni di donare in modo spersonalizzato o generalizzato. Sappiamo che il nostro sistema economico è alla base di notevoli disuguaglianze, sia all’interno della società stessa, sia nei confronti di quei milioni di individui che abitano il cosiddetto Sud del mondo. Spesso, per “riparare”, almeno in parte, le fratture causate dall’economia, si finisce per chiedere aiuto allo Stato o ad associazioni di volontariato e di carità. La carità, così istituzionalizzata tramite enti organizzati, non è più un dono nei confronti del prossimo, del vicino, di qualcuno che conosciamo, ma un gesto finalizzato a lenire tutte le sofferenze in genere. Al singolo destinatario si sostituisce una categoria (poveri, affamati, affetti da determinate malattie, colpiti da catastrofi) più o meno vasta e quanto mai anonima. Questo tipo di dono diventa un atto che mette in relazione soggetti astratti: un donatore che ama l’umanità e un ricevente che incarna la miseria del mondo.
Stiamo parlando del classico dono generalizzato, del tipo che non prevede un controdono materiale. Se anche ci fosse un beneficio per il donatore, sarebbe di natura morale, emotiva. In fondo, possiamo considerarla una sorta di riconversione: il donatore non offre qualcosa di realmente suo, non sceglie un oggetto che rappresenti in qualche modo il rapporto tra lui e il destinatario. Il donatore offre del denaro, sua pertinenza materiale, non “suo” in quanto segnato da un rapporto affettivo unico (un eventuale attaccamento sarebbe nei confronti del denaro in genere, non di “quel” denaro).
Si fa quindi la carità per aiutare i poveri del mondo, gli affamati, gli ammalati, ma la carità «ferisce chi la riceve», avverte Mauss, è umiliante, perché chi riceve non può restituire. Il circolo virtuoso identificato dallo studioso si spezza: al triangolo donare-ricevere-contraccambiare viene a mancare un lato, l’ultimo. Questo “buco” dà vita a gerarchie sociali ed economiche che inevitabilmente si trasformano in rapporti di forza, e trasforma il ricevente in debitore impotente.
Quando qualcuno ci fa un regalo, quasi sempre proviamo una duplice sensazione: da un lato l’emozione del ricevere qualcosa che ci spinge alla gratitudine verso il donatore, dall’altro, invece, un lieve senso di imbarazzo per la condizione di debito in cui sentiamo di essere appena passati. Non a caso, il pensiero va subito al modo in cui cercheremo di “sdebitarci”.
Debito è una parola che non amiamo, ci fa sentire in colpa se gli indebitati siamo noi e in ansia se a dover saldare un debito nei nostri confronti sono altri. In uno scambio mercantile, al termine della transazione i partner si ritrovano proprietari di quanto hanno acquistato o barattato. Mentre prima dello scambio uno doveva dipendere dall’altro per soddisfare i propri bisogni, a scambio avvenuto, entrambi risultano reciprocamente indipendenti e senza obblighi. Nel caso del dono, il ricevente non paga sul momento, come in una normale transazione commerciale. Chiunque di noi si sentirebbe offeso se, al momento di consegnare un regalo, vedessimo contraccambiato su due piedi il nostro gesto. La restituzione avviene nel tempo, magari in occasioni stabilite (festività, compleanni), ed è grazie a questa dimensione, prolungata nel tempo, che il debito si protrae e mantiene attivo il legame tra le due parti.
Il fatto è che nella nostra percezione tendiamo ad associare il debito alla sfera economica, mentre facciamo rientrare il dono in quella affettiva. Forse è per questo che siamo un po’ restii a chiamare con un freddo termine contabile quello che ci appare invece come un sentimento dei più genuini, che riserviamo a parenti, amici e persone care. Infatti, come fa notare Jacques Godbout ne Lo spirito del dono, nell’ambito familiare lo stato di debito è considerato normale, ma non viene percepito come tale. I genitori spesso donano ai figli molto più di quanto ricevono, ma non si sentono per questo creditori, né i giovani si sentono necessariamente in dovere di sdebitarsi.

Anche in una coppia o tra amici si contraggono continuamente debiti (scambi di favori, di oggetti, di affetto): si dona a chi si ama perché l’atto in sé ci dà gioia. Donando si genera però debito e quindi si crea uno squilibrio. Ma se osserviamo i rapporti di coppia o di amicizia è proprio nella situazione contraria, cioè in uno stato di equilibrio dare/avere che si determina la rottura di un rapporto. Il gesto della restituzione dei regali al partner per sancire la fine di una storia ristabilisce infatti la parità e annulla il debito. Allo stesso modo, l’inizio di un rapporto è spesso segnato da un regalo o da uno scambio di regali, che altera la situazione di parità originale creando asimmetria. Sembrerebbe una contraddizione: dono e controdono dovrebbero portare a un equilibrio, ma allo stesso tempo generano una sorta di conflitto permanente. L’antropologia ci ha però insegnato come l’equilibrio di un gruppo non nasca per forza da uno stato di inerzia, ma spesso da una serie di conflitti interni controllati.
Si dona per soddisfare il proprio piacere di vedere felice un’altra persona, ma non si tratta affatto di un atto gratuito. Tale gesto rientra in una “economia della gratitudine”: uno stato di debito reciproco, nutrito da surplus, da sorprese, e che fa sì che ciascuno possa dire dell’altro «gli devo tanto».
“Eppur si dona” potremmo esclamare, nonostante le apparenze e le nostre convinzioni ci portino a pensare altrimenti. Nella maggior parte dei casi siamo indotti a credere che si tratti di un’eccezione alla consuetudine di scambiare con un guadagno da entrambe le parti. Questo perché il dono, nella sua accezione contemporanea, è il prodotto di un’idealizzazione frutto di duemila anni di Cristianesimo: lo si definisce tale solo quando è uno scambio assolutamente gratuito, unilaterale, disinteressato. Abbiamo visto che non è così, ma spesso le società si pensano diversamente da come sono e il riflesso di questo pensiero finisce per condizionarne l’azione. Come affermava Max Weber, l’uomo rimane spesso impigliato nella rete di simboli da lui stesso creata.
A quanto pare, abbiamo delegato allo Stato, alla scienza e al mercato il compito di soddisfare i nostri bisogni, ma questi tre soggetti non riescono ad assolvere totalmente il loro compito. Saremmo davvero felici in una società efficientissima, ipertecnologica, ultrarazionale e superburocratizzata? Lo scenario sarebbe quello ipotizzato da Aldous Huxley nel suo Il mondo nuovo, e decine di altri libri e film fantascientifici non fanno altro che raccontarci le fughe di pochi “resistenti”, non allineati, in un futuro simile. Non si tratta solo di rifugiarsi alla rassicurante ombra del mito del buon selvaggio, ma di constatare che la razionalità a cui tendiamo, o meglio, con cui ci dipingiamo, non è sufficiente. Stato, mercato e scienza sono istituzioni reali e costituiscono la chiave dell’ordine sociale moderno, ma non rappresentano la società nella sua interezza. Danno vita semmai al terreno su cui si muove quella che Caillé chiama “socialità secondaria”, in cui le relazioni si sviluppano tra funzioni e non tra individui. Al contrario, la socialità primaria necessita invece di una personalizzazione dei rapporti, che va costruita nel tempo.
Appare abbastanza evidente che la realtà urbana, fatta di grandi numeri, così come il modello contemporaneo di lavoro, basato su lunghi spostamenti, relazioni telefoniche e telematiche, nonché l’accelerazione generalizzata delle azioni finalizzate a una maggiore efficienza, non favoriscono certo la maturazione di una socialità personalizzata. Siamo nel pieno della “surmodernità”, come Paul Virilio definisce questa fase storica segnata dal dominio del tempo sullo spazio nella quale l’accelerazione della storia ha annullato le distanze. Accade però che da qualche anno, proprio a Londra, a Parigi, a Zurigo e in altre grandi città europee, cioè nelle culle della modernità, siano stati avviati dei tentativi di creare delle alternative.
Parliamo dei cosiddetti “circuiti di scambio locale”, quelli che in Francia chiamano SEL, Systèmes d’Échange Locaux, in Regno Unito LETS, Local Exchange Trade Systems, Tauschring in Germania e Banche del Tempo in Italia. Con forme e organizzazioni diverse, questi sistemi locali tendono a spostare l’accento dallo scambio commerciale a uno scambio non regolamentato da una meccanica, ma che prevede una forma di moralità.
L’ispirazione per queste iniziative l’hanno fornita realtà simili operanti a Grand Yoff, un quartiere di Dakar. La particolarità del Senegal è che per far fronte a un sistema economico di stampo occidentale, apprezzato dalle élite dei funzionari ma troppo lontano dalle esigenze della gente comune, si è tentato di riproporre in chiave moderna quella che gli antropologi definiscono “economia degli affetti”. Niente di più naturale che recuperare le consuete relazioni parentali, struttura fondante della società africana, e farle funzionare come rete di scambio, ma come? «Noi sotterriamo una iena per riesumare un’altra iena» dicono le donne di Dakar, citando un proverbio della popolazione sererè, che senza volerlo diventa quasi uno slogan per questa nuova forma di economia antiutilitarista.
Se un individuo ha bisogno di un aiuto, sotto forma di manodopera o di beni di consumo, potrà accedere alle risorse disponibili nel gruppo di persone che compongono il suo circuito di scambio – si tratta di individui non necessariamente legati tra loro da vincoli parentali: è tipica dell’Africa l’estensione di legami di tipo famigliare anche all’esterno della cerchia dei consanguinei. Dal momento che a sua volta il beneficiario restituirà al donatore un servizio o dei beni per rimborsarlo, si potrebbe obiettare che è in corso un semplice baratto, ma non è così. La differenza sta proprio nell’attivazione del circuito. Il baratto mercantile si configura come uno scambio tra due commercianti senza fare ricorso al denaro, in questo caso, invece, tra gli individui che si scambiano beni e servizi si consolida sempre di più un legame di solidarietà che rafforza il circuito stesso. In pratica, il bene viene rimpiazzato dal legame.
Anche se da noi non esistono clan e famiglie allargate, ciò non significa che non si possano stabilire legami di solidarietà tra persone che condividono il desiderio di dare vita a un nuovo sistema, sia pure su piccola scala. Il primo SEL è stato fondato nell’estate del 1994, il secondo nel dicembre dello stesso anno. Meno di due anni dopo i SEL francesi erano già 120 e il loro numero è in rapido aumento. In Gran Bretagna, dove i LETS sono nati qualche anno prima, si contano oggi oltre 400 circuiti di scambio: il loro successo è evidente. Anche in questi circuiti urbani europei lo scambio di beni e servizi è alla base del sistema.
All’interno di un SEL il lavoro si scambia con altro lavoro e non con del capitale, è questa la filosofia alla base di tali meccanismi sociali. Un discorso del genere può forse apparire un po’ utopico, eppure i primi LETS sono nati in una realtà razionale e protestante come quella britannica. I sistemi di scambio locali, più che risolvere questioni economiche, danno vita a una nuova forma di socialità, un bene raro nel nostro mondo. Inoltre, il carattere locale di questi circuiti consente di raggiungere soluzioni più concrete e attuabili di quelle proposte dagli enti pubblici, spesso troppo lontani dal quotidiano.
Poniamo che Giovanni abbia bisogno di una baby-sitter, ma che le sue finanze non gli consentano di pagarne una. Francesca ha invece il motorino rotto e deve prendere l’autobus per andare ogni giorno all’università. Fin qui sarebbe semplice ipotizzare uno scambio di favori: Giovanni ripara il motorino a Francesca e lei accudisce i bambini per una sera. Si tratterebbe della forma più antica di scambio: il baratto. Il fatto è che Giovanni è un medico, non un meccanico, e non è in grado di riparare il motorino della studentessa. Mario però lo è. Basta mettersi d’accordo: Francesca farà la baby-sitter a Giovanni, il quale diventa debitore nei suoi confronti di un certo numero di ore di lavoro. Mario ripara il motorino di Francesca, rilevando così il suo credito nei confronti di Giovanni. Quest’ultimo pagherà il suo debito fornendo assistenza medica a Mario in caso di necessità.
Se immaginiamo questo semplice meccanismo moltiplicato per decine o centinaia di persone, abbiamo realizzato un sistema di scambio locale. Tali sistemi rappresentano un tentativo di creare impiego residuale rispetto ai vincoli macroeconomici (la concorrenza mondiale, i parametri di Maastricht ecc.) e si fondano su una forma di solidarietà circoscritta a un numero di partecipanti ristretto. Gli stessi promotori di questi gruppi sono pienamente consapevoli del fatto che tali iniziative non possono sostituire il modello economico vigente. È però importante mettere in evidenza e valorizzare la ricchezza pedagogica di tale formula, che se non altro ha il grande merito di proporre un sistema alternativo e dimostrare che non siamo per forza costretti a conformarci al vangelo dei grandi finanzieri internazionali. Grazie a queste iniziative, si riscoprono le virtù della cosiddetta economia informale, quella che Serge Latouche chiama “neoclanica”, che consente agli attori di passare da uno scambio freddo e anonimo a un sistema di scambi personalizzati.
Un’annotazione quasi di colore: i primi circuiti europei di scambio sono nati a Londra e Parigi, le due capitali del colonialismo africano. Legge del contrappasso? No, più semplicemente è il tentativo di ricostruire o recuperare quella forma di oikonomia vernacolare, basata appunto su una maggiore personalizzazione degli scambi e sull’affrancamento dalla logica di mercato in favore di un avvicinamento al modello del dono teorizzato da Mauss. Fare doni significa infatti tentare di sottrarsi, almeno in parte, all’imperativo economico dominante.
Abbiamo visto come, mentre la socialità secondaria mette in relazione individui che non si conoscono, lo scambio di doni contribuisce alla creazione di una socialità primaria. Questa dà vita a un ordine interno e non può essere generalizzata ed estesa all’infinito, pena la dissoluzione della sua essenza costitutiva. Si tratta di una socialità che fa riferimento a un “noi” ben determinato, che ripropone rapporti face to face e quelle dinamiche individuate da Redfield come caratteristiche di una piccola comunità.
I sistemi di scambio locali, utilizzando una logica che si avvicina a quella del dono maussiano, in fondo non fanno altro che tessere reti di relazioni che portano gli individui che vi aderiscono a conoscersi e a instaurare una catena di debiti che li lega tra di loro. Individui che allora non saranno più estranei l’uno all’altro, ma daranno vita a un “noi” che, sebbene non condizioni la totalità della loro esistenza, potrà agire in molti spazi lasciati vuoti dalla rete della socialità secondaria. Sostituendo il contratto con il dono, tali sistemi tentano di “reincastrare” l’economia nella società.
L’uomo è soprattutto un essere relazionale e crea relazioni attraverso il dono. Se proviamo a spogliare il dono dai suoi abiti “esotici” e “primitivi” e a ripensarlo come un riferimento per contrastare quell’anonimato che tanto ci spaventa, oggi, a ottant’anni di distanza, magari parzialmente disintossicati dalla morale utilitaristica dominante, scopriamo la grande attualità della lezione di Marcel Mauss.