Arjun Appadurai, Neta Alexander / Fallimento. Liberare il futuro
Failure di Arjun Appadurai e Neta Alexander (Fallimento, traduzione di Francesco Peri, Raffaello Cortina Editore, ottobre 2020, 130 pp.) sembra uscire con un tempismo quasi irritante nel panorama editoriale in crisi (e sulla crisi) che sta intercettando, con funambolica e opportunistica sterzata antropocenica, una manciata di parole-chiave: dissonanza, disfunzione, crollo, collasso, trauma, sopravvivenza. Il rumore di fondo si fa ormai insopportabile, come gli acufeni per un musicista, ed è auspicabile, con urgenza, che chiunque ne abbia le forze si faccia carico di scavare nel disorientante pozzo di carta per capire che cosa è utile e cosa invece non lo è. L’autofiction della pandemia, il lockdown che diventa “spirituale”, la politicizzazione saggistico-narrativa del disagio climatico, l’antropocenismo degli stenterelli non aiutano a vivere (e morire) in tempi difficili, non più del romanzo borghese o dei consigli culinari della nonna. Servono paradigmi, servono idee che con sana e non semplice plasticità ci consentano di sviluppare dei modelli inferenziali, di passare cioè dall’idiosincrasia autoriale alla salvezza per tutti. In questo senso, anche in questo senso, Fallimento di Appadurai e Alexander è un libro utile.
Anzitutto chi sono gli autori. Arjun Appadurai è un mostro sacro dei Cultural Studies, ma soprattutto è un antropologo, statunitense per storia accademica e indiano tamil di nascita e formazione scolastica, sempre in bilico analitico-narrativo tra percezione locale e globale, tra caso di studio etnografico e mass media, tra carotaggio delle ideologie post-coloniali e panorami tecnologici radicali, tra immaginario sociale e cultura come fabbrica del futuro. Il suo sguardo sul mondo è così penetrante, visionario e al tempo stesso pragmatico che, oltre a insegnare e scrivere, è consulente di fondazioni, progetti, istituzioni internazionali di prima grandezza laddove sia necessario risolvere situazioni di crisi dovute a globalizzazione, conflitti interetnici, accelerazione digitale. Neta Alexander lavora alla Colgate University di New York e si occupa di nuovi media, cinema e Rete. Due biografie che, messe a confronto in modo così brutale, potrebbero far inarcare un accademico sopracciglio, mentre invece raccontano la storia di un antropologo già entrato nella storia del pensiero che accetta la proposta di collaborazione di una giovane ricercatrice pressoché sconosciuta. Una prima lezione di metodo, dunque: un vecchio professore famoso e al vertice di una carriera piena di allori e una giovane solo agli inizi che mettono insieme due cervelli brillanti, che imparano a lavorare in completa sinergia, che si presentano alla pari in un mondo di pregiudizi, paternalismi e retoriche generazionali di ogni tipo.
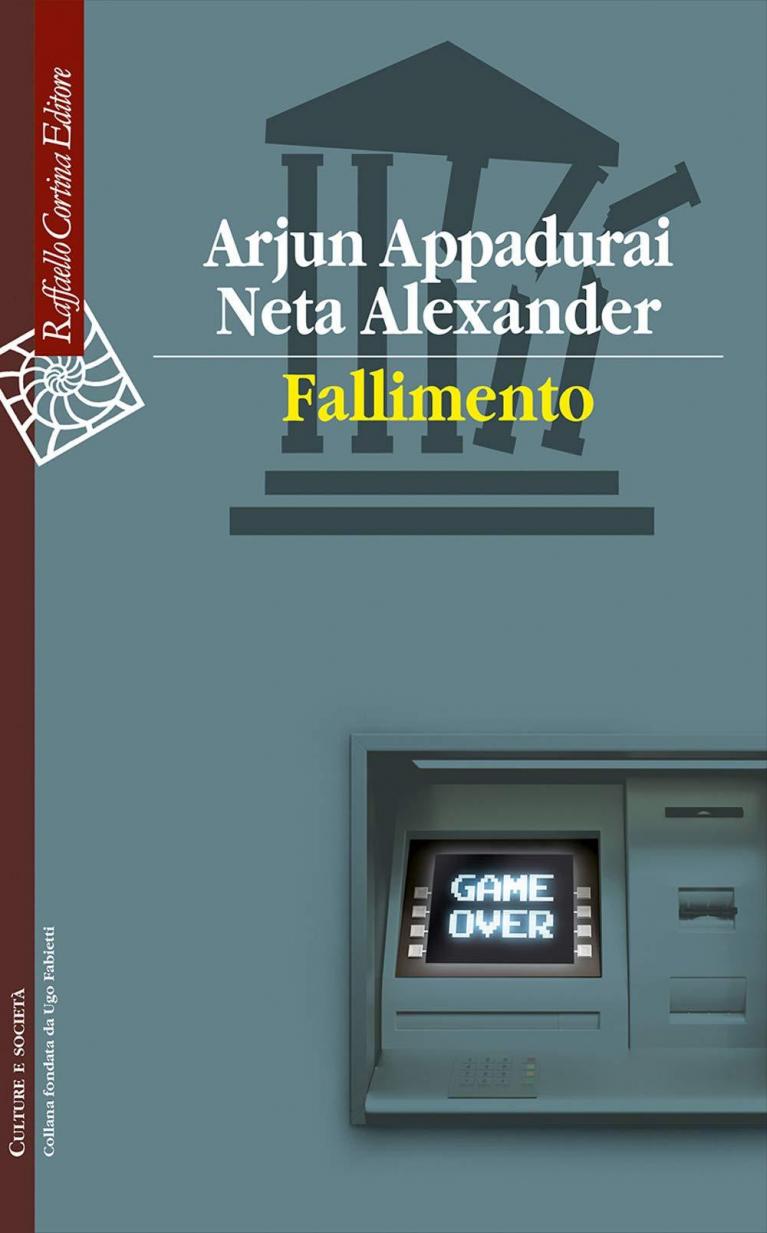
La tesi del libro si può riassumere così: il fallimento non è solo una parola e il suo habitat semantico-linguistico, non è solo un artefatto sociale e contemporaneamente una sensazione interiore di delusione individuale e collettiva, non è il destino ontologico di ogni finitudine o un demone annidato deterministicamente nella macchina tecnologica; il fallimento è un giudizio di chi ha potere, competenze e capitale per tenere in vita delle fantasie collettive, per generare dei meccanismi di attesa, per gestire a vantaggio di pochi il futuro di tutti. «In questo libro ci proponiamo di mostrare come certi protocolli di giudizio producano specifici regimi di fallimento. A interessarci sono soprattutto i modi in cui il capitalismo contemporaneo riesce a configurare sistemi finanziari e tecnologici ad hoc per dare luogo a un apparato interconnesso capace di produrre e naturalizzare il fallimento, e quindi suscitare l’ineludibile impressione che la buona riuscita sia sempre merito della tecnologia e delle sue virtù, mentre l’insuccesso è sempre imputabile al cittadino, all’investitore, all’utente, al consumatore» (p. 2). Basterebbe questo paradigma-zero in apertura del libro per confermare che siamo in presenza di un testo utilissimo in quanto generatore di prospettive. Un’applicazione veloce: la pandemia in Italia è stata gestita in un regime di giudizio e fallimento che, nella narrazione dialettica tra potere politico inetto e responsabilità di commercianti e cittadini festaioli, ha distratto quasi tutti da una considerazione cruciale: Covid-19 non è un’azienda, non è una nave da pilotare in mezzo alla tempesta, ma un evento fuori portata umana che produce perdite ineluttabili senza grandi possibilità di riparazione.
Attraverso due casi di studio canonici, ma non autotrasparenti, Wall Street e la Silicon Valley, Appadurai e Alexander esaminano di volta in volta le micro e le macrostrategie che servono a montare la funzione narratologica, oltre che economica e culturale, del fallimento, e illustrano come queste strategie poggino sempre sul bias cognitivo della memoria selettiva: si dimenticano tutti i fallimenti tranne alcuni, si ricordano i successi anche se piccoli e irrilevanti. E mentre i bias, l’oblio, formano un problema radicale nella gestione del futuro (perché scordarsi i fallimenti di individui, di gruppi e di specie è una delle peggiori malattie cognitive della civiltà), il cui prodest di questi bias ci mostra un mondo in cui il cinismo neoliberista raggiunge raffinatezze operative inimmaginabili per monetizzare l’ottusità percettiva della gente. Oltre che economico, però, il problema è epistemologico: il modello scientifico, da Popper in poi, è incardinato sul principio della falsificazione empirica, che acclara la verità teorica come la smentita di un’ipotesi erronea. Detto altrimenti, il progresso è consustanziale al fallimento, il che di per sé è corretto, ma la sua traslitterazione nel mondo della ricerca a fini commerciali ha generato un’atmosfera di “credenza” totale, una fede nell’ineluttabilità dell’innovazione tecnologica. Così siamo abbagliati dalle risorse dell’ultimo gadget informatico, dalla sonda su Marte, dalla clonazione umana, ma la fusione fredda, che forse servirebbe di più a un pianeta boccheggiante, resta un ridicolo mito da fantascienza boomer.

L’ethos imprenditoriale e scientista del fallimento come via per il successo è una narrazione profondamente tossica, secondo i due autori, un’opacità della rappresentazione che nasconde l’illusione artefatta che la scarsità verso cui siamo storicamente avviati sia un ingrediente indispensabile della ripresa. Una versione contemporanea, viene da aggiungere, dell’idea vittoriana di progresso e, come quella, infestata anche qui dallo spettro del (neo)colonialismo predatorio, questa volta su geografie di scala globale, nessun paese escluso. In altre parole, la nuova sacca di mercato speculativo consiste nel generare profitto dal potere anestetizzante del racconto della carenza come valore, un’escatologia profana dell’insuccesso per spalmare sull’inquietudine sociale un balsamo lenitivo, una promessa di felicità nell’impotenza che in realtà sta allargando il cratere del trauma. La prima idea per uscirne, dunque, è ripensare radicalmente il concetto di fallimento, vedendolo «come una disfunzione che si produce di continuo» (p. 6), sfumando la dialettica binaria successo/insuccesso, sostituendo al mito dell’innovazione un’etica della manutenzione e una cultura della cura. Se una cosa può essere riparata allora è solo guasta, non è irrimediabilmente persa, ma nell’era dell’obsolescenza programmata l’idea di fallimento definitivo del prodotto diventa accettabile (e necessaria) e il nuovo modello sul mercato è l’unica risposta possibile lungo una fulgida curva ascendente. Così la disfunzione quotidiana viene rimossa, ce ne dimentichiamo, e l’oblio è generato dalla nostra stessa natura di consumatori voraci.
Proprio nella risemantizzazione mercantile ed epistemologica dell’insuccesso si annida però il piccolo errore fatale che può fare inceppare la new economy del fallimento: queste dinamiche controintuitive e fino ad ora molto poco studiate diventano concettualmente fragili se sottoposte a un’analisi serrata, analisi che mostra ad esempio come il “prezzo da pagare” sia semplicemente e sistematicamente scaricato sull’utente che, oltre che compratore, diventa il collaudatore di tecnologie difettose, oppure svelando come dietro la promessa di una maggiore efficacia funzionale il mercato delle app social abbia lo scopo di modificare la socialità stessa rendendola più permeabile al consumismo compulsivo e solitario. Chiaramente le soluzioni accelerazionista, primitivista o alla Ted Kaczynski sono ad altissima ideologia e a bassissima praticità, e proprio per questo Fallimento di Appadurai e Alexander è un libro per chi ha tempo di non pensare a scorciatoie e di far pratica di traduzione di scenari. Ad esempio, leggendo le tecniche di distruzione creativa e di architettura di nuove socialità che sono prodotte da e che producono la gig economy, mi veniva da pensare che finalmente abbiamo un modello per descrivere in modo analitico la bolla in espansione dei servizi editoriali nel mondo del libro, la permeabilità del prodotto culturale (e dei suoi contenuti) al sistema neoliberista della prestazione temporanea e occasionale, la mercificazione dell’emotività del lettore… Certamente la Silicon Valley ha un peso infinitamente maggiore di certa editoria major e indie nel rallentare la liberazione del nostro futuro dalla cultura del fallimento. Interessante notare però come la logica alla base di entrambe sia la stessa.









