Raggiungere la felicità / Happycracy. Socrate scontento o maiale soddisfatto
La felicità è una cosa banale o non è. È così, e il suo valore non è certo sminuito per questo. Può capitare a tutti la “banalità del benessere” di un breve momento, transitorio, evanescente per la sua stessa natura costitutiva di sospensione della dura complessità del vivere. Nasce il tuo bambino, tutto si ferma, ed è una gioia squisita, che diventerà altro. Ti innamori, tutto si interrompe, e sei pervaso di sentimenti di piacere, che diventeranno altro. Sono stupende scintille che di tanto in tanto scoccano tra i fatti della vita, ma la felicità non può essere uno status, a meno che non ci si fermi alle zone epidermiche del nostro essere e lì si cerchi un appagamento relativo e simbolico. Se decidiamo di abitare il nostro mondo un po’ più in profondità le cose stanno molto ma molto diversamente.
Non ci sarebbe tanto altro da aggiungere a questa riflessione, storia del pensiero a parte, se non fosse che in tempi recenti la nozione di felicità è stata proditoriamente sottoposta a una vera e propria revisione che ha dato luogo a delle precise conseguenze nel vivere quotidiano. Questo è il tema di Happycracy. Come la scienza della felicità controlla le nostre vite (Codice Edizioni, 2019), scritto dallo psicologo spagnolo Edgar Cabanas e dalla sociologa israeliana Eva Illouz. Un libro che smonta, pezzo per pezzo, l’assunto della cosiddetta “psicologia positiva” che sta alla base della “scienza della felicità” secondo la quale il raggiungimento della felicità personale è il fine precipuo dell’uomo contemporaneo. Un enunciato davanti al quale non si può non trattenere le immediate e facili ironie dettate dal buonsenso comune: capirai, la felicità, vaglielo un po’ a dire a… Eppure l’idea che si possa costruire una condizione di felicità ha ormai più di due decenni di vita e, a parte tutto, mostra ancora una certa evidente energia.
La parabola fondativa della “scienza della felicità” è quella raccontata da La ricerca della felicità, film del 2006 di grande successo diretto da Gabriele Muccino, in cui il povero Chris Gardner (l’attore Will Smith) vive drammaticamente in povertà con moglie e un bambino di cinque anni nell’America reaganiana. Incantato dai broker di una prestigiosa società finanziaria che escono dal lavoro dice: “Mi sembrarono tutti così, non lo so, così felici. Perché non potevo esserlo anch’io?”. Chris decide di diventare anche lui un broker e fa di tutto per iscriversi a un corso presso quella stessa società finanziaria; la moglie lo lascia, ma lui, con il suo bambino, lotta duramente con tutta la determinazione fino a raggiungere il successo. Il vero Chris Gardner, di cui il film è la storia, ha spiegato che Happyness, titolo originale, viene da una scritta murale vista per strada, con la y al posto della i, dove “La y serve a ricordarci che sei tu [you] il responsabile della tua [your] vita. È inutile che aspetti i rinforzi.
Dipende tutto da te.” (p.6)
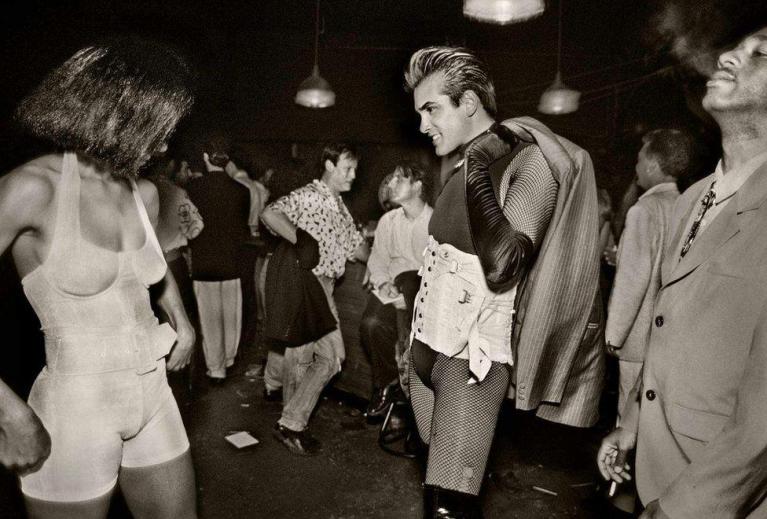
Cabanas e Illouz mostrano come la psicologia positiva abbia consentito al neoliberismo di spopolare in tutto l’Occidente con l’idea di far diventare l’uomo normale sano, e non più solo quello malato, un nuovo oggetto di indagine. Concentrandosi sulle qualità dell’individuo sano per svilupparle ed esaltarle si permette alle persone di “raggiungere la felicità”. Che cosa questo voglia dire, che cosa sia la felicità per gli psicologi positivi, aiuta a capire perché il loro pensiero sia perfettamente pertinente al progetto neoliberista. Gli autori si chiedono perché la felicità, “e non per esempio la giustizia, la prudenza, la solidarietà o la lealtà”, sia riuscita ad avere un ruolo prevalente nelle società del capitalismo neoliberista, e individuano uno dei motivi di tale successo nel fatto che la felicità è “un concetto saturo di valori individualisti, in base ai quali il sé individuale diventa il bene supremo, e i gruppi e le società si riducono ad aggregati di volontà autonome.” (p.51)
Si tratta di una felicità semplificata fino ad essere definibile e misurabile, c’è persino la formula della felicità, eccola: “H=S+C+V, dove H (Happiness) è il vostro livello permanente di felicità, S (Set range) è la vostra quota fissa, C rappresenta le circostanze della vostra vita e V i fattori che dipendono dal vostro controllo volontario” (p.55). Con questa “scientificità” si pensa di poter mettere a disposizione del sistema economico gente capace in sé, con gli opportuni consigli, di una vita bella e dunque produttiva. Brave persone, soddisfatte di lavorare innanzitutto “per il proprio bene”. E se l’individuo è il cardine del sistema economico, per esserne un fattore di stimolo e di continua crescita deve essere positivo, deve avere assoluta fiducia in sé, in una parola deve essere felice. Questa felicità diventa addirittura il prerequisito perché un uomo felice trasmetta la sua positività al sistema in cui opera, cioè l’azienda. Martin Seligman, fondatore della “scienza della felicità”, presidente della American Psychological Association, la più grande associazione di categoria degli psicologi americani con 117.500 membri, intuisce immediatamente, era il 1998, che le applicazioni della psicologia positiva possono diventare strutturali nella società americana, gli individui positivi, motivati perché soddisfatti, interessano all’industria, ma anche al sistema formativo, e anche agli eserciti: tutti campi di applicazione nei quali l’“uomo a una dimensione, felice” è perfettamente coerente.

Peccato, dicono gli autori di Happycracy, che proprio le stesse tecniche della felicità permettano anche “di scaricare sulle spalle dei dipendenti i problemi legati all’instabilità del mercato, alla scarsità delle prospettive d’impiego, all’inefficacia strutturale del sistema e alla concorrenza”. (p.13) Altro che felicità, ha ragione Michel Houellebecq: “Il liberalismo economico è l’estensione del dominio della lotta, la sua estensione a tutte le età della vita e a tutte le classi sociali.” (Estensione del dominio della lotta) “
In una società in cui la contentezza smette di essere un ideale e diventa “un tipo di persona” c’è anche un’“economia della felicità”: siccome tutti siamo perfettibili e abbiamo bisogno di migliorarci, diventiamo “clienti”, quantificabili: a chi non serve un coach, un counselor, per colmare la nostra “fondamentale incompletezza” e per raggiungere l’“autogestione emotiva”? In un mondo in cui incombono “il livellamento del senso e la proliferazione della parvenza”, come dice Alain Badiou (pensando a quanto orrore tutto ciò avrebbe suscitato in Lacan), ci viene offerta una miriade di “emodities” (merci emozionali). Ricordate The Truman Show? Era proprio il 1998, e da qualche altra parte degli Stati Uniti, qualcuno (Peter Weir con Andrew Niccol) aveva altre intuizioni a proposito della falsificazione della società, che andavano in tutt’altra direzione, su una strada in cui incontreremmo fior di idee più volte dimenticate e riprese (mai sentito parlare di Guy Debord?).
I grandi assenti in tutto questo quadro sono l’inconscio e la collettività, come dire, cosucce da niente. Cabanas e Illouz insistono più volte sulla scarsa scientificità dei teorici, per lo più americani, della “scienza della felicità”. La psicologia positiva, dicono, “si aggrappa a un approccio naturalistico, e vede le “emozioni come intrinseche”, vale a dire come un insieme fisso di condizioni universali. Una concettualizzazione del genere si colloca all’esterno del sociale e della storia e trascura la complessità e la molteplicità del fenomeno, dimostrata invece da diversi studi di carattere psicologico, sociologico e storico.” (p. 147) Per non dire della neutralizzazione della dimensione etica della felicità, e del rifiuto di fatto dello stesso aspetto morale del benessere. Per questo Barbara Ehrenreich, tra le voci critiche del mondo scientifico statunitense più spietate contro la “scienza della felicità”, così titola il suo libro Sorridi o muori: come il pensiero positivo ha ingannato l’America e il mondo intero (Smile or die: How Positive Thinking Fooled America and the World, Granta 2010).

Ma questa colossale mistificazione è uscita dai luoghi di origine, ormai viaggia per il mondo intero, il singolo individuo, di qua o di là, sembra spesso effettivamente molto invaghito della possibilità di mettere mano da sé al proprio singolo destino, che poi, messo assieme a quello degli altri felici, non potrebbe che portare il popolo, come usa dire oggi, alla realizzazione di un Paradiso in terra. Per vivere bene, dicono i nostri trainer in incessante attività, possono bastare, che so, capacità di sorridere, non stare soli, mangiare sano, dormire bene, dedicarsi del tempo, ascoltare musica, avere una vita di relazione, essere ottimisti piuttosto che pessimisti, arte e bellezza, viaggi… Con varianti più o meno furbe, in libreria c’è come un aggiornamento costante di questo “ovviume” (a caso tre titoli italiani appena sfornati, e non proprio da piccoli editori: Ilaria Gaspari, Lezioni di felicità. Esercizi filosofici per il buon uso della vita, Einaudi 2019; Raffaele Morelli, Manuale della felicità. Le dieci regole pratiche che ti miglioreranno la vita, Mondadori 2019; Eliana Liotta, Prove di felicità, La nave di Teseo 2019) che fa il paio con l’altro “ovviume”, quello della politica facile del rovesciamo i tavoli, del pensiero finalmente semplice, “perché noi siamo semplici!” come ci viene insegnato, e il pensiero critico è roba da inutili élites puzzone, cioè gente che in fondo non vuole essere semplicemente felice. La felicità, dice la trainer Liotta in un’intervista al Corriere della Sera, “è un dono che richiede una scelta: va desiderata.”
L’idea di felicità occupa la mente umana da sempre (numerose suggestioni si trovano in un articolo di Francesca Rigotti su questo sito), c’è come uno sforzo incessante di catturarla, di definirla, di possederla, un tentativo perenne di avere un qualcosa che non conosciamo, ma di cui si sa che fa bene. Un’astrazione, sì, ma bella e buona. Che tuttavia ci costringe a un martellante rovello: ma saremo felici? Umberto Galimberti ci ricorda spesso che questa visione della vita protesa in un al di là è frutto della cristianità, una prospettiva che gli antichi Greci non avevano. Oggi, dice Galimberti, “l’alienazione è l’andare lontani da sé, in modelli che sono vincenti. Si vuole avere un senso della vita, è il punto di vista cristiano, e oggi il senso dipende dall’adeguarsi al contesto in cui si vive, la performance” (puntata della benemerita rubrica di Radio3 “Uomini e profeti” del 14 aprile 2019). Quanto la “scienza della felicità” sia funzionale al mainstream mercantile della società neoliberista, composta da individui liberi-perché-felici-perché-liberi, è evidente. Possibile che un simile semplicismo scientifico sia riuscito a “bucare” la percezione delle persone e diventare comportamento umano?
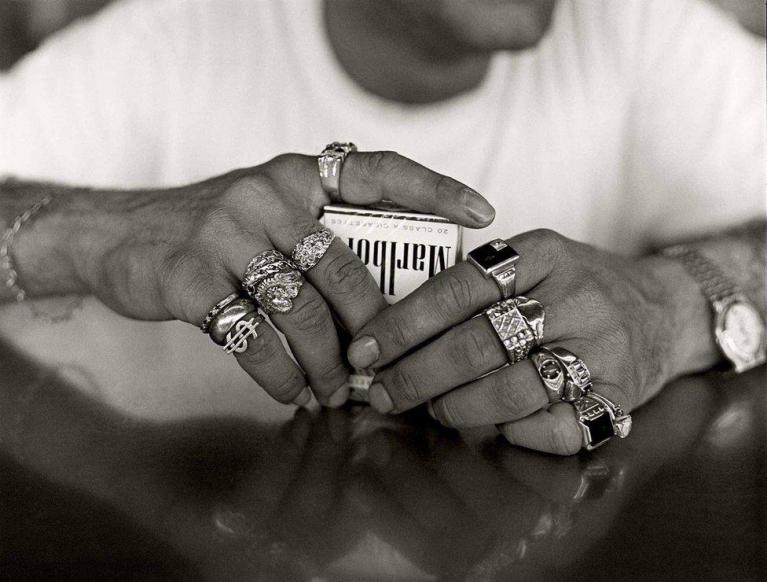
La realtà è una parete che ci circonda ed è sempre molto difficile da oltrepassare senza conseguenze importanti per chi ci prova. Dicono gli autori: “Non esiste un sé univoco, più autentico e assoluto degli altri, così come non c’è uno scopo supremo nella vita, e questo vale anche per il concetto di felicità. Qualsiasi scelta morale, autonoma o imposta che sia, personale o collettiva, comporta sempre il sacrificio di un bene: un sé degno di essere incarnato, alcuni valori che meriterebbero di essere rivendicati, un progetto sociale che varrebbe la pena attuare. È proprio questa l’irriducibile tragedia della scelta, radicata nella natura stessa dell’esperienza personale, sociale e politica a livello quotidiano. Nemmeno il fior fiore della scienza della felicità può salvarci da quei piccoli e grandi dolori nei quali ci imbatteremo inevitabilmente nel corso della vita.” (p.164)
Ci sono i sentimenti negativi, le emozioni “oblique” che nascono dal male e vanno dirette al bene, le infinite combinazioni tra vissuti personali e ambienti di vita, fisicità monche, inspiegabili potenzialità, imperfezioni e incompetenze, paure, angosce del crescere e dell’invecchiare, odio, invidia, tristezza, noia, nostalgia… Il positivo non può farcela a prevalere se non al prezzo, altissimo, di rinunciare al senso di realtà. La realtà è la normalità, con tutti i suoi tormenti, in mezzo ai quali si cela, banalmente, anche l’ipotesi di felicità che a chiunque può capitare di realizzare. La felicità è banale o non è, appunto (quanta letteratura è fatta di questo!). E la socialità ne è una componente imprescindibile. Come ripetutamente dicono Cabanas e Illouz, non si può buttare via la dimensione collettiva, quella della solidarietà tra gli uomini da cui è nata la civilizzazione.

Il filosofo utilitarista John Stuart Mill, a metà Ottocento, per spiegare polemicamente le sue obiezioni alle idee, secondo lui un po’ semplicistiche, di Jeremy Bentham, fondatore dell’utilitarismo, usò la celebre formula “Meglio un Socrate scontento che un maiale soddisfatto”; mi pare che, mutatis mutandis, possa ancora funzionare egregiamente nella nostra società contemporanea. Perché, come dicono in conclusione gli autori di Happycracy, “La conoscenza e la giustizia, e non la felicità, sono e saranno sempre lo scopo morale e rivoluzionario della nostra vita”. O no?









