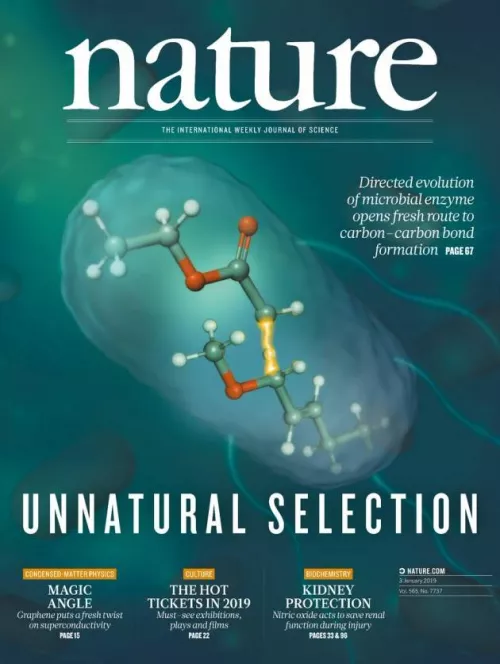Il pensiero creativo è malato?
Il nuovo anno è iniziato con un articolo che potrebbe sorprendere. In un momento storico in cui i cambiamenti tecnologici sembrano succedersi senza sosta, la rivista Nature pubblica uno studio dal titolo «La scienza ‘dirompente’ sta scomparendo … e nessuno sa il perché». Secondo l’autore, Maz Zozlov, il numero di articoli veramente innovativi e rivoluzionari sarebbe in continuo calo. L’articolo si basa su un’indagine capillare di oltre 45 milioni di lavori accademici dagli anni Cinquanta a oggi e sostiene che, nonostante una produzione scientifica quantitativamente in continuo aumento, i lavori veramente rivoluzionari sarebbero sempre meno. Una parola chiave del titolo dice molto: «dirompente» … la scienza non rompe più con il passato. Dall’altro colpisce l’ammissione di ignoranza proprio nel titolo, quasi un tirarsi fuori dalla responsabilità … «nessuno sa il perché» … veramente?
Consideriamo un altro settore, la filosofia. Qualche anno fa un filosofo americano molto stimato, Peter Unger, ha pubblicato un libro su un tema analogo, «Idee vuote: una critica della filosofia analitica». In sintesi, sostiene che il mondo filosofico si sia avvitato su se stesso, impegnandosi a risolvere problemi privi di contatto della realtà. Secondo Unger, i filosofi sono diventati filosofologi, non parlano più della realtà, ma solo del lavoro di altri filosofi ponendosi problemi scolastici privi di reale importanza. Molti altri indizi suggeriscono una progressiva autoreferenzialità del settore: il numero di citazioni di un articolo pubblicato sulle migliori riviste filosofiche è sorprendentemente basso. Per lo più il lavoro dei filosofi è letto (e poco) solo dai colleghi.
Spostiamoci in un’area apparentemente diversa: l’arte. Consideriamo due settori in particolare: musica e cinema. Nel 2012 uno studio statistico spagnolo basato sul più grande archivio di brani musicali ha trovato prove quantitative di una «crescente omologazione e omogeneizzazione dei contenuti musicali: la creatività e la varietà è costantemente diminuita durante gli ultimi 50 anni». Secondo gli autori, la produzione musicale è sempre più convenzionale e priva di originalità in quanto i criteri che ne giudicano il valore tendono a essere auto-referenziali e contrari a ogni evoluzione. E che dire del cinema? Non assistiamo forse a una continua riproposizione delle serie di successo (da Avatar a Top Gun, dalla saga di Bond al Marveluniverse), sembra che l’unica strada percorribile sia l’eterna riproposizione del già visto, in ossessive permutazioni.
Questi tre casi – filosofia, scienza e arte – sembrano delineare una tendenza comune: la creatività, intesa come originalità dirompente, è in declino in molti settori. Se questa analisi contiene qualche elemento di verità, dovremmo chiederci come mai. Un paio di spiegazioni, con buona pace dell’innocente stupore dell’articolo di Nature, non sono difficili da cogliere. La prima è sintetizzabile così: l’originalità non è né politicamente corretta né democratica. La seconda è: il nuovo non è contenuto nel vecchio. Sembrano due ovvietà, ma si può notare come le tre aree – scienza, filosofia e arte – siano, almeno in una certa misura, prigioniere del proprio passato, anche se con meccanismi diversi.
Nel caso della musica e del cinema, il principale responsabile è, naturalmente, il successo commerciale che aborre il rischio. Un nuovo prodotto deve essere, come suggeriva il compositore ottocentesco Robert Schuman, come una canzone che «nessuno ha mai sentito, ma che tutti ricordano». Il numero di “mi piace” sui social network, di visite sui canali Youtube e di download su Spotify premia chi propone un usato sicuro. È quasi impossibile farsi spazio senza una base già affermata.
Per quanto riguarda la produzione scientifica e filosofica, un po’ come per i personaggi dei drammi di Shakespeare, è la virtù che porta alla perdizione. Come ha notato il filosofo Luciano Floridi in una discussione sul tema, la revisione dei pari (il cosiddetto peer review) «funziona male, ma senza il sistema funzionerebbe ancora peggio, basta pensare a quando, per pubblicare un articolo, serviva conoscere il barone di turno». Ha ragione, non si vedono alternative. In pratica, le riviste svolgono un ruolo di selezione e ogni nuovo articolo viene sottoposto al giudizio dei colleghi che decidono se sia o non sia degno di essere pubblicato. L’intento è lodevole e punta a evitare favoritismi e, nei limiti del possibile, proporre un criterio oggettivo (o almeno inter-soggettivo). Floridi non ha torto. Parafrasando Winston Churchill, il peer review avrà anche i suoi difetti, ma è il migliore metodo tra tutti quelli proposti finora.
Tuttavia, in questo meccanismo, è insito il rischio del conservatorismo. Il lato oscuro del metodo di valutazione è il fatto è che chi giudica, spesso si sente giudicato (magari dal redattore, magari dai colleghi, magari dal suo settore disciplinare) e si chiederà come verrà valutato per la sua valutazione … Un circolo vizioso che esiste e che non può essere sempre assolto giocando la carta, tanto amata dalle anime belle, dell’oggettività dei revisori. Quando la disciplina non ha un oggetto ben definito (come potrebbe), non esiste una valutazione oggettiva. L’unico oggetto a disposizione è, ovviamente, il materiale che arriva dal passato che però, per definizione, non può prevedere gli sviluppi futuri.
Nella storia del pensiero ci sono due tipi di idee: quelle oggettivamente difficili da capire (come la relatività generale) e quelle che sono semplicemente diverse da ciò che si era sempre creduto. Per esempio, l’eliocentrismo non è affatto un’ipotesi difficile da comprendere. Oggi qualsiasi bambino lo capisce già alle elementari (se non prima): il sole è al centro del sistema solare e la terra gli gira intorno. Che c’è di difficile? Eppure, nel Cinquecento, quando Copernico lo propose, moltissime persone di ottima cultura lo reputarono al limite dell’incomprensibilità! Come mai? Perché metteva in discussione l’idea, consolidata nei secoli, che la terra fosse al centro dell’universo. Troviamo difficile ciò che si oppone alle nostre credenze. È una tendenza che resiste al nuovo nelle idee come nelle forme estetiche, nella filosofia come nella musica, nella scienza come nel cinema.

Si può sostenere che la selezione si sia spostata dalla pubblicazione all’impatto. Molto si pubblica ma solo poco ha una effettiva diffusione e influenza, dopo. In parte è vero, ma non del tutto. Non si deve dimenticare che in molti settori (dalle clip musicali alle pubblicazioni filosofiche) il gusto del pubblico è determinato dall’esposizione ripetuta a una certa forma. La gente o gli studiosi selezionano quello che hanno già interiorizzato. Come nella distopia accademica di Herman Hesse nel romanzo Il gioco delle perle di vetro (1943), la società si trova nelle mani di comunità che tendono a difendere l’esistente perché corrisponde a quel sistema di concetti e principi dentro il quale si sono formae e hanno prosperato. Non ci si può aspettare che le persone desiderino contestare i valori dalla cui difesa dipende il loro stipendio.
Valutare il nuovo sulla base dei successi passati è palesemente una forma di conservazione, tanto più quando questo approccio viene supportato da misure quantitative. Introdurre meccanismi di misura, sperando che l’uso di numeri elaborati da algoritmi impersonali, e quindi presupposti oggettivi, produce quel fenomeno indesiderato che, nel 1984, è stato sintetizzato dalla cosiddetta legge di Goodhart: «ogni misura usata per valutare è, a lungo termine, inaffidabile e dannosa». Il motivo è semplice, ogni misura proposta diventa l’obiettivo reale a danno della realtà delle cose. Un esempio banale dal mondo accademico: se i ricercatori sono valutati in base al numero di pubblicazioni annue, assisteremo a una moltiplicazione del numero di articoli a scapito del contenuto. Probabilmente oggi Immanuel Kant non supererebbe le soglie quantitative necessarie per ottenere una docenza. Nessuno indicatore permetterebbe di valutare positivamente dieci anni di passeggiate trascorse a formulare il suo pensiero.
Sempre su Nature, nel 2018, si è osservato come molti autori arrivino a pubblicare (o mettere il loro nome) su un numero enorme di pubblicazioni: fino a una media di 72 articoli all’anno (circa uno ogni cinque giorni). È chiaro che nessuno potrebbe raggiungere questa mole di lavori. Si tratta di risultati che sono l’esito di meccanismi opportunistici con lo scopo di ottenere il massimo punteggio dati gli indici di valutazione. Il problema è che, in questo modo, l’obiettivo diventa la misura e non la realtà. Ovviamente, questo stato di cose incoraggia il conformismo piuttosto che l’originalità; la sicurezza invece del rischio.
Non è una prerogativa solo del mondo accademico. Molti di questi meccanismi hanno l’analogo in altre aree, dalla musica ai post su Youtube. La ricerca della conferma di un pubblico, selezionato o meno che sia, conduce alla stagnazione. Anche nella biologia esistono meccanismi analoghi. Le popolazioni che vivono in grandissimi numeri, come i pesci del mare, hanno un tasso di evoluzione più lento dei piccoli gruppi. Lo squalo e l’aringa sono degli evergreen e sono cambiati relativamente poco in milioni di anni. Sono le piccole comunità isolate, libere dal giudizio esterno, che vedono rapidi balzi (a volte in avanti e a volte no!).
Negli anni Sessanta, il filosofo americano Thomas Kuhn tracciò la famosa distinzione tra scienza ordinaria e scienza straordinaria. Di solito lo si cita in filosofia della scienza, ma credo che avesse colto qualcosa di universale. Secondo Kuhn, le idee si mantengono relativamente stabili, e non si assiste a grandi rivoluzioni finché, piano piano, il sistema di pensiero dominante, che lui chiama paradigma perde il contatto sulla realtà, sclerotizzandosi nella ripetizione scolastica dei modelli passati. Si entra così in un declino che culmina in una crisi che viene incubata dalla prolungata senescenza dei modelli dominanti. Come scrisse il fisico Max Plank, il progresso avanza un funerale alla volta. Grazie a questo declino, finalmente, qualcosa di nuovo rompe il guscio del paradigma dominante e trova il modo di farsi strada. Rompendo con il presente diventato passato, e facendo nascere il futuro in un nuovo presente. La vera innovazione è sempre rottura. È dirompente. Il nuovo non è contenuto nel vecchio. Nella terminologia di Kuhn, la scienza ordinaria è la declinazione delle premesse. La scienza straordinaria invece è dirompente, inaspettata, libera e discontinua. L’impero romano non ha avuto progressi significativi per secoli. E infatti sappiamo come è finito. E noi? Questa crisi di creatività è un affanno momentaneo o il sintomo di un declino cronico?
Riferimenti
Ioannidis, J. P. A., et al. (2018). "The scientists who publish a paper every five day." Nature 561: 167-169.
Kozlov, M. (2023). "‘Disruptive’ science has declined — and no one knows why." Nature 3 Jan.
Muller, J. Z. (2018). The Tyranny of Metrics. Princeton, Princeton University Press.
Goodhart, C.A.E. (1984), Monetary Theory and Practice, London, MacMillan.
Serra, J., et al. (2012). "Measuring the evolution of contemporary western popular music." Sci Rep 2: 521.
Tyler, C. e B. Soutwood (2019). "Is the rate of Scientific Progress Slowing Down?" GMU Working Paper in Economics 21(13): 1-46.
Unger, P. (2014). Empty Ideas. A Critique of Analytic Philosophy. New York, Oxford University Press.