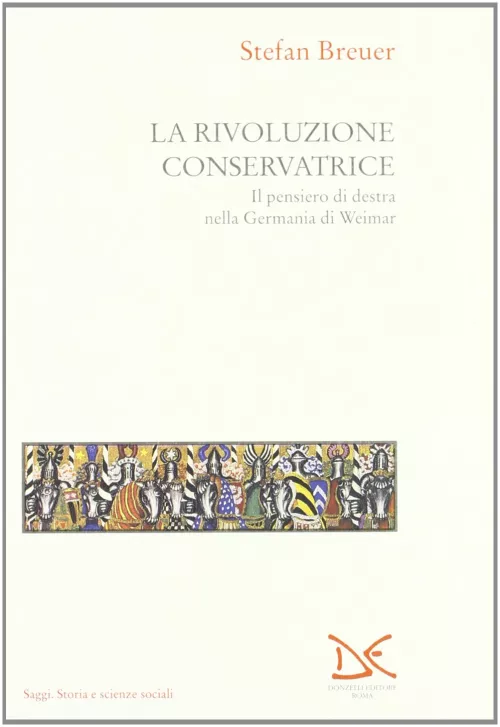Rivoluzione conservatrice?
Il fenomeno delle destre radicali di questo nostro tempo più che essere solo una novità o il segno di una crisi attuale, ha tempi più lunghi, luoghi di formazione culturale e coesiste con la parallela crisi del conservatorismo tradizionale.
È una delle piste di indagine che da anni suggerisce Stéphane François uno studioso francese delle culture di estrema destra (in Francia e in Europa) a cui credo dovremmo prestare attenzione nel suo nuovo studio in uscita in Francia nelle prossime settimane (Une avant-garde d’extrême droite.)
Anziché limitarsi ad analizzare il discorso pubblico o gli slogan o gli atti, François si sofferma in particolare sulla loro produzione culturale. La sua convinzione è che come ogni ideologia politica, anche quell’area ha prodotto una propria contro-cultura, caratterizzata da un profondo aspetto identitario razzista e fondato su una visione del mondo in cui i militanti si sentono avanguardia nella lotta contro il declino dell’occidente e della civiltà occidentale. Una dimensione che fa tornare in auge le profezie di Oswald Spengler, soprattutto del suo Il tramonto dell’Occidente.
Decadenza dunque è una delle parole chiave.
Il concetto di decadenza ogni volta che è comparso nel linguaggio pubblico ha prodotto una lettura della storia che mette in opposizione l’epoca delle origini con il tempo presente che è valutato come smarrimento dei valori fondamentali. In questa chiave il futuro è spesso apparso come un esito della storia interpretato talvolta come definito, o come parte di un ciclo in cui la morte è seguita da una rinascita.
In questo secondo caso si struttura una visione della storia in forma di periodizzazione, in cui si delinea un’idea di linea della storia fondata sulla contrapposizione tra «antichi» e «moderni» e in cui i difensori del concetto di decadenza criticano radicalmente il periodo in cui vivono in nome di valori che ritengono essere stati realizzati nel passato, ragion per cui contestano l’idea di progresso (richiamando talvolta progetti di conservazione e o di restauro del passato o proponendo schemi di riordino e di equilibrio che fanno forza intorno all’idea di utopia) mettendo talvolta al centro della propria polemica lo smarrimento dei costumi tradizionali o il diffondersi del lusso, insistendo sull’influenza negativa dello sviluppo urbano (in nome di un rapporto equilibrato città/campagna), talvolta insistendo sul dato della denatalità o del decremento demografico.
È anche in forza di questa condizione di disagio che ritorna in campo la forza argomentativa della «Rivoluzione conservatrice» a cui una parte delle destre analizzate da Stéphane François si richiama, e che è nuovamente in grado di proporre offerta politica di futuro.
In questo senso è importante riprendere in mano alcuni dei suoi contenuti, scavare nell’immaginario che suscita o negli entusiasmi o nel processo di identificazione che innesta.
Di nuovo non perché il presente sia un’operazione di copia e incolla dal passato, ma perché alcune categorie culturali hanno un fascino, credo, anche in questo tempo presente.
«Rivoluzione conservatrice» è un’espressione intorno a cui si sono accumulati più malintesi che certezze. Se l’ambito di riflessione, circoscritto da questa locuzione è abbastanza determinato – la variegata area di destra tedesca «inquieta» ed «eretica» tra Repubblica di Weimar e nazismo – resta ancora poco esplorato, al più vagheggiato, l’ambito tematico che la connota.
«Rivoluzione conservatrice» è un’espressione su cui nel tempo si è costruito un doppio mito: quello della visione alternativa per antonomasia al processo della modernità industriale e quello legato a una visione «antistorica» della storia, dove la modernizzazione è vissuta come il pesante cingolato che travolge e dissolve il nocciolo duro della Tradizione.
Fenomeno e ideologia della «terza via», in cui contemporaneamente entrano in gioco la fisionomia «né destra, né sinistra» e quella apparentemente speculare «e destra, e sinistra», la topologia della «Rivoluzione conservatrice» rischia di rimanere indeterminata o di dislocarsi in quel territorio eccessivamente frequentato e sovraffollato da tutte le «terze vie» del Novecento: il fascismo, il nazismo, il planismo, il cattolicesimo sociale e comunitario, il comunitarismo laico a base federalista.
Intanto il concetto.
«Rivoluzione conservatrice» in quanto categoria storiografica è un concetto che è stato introdotto e proposto da Armin Mohler alla fine degli anni’40 del ‘900, poi riproposto e ampliato in una monografia dal titolo Die Konservative Revoution in Deutschland 1918-1932 nel 1972 (una traduzione italiana è comparsa nel 1990).
La sua ricostruzione tende a staccare la fisionomia di quella esperienza – che Mohler intende definire più culturale che non politica – in autonomia rispetto al profilo che negli stessi anni in Germania viene assumendo il partito nazista.
Il tema come vedremo tra poco non è banale, perché una delle fortune culturali, che ha incontrato l’immagine della «Rivoluzione conservatrice» a partire dagli anni ’70, è stato proprio quello di riprendere in mano quel malessere che era stato proprio degli anni ’20 del Novecento: il venir meno della produzione agricola, lo sviluppo industriale, la lenta erosione a partire dagli anni’70 di un’idea di futuro progettabile e di proporlo come un segmento rilegante di una ideologia critica dello sviluppo al netto delle analogie, delle prossimità linguistiche (il che vuol dire anche dei significati) o anche delle connessioni con quel precedente.
Dunque consentendo per questa via una reimmissione nel linguaggio politico pubblico senza dover pagare il «pedaggio» di un confronto con le prossimità del passato.
Questo processo, non a caso all’inizio degli anni ’90 sarà proprio il punto argomentativo di forza con cui interverrà Stefan Breuer, in una stagione in cui il fascino per il radicalismo di destra nella Germania successiva all’unificazione trovava nuove vie di diffusione.
La necessità di ripensare le forme del progresso e l’idea di sviluppo, che discendono da quella sensazione o da quel rinnovato senso di “smarrimento” hanno come conseguenza la riacutizzazione dell’immagine della tecnica come nuovo dispotismo, un tema che ripropone negli anni ‘70 e ‘80 le angosce nei confronti della tecnica non come qualcosa «nelle mani dell’uomo» ma come qualcosa a cui l’uomo appartiene, un tema che rende di nuovo “attuale” il Martin Heidegger del suo rettorato tra 1933 e 1934, ovvero il tempo del suo fascino per il nazismo.
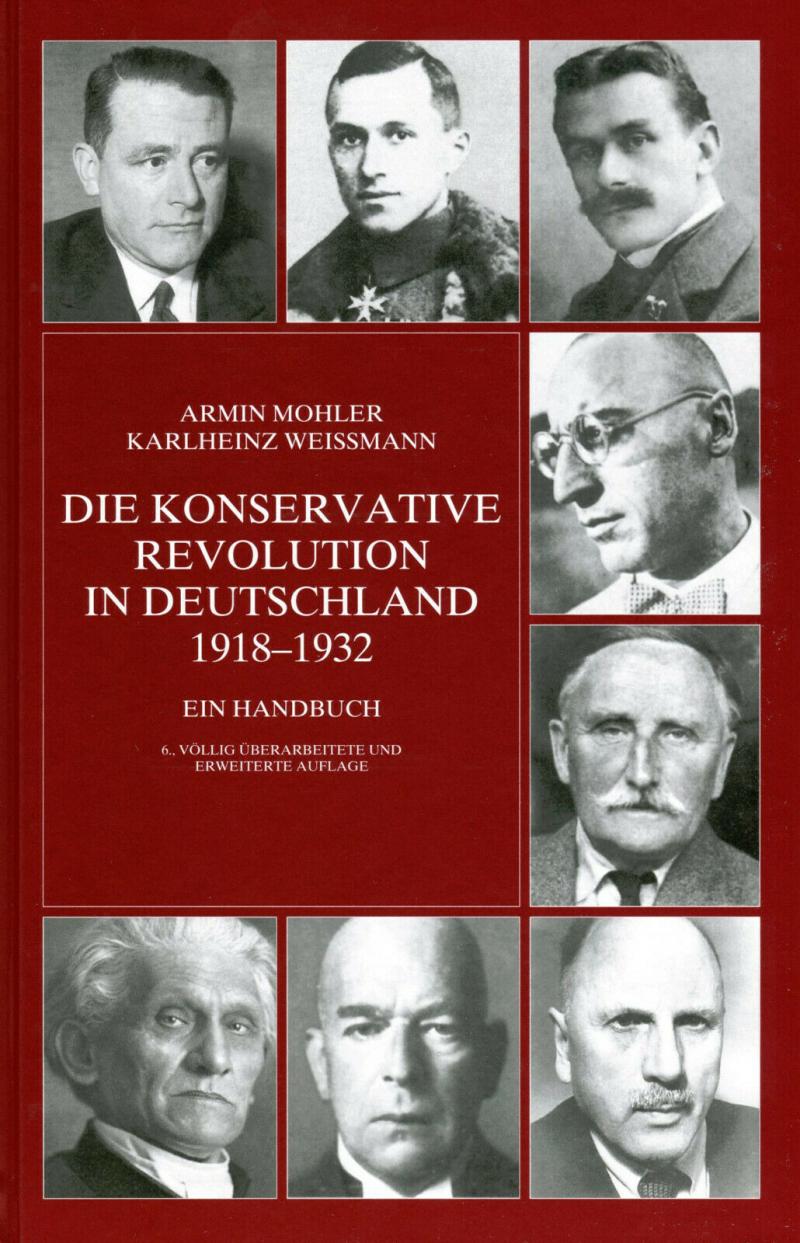
Il primo aspetto è dunque dato dalla convinzione che se la linea di sviluppo tende alla distruzione dei vincoli comunitari che fondano il patto nazionale, la prima replica è ritrovare il senso dell’appartenenza nazionale come risposta autonoma rispetto all’“omologazione”.
È un tratto che presentano molti le ideologie nazionaliste tra fine ‘800 e prima metà del’900 – sottolinea Mohler: Maurice Barrès e Georges Sorel in Francia; Dostoevskij in Russia; Vilfredo Pareto e Julius Evola in Italia; Vladimir Evgen’evič Žabotinskij nel movimento sionista. Ma anche un teorico della rivoluzione dei manager con James Burnham non è esente.
Il secondo aspetto è quello che riguarda la vicenda temporalmente definita della Germania di Weimar su cui Mohler costruisce gran parte della sua monografia e su cui interviene criticamente Stefan Breuer.
Il tema su cui Mohler insiste è quello di una generazione che esce dalla guerra convinta di essere vittima dei poteri forti, che ha un’attrazione per quelle forme di rivoluzione che si contrappongono al modello restaurativo anche partecipato per la ricostruzione del dopoguerra. La sua è un’opposizione sia alla classe politica tedesca che accetta la sconfitta e subisce il ricatto delle sanzioni del sistema di Versailles, sia di chi prova a ricostruire una nuova economia basandosi su un patto di compromesso con i nuovi poteri che provano a pensare Europa. Walter Rathenau, per esempio, il ministro dell’economia che gli esponenti della destra estrema uccidono nel giugno 1922 come poi racconterà uno dei membri del gruppo terroristico Ernest Von Salomon nel suo I proscritti.
Un progetto di esecuzione fondato su un disegno di forte rivendicazione identitaria, pensando alla rivoluzione russa come atto contro i poteri occulti dell’Occidente. Un’immagine che non sarà estranea a una parte non indifferente del mondo fascista italiano ancora alla metà degli anni ‘30
Un’esecuzione che avviene anche in forza della solitudine dell’uomo pubblico Rathenau, come poi scriverà Stefan Zweig nel suo Il mondo di ieri.
Raramente – scrive Zweig – ho sentito la tragedia dell’uomo ebreo più fortemente che in lui, nella sua profonda inquietudine pure accanto all’apparente sicurezza. Altri miei amici (…) non erano neppur lontanamente così acuti e così universali, così internazionali nelle loro cognizioni, ma avevano la sicurezza di sé medesimi, mentre in Rathenau si intuiva sempre che ad onta della smisurata sapienza non aveva terreno saldo sotto i piedi. (…) Soltanto nell’ora della responsabilità, allorché dopo il crollo militare, nel 1919, gli fu imposto il compito più duro, rendere di nuovo vitale lo Stato sconvolto strappandolo al caos, le inaudite forze che esistevano in lui potenzialmente si trasformarono d’un tratto in energia unitaria. Ed egli si creò la grandezza innata al suo genio, prodigando la propria vita per un’unica idea: salvare l’Europa.
Salvare l’Europa, probabilmente ora come allora voleva dire andare oltre il proprio “io nazionale” e pensare un’altra forma di patto per lo sviluppo. Un progetto a cui lavorano gli intellettuali francesi e tedeschi (Henri Barbusse e Heinrich Mann) che fondano nel 1923 una rivista bilingue – «Europe» – che significativamente durerà fino al 1939 e che nel tempo è destinata a raccogliere le molte voci inquiete dell’Europa (non solo democratiche o di sinistra, ma anche di destra, per esempio vi scriverà Drieu la Rochelle). Esperienza che, tuttavia, sopravvive a se stessa e non crea nuovo linguaggio.
L’ipotesi alternativa, il pensarsi «terza via» tanto rispetto al modello ricostruttivo uscito dal sistema di Versailles, tanto dal sistema comunista congelato dopo il 1921 nei confini russi, non passa per quella ipotesi europeista. È invece il linguaggio della nazione che diventa alternativo. Quel linguaggio, se anche non approda alla «Rivoluzione conservatrice», ne lascia la nostalgia.
Un linguaggio definito dai diversi destini dei gruppi che si riconoscono nella ideologia della «Rivoluzione conservatrice». Una geografia che Mohler descrive con precisione e che ci è utile anche per comprendere le diverse famiglie culturali e sociali che solo in parte poi confluiscono o sono assorbite nel nazismo regime.
Un primo gruppo si riconosce nella teoria della “razza”, o comunque legge l’identità germanica come tratto etnico fondato sul recupero dei caratteri originari primitivi, nordici (“popolo”, “stirpe”, “paesaggio”, “lingua”). Alcuni elementi di culturali e ideologici passeranno nell’ideologia nazista anche se non tutti coloro che inizialmente si riconoscono in questo gruppo approderanno al nazismo.
Un secondo gruppo è costituito dai “Conservatori”. La loro caratteristica culturale è quella di dichiararsi in opposizione al processo di modernizzazione. Al centro del loro progetto non sta la comunità, ma il concetto di Reich. Con questo termine non intendono uno Stato nazionale chiuso e costituito da un’unica popolazione, ma piuttosto alludono a un superstato, una sorta di Commonwealth. Il “Reich” è così un sistema di governo che si pone al di sopra e al di là dei singoli popoli.
Un terzo gruppo è costituito dai “Nazionalrivoluzionari” e trae la sua origine dal mito della comunità definito e dall’sperienza bellica. Hanno tratti simili all’esperienza del primo arditismo italiano e hanno la fisionomia di un movimento. Auspicano il superamento della distinzione destra/sinistra. Fa riferimento a questo principio un’idea di Europa che guarda alla ricongiunzione con il mondo orientale, e dunque con la Russia mentre soprattutto avvertono che il nemico strutturale – sociale, ma soprattutto culturale – è rappresentato dal modello americano inteso come corruzione del costume europeo.
Il quarto gruppo è invece un gruppo che riedita in parte l’esperienza dei movimenti giovanili del periodo guglielmino e dunque ripropongono il mito della natura, del rapporto con l’idea di Germania. In gran parte verrà assorbito o assunto nell’esperienza della HitlerJugend ma non necessariamente si identificherà con quella.
Il quinto gruppo infine ha caratteri più contenuto e si trova essenzialmente nella regione dello Schleswig-Holstein e riguarda soprattutto la sensibilità del mondo contadino. A quel mondo in parte si rivolgeranno sia la socialdemocrazia che il partito comunista negli anni a cavallo della grande crisi, ma con scarso successo.
Se abbandoniamo il confronto tra queste diverse anime, che pure consente di capire i molti percorsi culturali con cui si crea identità nel tempo della crisi, emerge che dietro lo scenario concettuale della «Rivoluzione conservatrice» si cela così un primo mito: quello della sua fondazione come mito politico, come grande macchina mitologica che sollecita una tensione fisica e mentale in quanto mito, che, a sua volta, rigenera mito.
A ragione Stefan Breuer insiste particolarmente su due questioni: da una parte la questione della mentalità degli esponenti della «Rivoluzione conservatrice»; dall’altra il complesso e complicato rapporto che i «rivoluzionari conservatori» intrattengono con la categoria di «modernità».
Giustamente Breuer ritiene che sia improprio parlare di movimento della rivoluzione conservatrice. Più che un’ideologia quella della «Rivoluzione conservatrice» gli appare come una mentalità. Una mentalità, per di più, che è il risultato di un continuo sovrapporsi di eventi e di condizioni che trova la sua prima espressione nel disagio della modernizzazione guglielmina, che poi si nutre del mito della «giovinezza» negli anni dei primi movimenti giovanili e naturalistici nel decennio a cavallo tra i due secoli e che, infine, viene ulteriormente rivoluzionata dall’esperienza della guerra.
L’esperienza della guerra ha tuttavia un esito doppio:
1) spinge all’estremo la percezione di fine di epoca e la dimensione dell’approssimarsi di una stagione apocalittica dove la categoria della violenza non ha valore in sé ma acquista una sua dignità come espressione del rifiuto sistematico e radicale di una qualsiasi ipotesi di contrattazione sulle regole politiche e su un patto politico fondato su regole impersonali. Non è casuale che il rifiuto dell’ideologia liberale, di una filosofia politica che in qualche modo riconosca a proprio fondamento l’idea di contratto, è forse il tratto comune che attraversa tutta la galleria di figure dei rivoluzionari conservatori;
2) accelera il processo disgregativo-nichilistico, che ne costituisce l’ipotesi fattuale. La figura retorica del «soldato politico» coniato da von Salomon ne riassume per gran parte entrambe le caratteristiche.
Tuttavia, questo doppio aspetto non necessariamente unifica le figure intellettuali riconducibili sotto l’etichetta della «Rivoluzione conservatrice». Ognuno dei suoi esponenti più in vista (i fratelli Jünger, E. Jung, Spengler, Schmitt, Moeller van der Bruck, Niekisch, ...) avrà esiti diversi: alcuni si identificheranno con l’esito nazista, altri vi si opporranno, altri si collocheranno in una scala intermedia di consenso/dissenso.
È il concetto di modernità a segnare molte delle differenze che intercorrono tra di loro. Tra chi vi si contrappone in nome della tradizione che appunto verrebbe dissolta, o che comunque elabora ancora una riflessione legata a schemi sociali della Germania guglielmina, e dunque accentua l’elemento conservativo, a chi invece sottolinea l’aspetto rivoluzionario perché coglie la modernità come l’opportunità di riscrivere le gerarchie sociali sotto l’egida di una società per ordini. Un sistema di ordini il cui principio fondatore non è dettato dalla vecchia nomenclatura per ceti, ma da una mistica della nazione in cui la dimensione di comando è in funzione della nuova collettività politica e non fondamento della stessa (è questo il punto di cesura su cui si consuma il rapporto con il nazismo ormai trionfante di molti rivoluzionari conservatori).
Una idea di modernità che legge il «moderno» attraverso l’avvento di un’«età della tecnica» e dunque come mistica dell’ordine.
La modernità, anziché conflitto tra sfere parziali dell’individuo, assume, agli occhi dei rivoluzionari conservatori, la dimensione di scrittura organica dell’individualità che risolve la propria insufficienza in una mistica organicistica della società. Una tecnica che non è strumento di razionalità ma luogo recondito e fonte originaria dell’ordine; che è codice e reticolo concettuale capace di disaggregare la razionalità occidentale. Una dimensione tanto aborrita, quest’ultima, da auspicare l’esaltazione e il recupero strumentale persino della psicoanalisi – forse l’ambito disciplinare più antitetico al paradigma culturale dei rivoluzionari conservatori, recupero che comunque è illuminante sul loro non essere dei semplici «passatisti» – perché intravista come lo strumento più efficace di disaggregazione proprio di quella razionalità assunta come antitesi al progetto di una comunità originaria, il loro mito politico «soreliano» e il cui patto societario andrebbe riscritto sotto il fuoco di una vagheggiata «Età dell’acciaio».