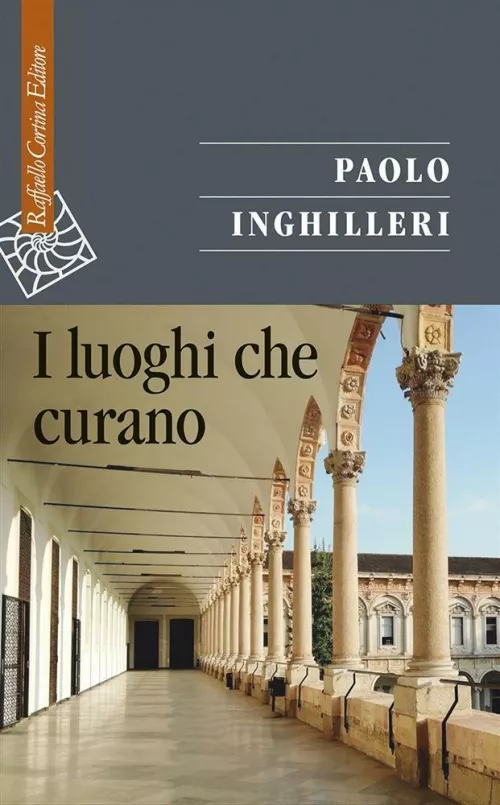Vita e pandemia / Il tempo della cura
Mi è già capitato di scriverlo su La Repubblica: questo è il tempo della cura ma non tanto nel senso clinico del termine – bisognerebbe anzi soffermarsi un po’ sui rischi di un’eccessiva medicalizzazione della vita – ma nella sua accezione esistenziale, che è del resto consustanziale alla vita umana. L’immancabile riferimento filosofico per questo distinguo è Martin Heidegger che in Essere e tempo differenzia la cura in senso medico (Kur) da quella in senso esistenziale (Sorge) resa bene anche dalla distinzione inglese tra i verbi to cure, curare, e to care, prendersi cura, interessarsi, partecipare emotivamente alle sorti di qualcuno.

Mentre in questi mesi di malattia pandemica la cura medica, seppure tra mille difficoltà, disfunzioni e falle di sistema, ha tutto sommato funzionato bene – soprattutto grazie alla straordinaria dedizione del personale sanitario – la capacità politica di prendersi cura della qualità della vita si è invece rivelata gravemente lacunosa. È sicuramente difficile fare bene e non scontentare nessuno di fronte a una pandemia di simili proporzioni, ma non si può restare indifferenti di fronte ai dati preoccupanti del disagio psico-affettivo con i quali dobbiamo fare i conti. Secondo uno studio del Journal of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, nei giovani tra i 10 e i 25 anni, i suicidi, già seconda causa di morte, sono aumentati del 20% durante l’isolamento sociale dovuto alla gestione della pandemia e lo stesso può dirsi per le forme di disagio psichico più diffuse, quali depressione, ansia, disturbi dell’alimentazione, comportamenti autolesionistici, insonnia, e così via. Il prezzo che stiamo pagando per questa forma di trascuratezza politica del malessere esistenziale è altissimo e ancora difficilmente calcolabile, se teniamo conto anche dell’aumento delle violenze domestiche. Un disagio che si è ignorato e che si fatica tuttora ad affrontare. Non era inevitabile: la chiusura indifferenziata e immotivata delle aree all’aperto, che con i giusti accorgimenti della mascherina e della distanza di sicurezza avrebbero potuto garantire una relazione feconda e riappacificante con la natura e sereni scampi di socialità (la superdiffusione, dicono gli studi, avviene in ambienti chiusi come uffici, scuole, supermercati, mentre è quasi del tutto assente nei grandi spazi all’aperto, come i parchi, le spiagge, le montagne, ecc) ha trattato la socializzazione come un lusso che non potevamo permetterci, anziché riconoscerlo come il principale antidoto alla malattia, dopo l’astensione dal fumo, l’esercizio fisico e una dieta sana (Zeynep Tufekci, The Atlantic, Stati uniti, Gli errori che hanno aiutato il virus, L’internazionale, 12/18 marzo, 2021, pp. 40-48).

In una poesia intitolata “Mercoledì delle ceneri” T. S. Eliott prega Dio di “aiutarci ad aver cura e non a curare”, perché la capacità di capire quando la cura vada declinata secondo il primo o il secondo paradigma è di vitale importanza, ma in questo mio intervento, prendendo spunto da due recenti testi sulla cura – uno filosofico , l’altro di psicologia sociale – vorrei piuttosto evidenziare la necessità di promuovere un approccio volto a tenerli insieme perché non c’è nessuna cura medica efficace se non c’è anche cura nel senso pedagogico del termine. Al reparto riservato ai malati covid dell’ospedale Le Molinette di Torino, ad esempio, il personale medico e infermieristico ha osservato come la possibilità di vedere fisicamente i propri cari durante il ricovero avesse aumentato le percentuali di guarigione e ridotto i tempi di degenza.
La cura di cui entrambi i libri parlano, va intesa come capacità di holding, presa a cuore, partecipato interesse psico-affettivo, attivazione dell’intelligenza emotiva, lucida ma coinvolta, capace di empatia e intrinsecamente relazionale. Una lezione che impariamo sin dalla nascita al punto che, per il genere umano, si potrebbe dire, parafrasando Genesi, “all’inizio era la cura”. I neonati umani sono, infatti, tra le diverse specie animali, quelli che richiedono un accudimento particolarmente presente e duraturo senza il quale, semplicemente, il cucciolo d’uomo non potrebbe sopravvivere. L’importanza di queste prime esperienze di cura genitoriale e ambientale sono state ben analizzate dagli studi della psicologia e della pedagogia dell’attaccamento, dalla celebre trilogia di John Bolwby in poi (Attaccamento e perdita, in tre volumi pubblicati tra il 1976 e il 1983 editi in Italia da Bollati Boringhieri), ma è Heidegger a riconoscere come la cura accompagni l’intera esistenza umana, nelle sue forme positive o difettive, autentiche o inautentiche, e costituisca un aspetto ontologicamente pregnante dell’essere al mondo.
Non c’è vita senza cura, se non si vuole farla scadere a mero dato biologico. È la cura, infatti, a orientare la vita verso una forma che possa valorizzarne le qualità, salvaguardarne la dignità, svilupparne le potenzialità, permetterne l’espressione e, quando ci riesce, favorirne la piena fioritura. È ad essa che dobbiamo la capacità di sviluppare e stabilizzare un maggiore gusto per la vita, caratterizzato, ci aiuta a comprendere Luigina Mortari nel suo recente Politiche della cura (Cortina, 2021), da una “buona disposizione d’animo (traduzione del greco eunoia) sostanziata “dalla chiarezza del pensare e dalla purezza del sentire” al servizio di una conoscenza che “non è rispecchiamento di ciò che è già accaduto, ma tensione a far accadere il possibile nella sua forma migliore” (p. 142).

Questo intento – che come mostra il libro attraversa l’intera filosofia antica, ma può essere opportunamente perseguito anche ai giorni nostri – si orienta in quattro fondamentali direzioni: “cura di sé, del proprio divenire nelle sue potenzialità più proprie; cura degli altri, perché vivere è convivere; cura della natura, perché ne siamo parte; cura del mondo” nella sua complessità (pp. 48-49). Sono orientamenti che si trovano presenti in tutte le filosofie antiche che, come apprendiamo in particolar modo dall’insegnamento di Pierre Hadot, richiedono che l’individuo trascenda la propria centratura egoica per riconoscersi intessuto da ciò di cui si prende cura (nel primo caso, non identificandosi col dato in atto ma con le potenzialità d’essere che ospita). È importante sottolineare, come fa Mortari, che questa cura, partecipe alle sorti di ciò che, senza adeguate cure, potrebbe non svilupparsi mai o non farlo appieno, parte dalla realtà contingente e concreta alla quale “obbedisce”, con un buon esame di realtà, solo se non ne trascura né le effettive attualità né le recondite potenzialità. È per questo, sempre, un’attività etica nel senso aristotelico dell’attivazione di potenzialità dell’anima secondo ragione e secondo virtù, liberandola dall’inerzia irriflessa – apatica o indaffarata – che spesso l’imprigiona. Ma non si equivochi: la cura non si dà come ripiegamento del soggetto su di sé, al contrario: il suo cuore etico sta nel riconoscimento che i beni relazionali sono i più importanti per lo sviluppo della nostra fioritura e costituiscono, per noi, “il più alto valore esistenziale” (p. 162).
Su questo crinale, appena accennato da Mortari, si muove, secondo un orientamento psicologico, il libro di Paolo Inghilleri, I luoghi che curano (Cortina, 2021). In questa prospettiva, come si evince sin dal titolo, il carattere sociale dell’essere umano è messo in primo piano e fatto risaltare, in particolar modo, dall’analisi delle interazioni con quelli che chiama “beni comuni”. Con tale definizione, spiega, “non si devono intendere soltanto le risorse naturali, ma anche le capacità di usarle e il diritto, da parte di una comunità, di godere dei loro frutti. È interessante notare come entri in gioco un secondo punto indissolubilmente legato al concetto di bene comune, cioè quello dei nostri vissuti e delle relazioni tra persone” (p. 57) – aspetto che ritengo enormemente trascurato dai dpcm che si sono susseguiti in questi mesi.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità, inascoltata, spiega da tempo come “la salute mentale e molti disturbi psichici comuni siano ampiamente influenzati dagli ambienti sociali, economici, fisici in cui le persone vivono; (…) di conseguenza, agire per migliorare le condizioni della vita quotidiana prima della nascita, durante la prima infanzia, in età scolare, in famiglia, nel lavoro e per gli anziani, offre l’opportunità per migliorare la salute mentale della popolazione e ridurre il rischio di disturbi mentali” (p. 59). Prendersi cura di tutto ciò significa preservare la salute, prevenire il dilagare di malesseri gravi, favorire la salute privata e pubblica, prendersi a cuore le possibilità esistenziali della vita di ciascuno. È interessante, in questo senso, il concetto di “memi”, le unità di base della cultura analoghe ai geni per la biologia con i quali, si è scoperto, interagisce. Ciò significa che lavorare a una cultura che sappia valorizzare interesse, empatia e partecipazione alla sorte di tutto ciò di cui si prende cura – anche ai fini egoistici, ma nell’interesse di tutti – promuoverebbe una diversa disposizione alla vita, che sarebbe avvertita come soddisfacente, buona e degna di essere vissuta (p. 112).
Queste condizioni vanno non solo garantite dallo Stato ma esercitate dai singoli cittadini se si vuole sviluppare quella che l’antropologo indiano Arjun Appadurari ha chiamato una “democrazia profonda” perché capace di salvaguardare anche i diritti della cittadinanza psicologica. Questa condizione richiede che non si tratti con paternalismo i cittadini ma li si coinvolga, per quanto possibile, nelle scelte politiche fondamentali della loro esistenza, li si riconosca attivamente coinvolti nella cura dell’ambiente sociale e naturale nel quale si muovono, anziché considerarli semplici esecutori di protocolli impartiti dall’alto. Nella gestione del covid, come ha osservato, tra gli altri Zeynep Tufekci, ciò avrebbe significato mettere noi cittadini nella condizione di avere maggiori informazioni sul funzionamento della diffusione del covid, ampliare i comitati tecnico scientifici a personalità del mondo delle cosiddette scienze umane, valorizzare le risorse della biophilia – l’amore per le forme di vita e i suoi effetti sul nostro sistema immunitario e sugli effetti patogeni dell’ambiente (pp. 124-126) – anziché costringerci a un indifferenziato e irrazionale ritiro dal mondo, sottoponendoci, tra l’altro, a una serie di leggi talvolta difficilmente comprensibili e, non di rado, in contraddizione tra loro.
Il libro di Inghilleri si profonde infatti in un vasto, e a tratti un po’ troppo sbrigativo, elenco degli effetti terapeutici dell’interazione umana con i luoghi, gli oggetti – materiali e culturali – della nostra civiltà, la natura, i paesaggi, le architetture e gli orizzonti di senso capaci di nutrire il nostro gusto per la vita e la nostra democrazia che, se opportunamente gestiti, avrebbero potuto costituire una fonte di cura del nostro disagio in tempi di covid, e potrebbero tornare a svolgere più strategicamente questa funzione quando l’attuale emergenza sanitaria sarà terminata. Tale approccio, che possiamo chiamare sistemico, ha il merito di fare i conti con la complessità della vita di cui la pandemia non è che un aspetto. Per affrontare adeguatamente entrambi, vita e pandemia, è fondamentale apprendere il sapere e le pratiche della cura di cui, come ritengo da tempo, la filosofia è una delle massime espressioni.