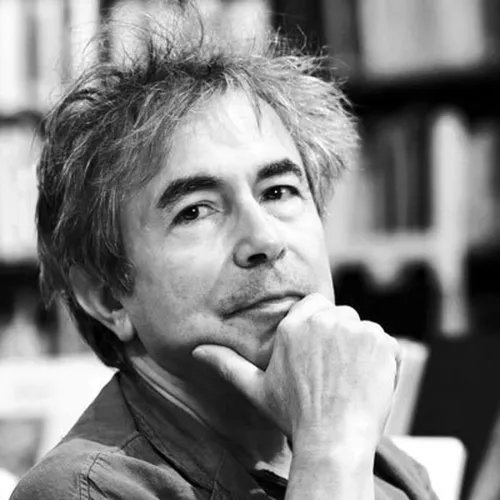La vita come processo / François Jullien, sul vivere
In principio il détour, la deviazione per la Cina. Non per esotismo di maniera, per seduzione ingenua dell’Altrove, ma per fare di quell’Altro assoluto costituito dal pensiero cinese un “apriscatole” grazie al quale accedere a quel che non pensiamo più a pensare: le evidenze che diamo per scontate, gli a priori nascosti, le rive in cui scorrono i nostri pensieri o l’occhio con cui guardiamo il mondo, avrebbe detto Wittgenstein. È così che François Jullien (nato nel 1951), esperto di filosofia greca, negli anni Settanta si stacca dall’“Europa dagli antichi parapetti” (Rimbaud, Il battello ebbro) per incontrare la cultura di matrice confuciana, formatasi in totale estraneità rispetto all’Occidente. La lezione proto-strutturale di Marcel Granet – l’autore di Il pensiero cinese (1934, Adelphi, 2018) – si arricchisce del ricorso all’“eterotopia” suggerita da Michel Foucault: solo facendo incontrare ciò che non si è mai incontrato, solo ponendosi a distanza (lo spaesamento di Lévi-Strauss), una cultura ha l’occasione di riflettere su di sé e sui propri impensati. Siamo chiamati, nell’epoca dell’uniformità globalizzata, a una vera decostruzione, quella che si opera solo muovendo dall’esterno: per “uscire” da noi stessi e rendere di nuovo inventiva la filosofia occorre entrare in un altrove. In caso contrario ci rimane sfuggente proprio quel che è più difficile da cogliere: “Possa Dio provvedere il filosofo di uno sguardo acuto per ciò che sta davanti agli occhi di tutti”, suggerisce il Wittgenstein dei Pensieri diversi.
Il faccia a faccia fra le due fonti – filosofia greca e religione ebraico-cristiana – della cultura dell’Occidente e la tradizione cinese non mira a far emergere differenze, secondo l’abusato gioco del comparativismo. Sfuggendo il pigro universalismo che ritrova nell’altro sempre se stesso e che estende all’umanità intera le categorie formatesi nello sviluppo contingente dell’Occidente, l’uso filosofico della Cina proposto da Jullien si pone l’obiettivo di far emergere scarti concettuali, grazie ai quali disfare le “pieghe” già tracciate nel campo del pensabile. Gli scarti aprono una dissidenza all’interno della filosofia, fanno rinascere l’inquietudine e mettono in tensione il pensiero: sfruttando le risorse offerte da concetti nomadi, costruiti nello spazio “tra” forme diverse d’intelligibilità, diventa possibile aprire varchi su campi inesplorati. Lungo questo percorso, scandito ormai da più di 40 testi (quasi tutti tradotti in Italia), l’opera di Jullien – docente all’Università di Parigi 7, dove dirige l’Institut de la Pensée contemporaine – restituisce un margine di manovra alla filosofia – incagliata nel riproporre le sue antiche domande –, a cui affida una vocazione nuova, trans-culturale e trans-linguistica. La cultura della Cina è passata accanto ai concetti forti del nostro pensiero: ha accantonato la riflessione sull’Essere, su Dio, non ha fatto della Verità un’ossessione, né si è affidata al potere della Parola. Il suo mondo non conosce il logos, quantomeno nelle modalità elaborate da Platone e Aristotele, forse perché è rimasta pressoché indifferente di fronte al mythos e all’epopea.
Nel cantiere sempre aperto di Jullien si è via via rarefatto il confronto tra filosofia e pensiero cinese, esemplarmente promosso in Il saggio è senza idee (Einaudi, 2004), o in Strategie del senso in Cina e in Grecia (Meltemi, 2004). La Cina continua ad agire, ma in modo sotterraneo, offrendo “risorse” per “filosofare in altro modo”, soprattutto per (tornare a) pensare quel che da noi la filosofia ha tralasciato, vale a dire il vivere stesso. Philosophie du vivre (Gallimard, 2011, il solo scritto rilevante di Jullien non tradotto in italiano) indicava fin dal titolo l’apertura di un “ciclo” relativo a ciò che ostinatamente resiste all’astrazione e al concetto: vivere e non “la vita”, nozione già astratta, che si può ritagliare e disporre lungo un segmento con inizio e fine. La filosofia, rileva Jullien, essendosi affidata all’Essere e alle sue categorie, non ha poi trovato le risorse per accostare quel che si può intendere solo in termini di processo, come ben sapeva Hegel: “das Leben als Prozess”. Come accedere dunque al vivere se questo non si lascia porre a distanza come “oggetto” di conoscenza, essendo ciò in cui ci si trova coinvolti fin dall’inizio e da sempre implicati?
Questo nuovo ambito di riflessione è in realtà l’esito di un percorso che risale lontano, già avviato in Processo o creazione, il primo libro di Jullien tradotto in italiano (1989, Pratiche, 1991). I missionari gesuiti, giunti in Cina a fine Cinquecento con l’obiettivo di convertire al Cristianesimo gli intellettuali di corte (vecchio sogno diffuso da Marco Polo), non trovarono un ideogramma per tradurre il termine “creazione”, ignoto alla lingua-pensiero della Cina. L’idea di un Assoluto trascendente, in grado di compiere il passaggio dal Nulla all’Essere, non ha fatto presa, non ha assunto consistenza: la nozione arcaica di un “Signore dell’alto” si è poi tradotta nel Cielo, che non equivale al divino, all’aldilà, ma è il partner dell’opacità materiale della Terra nel promuovere il rinnovarsi continuo del mondo, istanza regolatrice del processo che si rivela nel corso regolare della natura. Non c’è dunque posto per l’immagine del Dio benevolo della Genesi che agisce in vista di un fine, o del Demiurgo platonico che plasma il mondo in base a un modello ideale di perfezione.
La Cina non si inquieta dell’origine, dell’arché da cui hanno preso avvio l’interrogare filosofico e, prima ancora, i miti cosmogonici, come la Teogonia di Esiodo. Quelli che impropriamente chiamiamo Dialoghi di Confucio (fra il VI e il V secolo a.C.) si dichiarano indifferenti all’indagine sulla physis, e anche i due grandi classici del taoismo – il Tao the Ching, “Classico della Via e della Virtù”, che la tradizione attribuisce a Laozi, il “maestro venerabile”, e lo Zhuangzi – restano in silenzio sulla questione. La realtà è un processo continuo scandito dall’alternanza di fasi opposte e complementari – fasi e non elementi, come erano le radici di Empedocle o gli atomi dei presocratici. La dualità di forze differenti promuove la tensione reciproca che tiene costantemente in moto il mondo, seguendo la Via, il Tao: yang, il maschile, tende all’espansione, yin, il femminile, alla concentrazione, di qui l’alternarsi di inspirazione ed espirazione il cui modello è il moto del drago. La dualità, e non il dualismo, di forze in interazione si manifesta nel ciclo inesauribile delle stagioni; il corso regolare della natura è il fondo di senso, il fondo di evidenza della cultura confuciana, certo derivato dall’essere stati i Cinesi un popolo di coltivatori, attenti alla fecondità della Terra. La tradizione ebraico-cristiana sorge fra popolazioni di pastori in cui l’intervento diretto dell’uomo, attraverso comandi e costrizioni, è determinante. Da noi la parola è azione, anche Dio “fa essere” pronunciando il “fiat”: in principio era il verbo, dice il Vangelo di Giovanni, e la stessa Rivelazione passa attraverso la parola o la parabola. L’agricoltore invece confida che il risultato si ottenga da sé, una volta innescate le condizioni per lasciar evolvere il processo di maturazione. L’immagine più pertinente ci è fornita dalla crescita delle piante, ricorda Mencio (IV secolo a.C.), erede spirituale di Confucio: non bisogna tirare i germogli per farli crescere, nemmeno però si deve tralasciare di sarchiare per farli spuntare.
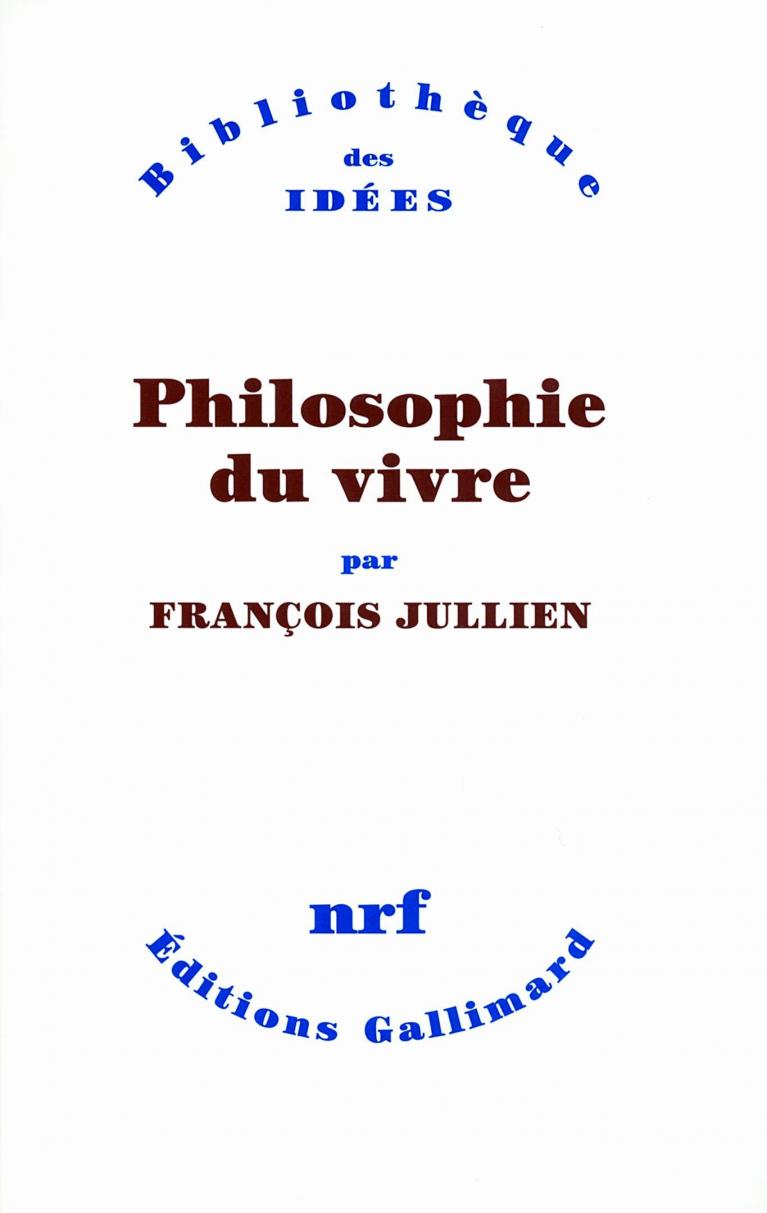
Se il pensiero della creazione valorizza l’istanza volontaria del soggetto agente, nell’intelligenza strategica della Cina l’importante è lasciar fare, agire in modo discreto, nei primi momenti, evitando la spettacolarità delle gesta eroiche o titaniche (si veda Trattato dell’efficacia, Einaudi, 1998). Ci si attende l’effetto dalla logica interna al processo stesso, dalle sue sole “propensioni”: il termine, usato da Longobardi, il gesuita siciliano che raccolse l’eredità missionaria di Matteo Ricci, viene ripreso da Leibniz e, più vicino a noi, dal Popper che riflette sulla svolta della fisica del Novecento. È questa la funzione assolta dal Classico delle mutazioni (I Ching), un testo le cui origini divinatorie risalgono probabilmente al IX secolo a.C., su cui Jullien si è soffermato in Figure dell'immanenza. Una lettura filosofica del I Ching (1993, Laterza 2005). Gli esagrammi formati da linee continue (yang) o spezzate (yin), ottenuti dal combinarsi degli steli di achillea, forniscono indizi sullo stadio germinale in cui già è presente, anche se ripiegato e latente, il futuro che sta per rendersi manifesto.
La radice ji del titolo indica appunto l’infimo inizio, l’impercettibile avvio del processo regolato da una coerenza interna (li), in cui si esprime l’energia universale (qi). Il saggio (e lo stratega) può così “sposare” la propensione contenuta nel potenziale di situazione, cogliere in ogni venatura o fibra del processo un “innesco” della trasformazione a venire. L’occasione che si offre non è il Kairos divinizzato dai Greci, l’istante fuggevole in cui il caso apre lo spazio per l’audacia dell’azione; è invece la congiuntura favorevole, il momento propizio con cui porsi in sintonia, senza le forzature dell’agire arrischiato che vuole imporre i suoi progetti al mondo. In quella sorta di dizionario che è Essere o vivere (Feltrinelli, 2016), dove Jullien pone in tensione gli “scarti”, non le differenze, che il suo cantiere ha aperto fra la cultura cinese e quella dell’Occidente, la prima delle venti coppie oppositive è appunto “Propensione (vs Causalità)”. Il sapere europeo è dominato dal regime della causalità: scire est scire per causas, diceva la scolastica sulla scia di Aristotele, rendiamo conto di qualunque ente attraverso ciò che lo determina da fuori, a partire dalla linearità del contatto o dell’urto. La causa è principio della cosa, solo grazie alla prima possiamo giungere all’esplicazione della seconda. Nel pensiero della Cina le cose non “sono”, ma “propendono”, si inclinano in avanti producendo il rinnovamento, secondo una logica interna di implicazione.
Il pensiero della creazione apre il fossato tra la perfezione del Creatore e la corruzione delle creature, implica una distinzione di piani fra l’eterno e il divenire, un fossato che filosofia e teologia cercheranno in tutti i modi di colmare: servirà un “terzo uomo”, secondo la critica di Aristotele al maestro Platone, oppure il mediatore, Cristo, fra divino ed umano. Nella tradizione idealista della nostra filosofia, il dualismo fra mondo sensibile e ideale, reso esplicito in Platone (si veda L’invenzione dell’ideale e il destino dell’Europa, Medusa, 2011), si è spesso tradotto nella condanna del vivere terreno: dal mito platonico della caverna a Schopenhauer, il visibile ha finito per tradursi in apparenza e illusione, mentre la vera realtà è affidata a quanto resta invisibile ai sensi. Nel pensiero confuciano, al contrario, l’invisibile non assume connotati religiosi o meta-fisici: è il piano della latenza che contiene il dispiegarsi dei possibili a venire. Il vuoto non è ontologico non-essere, è un vuoto funzionale, l’ambito della disponibilità di cui si alimenta il processo: il vuoto al centro dell’assale permette alla ruota di girare, il vuoto all’interno del vaso permette di contenere, ricorda il Laozi.
In questo pensiero dell’immanenza non esiste evasione possibile dalla realtà materiale né condanna dei legami col mondo terreno, come sogna il buddismo (che giunge in Cina da Occidente, dall’India), nel Nirvana in cui trova termine il ciclo delle reincarnazioni.
La Cina non ha pensato l’eterno, l’Essere fuori dal tempo, bensì il costante, cioè il procedere continuo delle cose per alternanza: non coltivando il culto dell’Essere, non ha neppure immaginato di squalificare il divenire soggetto al tempo corruttore. Invece di fare del Tempo un’astrazione, un involucro omogeneo al cui interno disporre il succedersi degli eventi, la Cina, ha spiegato Jullien in Il tempo. Elementi di una filosofia del vivere (Luca Sossella, 2002), ha pensato il momento stagionale e la durata. E questo non si deve al fatto che i Cinesi avrebbero lo spirito concreto, come spesso si è detto (Hegel docet) e neppure per ragioni implicite alla loro lingua, che non coniuga e non distingue i tempi verbali. Quando hanno introdotto il termine “tempo” nel XIX secolo, a contatto con l’Occidente, si sono serviti di un ideogramma traducibile come “fra momenti”: le differenze qualitative che scandiscono, con le variazioni stagionali, il corso della natura fanno del tempo un succedersi regolato di momenti, grazie ai quali viene pensata in primo luogo la continuità della transizione e del passaggio.
Il tempo non si costituisce così in soggetto-agente indipendente, non viene astratto, cioè estratto, dal costante rinnovarsi del mondo: la personificazione del tempo, Kronos o Saturno che divora i suoi figli, è l’eredità che il pensiero mitico ha lasciato alla filosofia (residuo inconfessato di una trascendenza mai abolita). Quando gli dei si ritirano, il Tempo li rimpiazza conservando in sé lo status di un potere onnipotente, di cui subiamo l’azione distruttiva.
In opposizione alla distensione temporale tra inizio e fine, entro la quale l’Occidente ha pensato il tempo della vita, facendola precipitare verso la sua Fine, la Cina ha pensato la processualità secondo una logica della transizione e della durata. Diceva Bergson che vivere è invecchiare, ma dell’invecchiare non si danno inizio e fine, ma solo corso indistinto: la transizione avviene in ogni momento e l’evento è riassorbito nella continuità silenziosa del processo, scandito da piccole trasformazioni tanto più efficaci quando più restano inavvertite (Le trasformazioni silenziose, Cortina, 2010). La nascita non è passaggio dal nulla all’essere, ma rendersi manifesto di ciò che era latente, ed il morire non è annullamento, ma rendersi latente di ciò che prima era manifesto.
Nascendo semplicemente si diventa uomini, morendo si ridiventa Cielo-Natura, cioè si torna al fondo di latenza del processo da cui sorge ogni esistente. In questa prospettiva, vivere è dell’ordine della transizione che si dispiega nella coincidenza con ogni momento particolare, come suggerisce un aforisma di Montaigne, uno dei pochi in Occidente ad aver raccolto il lascito della saggezza: “Il nostro grande e glorioso capolavoro è quello di vivere a proposito”. Pensare la vita sotto il giogo del Tempo apre il senso del tragico, pone ogni esistenza, fin dal suo sorgere, sotto il destino dell’inevitabile annientamento; scorgendo nel Tempo una continua fuga in avanti per colmare il vuoto del presente, la questione del Senso, che assilla l’Occidente, sfocia inevitabilmente nel mistero dell’oltre o, con la modernità, nella convinzione dell’assurdità dell’esistenza.
Pensare il vivere secondo il momento ci apre invece al rinnovarsi senza fine delle differenze che costantemente si offrono, si traduce in invito ad accogliere in modo sereno il corso della realtà, restando disponibili alle sue opportunità. Credendo di afferrare qualcosa di originario ed universale, Heidegger scorge il senso del Dasein nella temporalità; ma che l’esistente umano, gettato nel mondo, sia in cammino verso qualcosa e che nel suo pro-gettare anticipi la propria fine, suona conferma dei presupposti di una tradizione, del sentimento ebraico-cristiano del peccato originale che ci fa avvertire estranei al mondo. La sua tesi affonda nella piega europea del tempo, sconta il “debito impensato” nei confronti della tradizione ebraica, secondo la formula proposta da Marlène Zarader (Il debito impensato. Heidegger e l’eredità ebraica, Vita e Pensiero, 1995).
Il saggio, al contrario, non mira a costituire un soggetto “autentico” cercando risposte al senso dell’esistere: lascia l’iniziativa al “momento” del mondo, il suo vivere appartiene alla natura e non richiede giustificazioni. L’uomo saggio “respira con i talloni” (Zhuangzi), cioè fa in modo che tutto il suo essere resti disponibile al processo, si mantenga in fase con le sue incitazioni. Non sarà dunque l’angoscia il sentimento che caratterizza l’esistenza umana; il mondo non si svela come estraneo, ma come invocante, da esso siamo accolti e invitati fin dalla nascita. All’Occidente prometeico, che drammatizza il suo agire nella prospettiva heideggeriana della cura e dell’essere per la morte, il saggio confuciano risponde praticando la noncuranza, non intesa come fuga o dimenticanza, ma come de-preoccupazione, come costante e spontanea adesione al momento, serena sintonia con il vivere a cui la morte stessa è integrata.