Giorgio Agamben / Hölderlin nella torre
La torre di Hölderlin è il vero tema del libro di Agamben. Si entra attraverso un saggio iniziale, c’è quindi una corposa parte centrale, cronologica, fitta di lettere e testimonianze. È una struttura interna, biografica, che è quasi una scala dove saliamo con Hölderlin nella torre. Alla fine, o piuttosto in cima, ci si affaccia attraverso un saggio finale su orizzonti molto ampi. Com’è finito nella torre Hölderlin e perché ci rimane per trentasei anni? Forse perché l’amico Sinclair viene arrestato e il poeta inizia a ripetere Non sono un giacobino. Nato nel 1770 ha 19 anni quando scoppia la rivoluzione francese, la politica nella sua generazione è uno snodo di tante questioni diverse e forse in seguito vuole ritrarsi, sottrarsi da quello che la politica dice. Forse ci sono tracce di una delusione amorosa, o semplicemente le difficoltà con gli altri umani e il mondo di tutti, in ogni tempo.
Di fatto alla fine ci si ritrova all’interno di una torre che è come un pensiero, come la poesia. Qualcosa di verticale così intrinseco alla persona che è difficile parlarne senza tradirne le difese e quindi la sua funzione principale, proprio perché parlare e interloquire è rivolgersi ad altri, mentre quel che caratterizza la torre è una chiusura al mondo, l’arroccarsi per sopravvivere. Hölderlin infatti non parla davvero, manda biglietti, messaggi, il suo luogo è sempre più interno, irraggiungibile. La torre si innalza, come il pensiero di Pierre Bezuchov quando viene portato davanti al plotone di esecuzione, come il percorso dantesco dal Purgatorio in avanti. Una interlocuzione non diretta e chissà con chi, di cui ci giungono le tracce.
A chi parla Hölderlin? È in un punto altissimo, in cui la storia gli scorre davanti agli occhi. E così la pioggia, le stagioni, il tempo. Come felice è vedere, quando le ore tornano/in cui l’uomo di sé contento contempla i campi. Intorno alla torre ci sono fiumi, la vita che è il nostro amore per il mondo, per gli altri. Vivere è un darsi infinito, essere transitivi, siamo per altri e con altri. Amiamo qualcuno che ama qualcun altro e questo correre di ognuno di noi verso qualcun altro fa sì che si è sempre riceventi e danti, ci si rivolge sempre a un esterno, si scorre tra gli altri e le cose. Gli uomini sono felici, Se essi siano buoni o vivano per la virtù/poiché l’anima è lieve e raro il lamento. Agamben segue questo straordinario percorso senza cedere a tentazioni sentimentali, avverte come fosse il proprio il rischio di dissipazione e pericolo che inevitabilmente innerva questo essere al mondo. Parla di un vivere a cui basterebbe guardare il cielo e la luna, camminare per una strada del centro, scambiare sguardi e frasi con tutti e che invece alla fine rinchiude in una torre. Quasi una prigione scelta per sottrarsi a un’altra prigione (politica, sentimentale, umana).
La sofferenza di questa condizione non viene idealizzata. L’essere così aperti al mondo rincula in una richiesta di rassicurazione. La torre, per Hölderlin, è una condizione di estrema dipendenza da chi si occupa di lui. Ma anche fuori dalla torre c’è una strana dipendenza. Quando vorremmo che le opinioni politiche fossero un partito, o che gli altri fossero tutti amici fedeli, che chi amiamo ci riamasse e a nostra volta impegnarci ad amare chi ci ama, chiudendo in altro modo il nostro essere al mondo in qualche formula, per assicurarci che tutto sia al sicuro, investito bene. Quando ci si ama a vicenda si può anche finire prigionieri di una torre che non si alza, anzi, che rischia di rimanere piatta, di accontentarsi di riverberi sentimentali, narcisisti, che alla fine scadono facilmente in consolazioni che piegano a un consumato birignao amicale o coniugale. Un’alleanza professionale, un’amicizia che degrada in una consuetudine. La stessa condizione della torre: Il progresso dell’abitudine conduce la coscienza, attraverso un’ininterrotta degradazione, dalla volontà all’istinto scrive Agamben citando Félix Ravaisson. Una incolmabile solitudine.
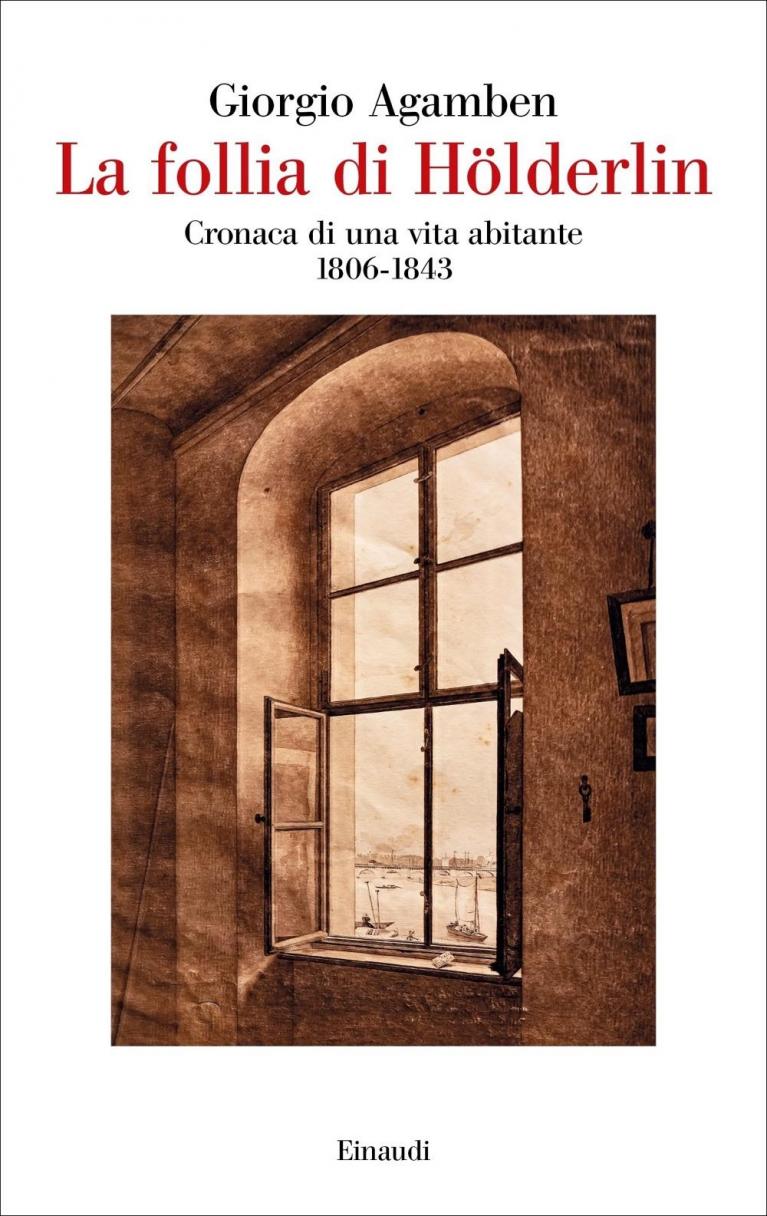
Se quindi da un lato la poesia mira in alto perché bisogna rendersi veggenti, dall’altra è costantemente esposta al rischio di confondere la veggenza con una sbornia di se stessi, e questo può avvenire da soli come in mezzo agli altri. Quello che conta è invece la torre. Abitare la vita lasciando che quello che pensiamo di noi stessi e del mondo non oppongano oggetto e soggetto. Sono i temi della filosofia della sua generazione e sono andati maturando nell’empirismo, ora lo riguardano così da vicino che è proprio la soggettività ad essere una prigione.
Hölderlin avverte quanto sia incandescente questa materia. Si discosta dagli altri attraverso una deferenza nei loro confronti che a prima vista sembra dire lasciatemi in pace! Chiama tutti eccellenza, si firma nelle lettere alla madre devotissimo figlio, irrigidisce la distanza in formule di cortesia quasi a sancire la separazione da tutti. Queste maniere sono i muri della torre.
All’inizio dell’omonimo libro, Hyperion racconta a Bellarmino che quando sente parlare tedesco si sente come un cane che tira la catena che gli stringe il collo. Dei tedeschi ha scritto: Barbari di un’epoca più antica, che si sono resi ancora più barbari attraverso il lavoro, la scienza e la religione. Lui è nel mondo greco e sentire la propria lingua madre lo soffoca. Le due lingue, l’abitare un mondo che non è quello della parola che si può scambiare con gli altri, lo spingerà a elaborare un tedesco, come spiega nel saggio introduttivo Agamben, che è un calco, un’elaborazione di una lingua che diviene impossibile. Oppone l’essere nel proprio a essere nell’altro, in quello che non è nostro. Questo è familiare a tutti i traduttori: come rendere quello che esiste in un ambito in un altro? La traduzione non è solo da una lingua a un’altra, è tra l’essere nel proprio e l’essere con l’altro, per l’altro, nell’altro. Quindi non è un problema solo dei traduttori, ma di tutti noi. Cosa significa essere nel proprio? e come si può rendere quello che si è in sé in qualcosa che sia anche per l’altro? Come si esce dalla torre? e vogliamo davvero uscirne? Nello scrivere una poesia o in qualunque impresa artistica, ci diamo davvero, come scrive Pasternak in una famosa poesia? (Essere rinomati non sta bene./ Non è così che ci si leva in alto./… Scopo dell’arte è donare se stessi.../ Si deve invece vivere senza impostura/ vivere così da attrarre, in fine, a sé / l’amore dello spazio/udire la chiamata del futuro.)
Siamo sempre nella torre. Mai forse come in questa pandemia nella condizione di Hölderlin, costretti ad attraversare una soglia, ora capaci e ora incapaci di farlo. Pieni di deferenza o insolenza per quello che è là, fuori di noi, alla ricerca del giusto garbo che ci consenta di aver a che fare con gli altri e consapevoli di come questa linea può essere costantemente valicata, mettendo noi o gli altri in pericolo. Troppo vicini, troppo lontani. E se questo confine non lo si avverte, non siamo forse proprio in quelle imitazioni di dimestichezza con gli altri in cui ci dimettiamo da noi stessi in nome delle buone maniere?
Hölderlin si firma alla madre devotissimo, ai tanti che gli si avvicinano si inchina professando rispetto e in questo modo confessando l’impossibilità di un contatto. A questo punto le idee e le opinioni non contano più nulla. La politica, la letteratura, quel che si pensa di questo o di quello è travolto dall’essere umani, fatti di immateriale, occasionalmente divini, e per questa ragione alla continua, disperata ricerca di poter constare in qualcosa. Un titolo professionale, un ruolo sociale, un nome. Eccellenza, come Hölderlin dice un po’ a tutti, quasi dicesse “forse lei esiste…” Ma in tutto questo tentativo di esserci paradossalmente e progressivamente si rivela l’assenza.
Pensare la follia diventa alla fine per Hölderlin, Agamben e per chi segue questo percorso, pensare l’umano: Pallacksch, che nella lingua di Hölderlin significa sia sì che no, che è l’esclamazione con cui si chiude anche il libro di Giorgio Agamben, è il minimo che dobbiamo a un uomo tanto gentile, per restituire al poeta la vita che gli è mancata per delicatezza, come scrive Rimbaud (Oisive jeunesse/À tout asservie,/ Par délicatesse/ J’ai perdu ma vie), per consentire ai folli, all’amico, la dignità di essere umani, per essere semplicemente quel che si è, abitare la vita.









