Franco Vimercati. Tutte le cose emergono dal nulla
In anni non molto remoti, quando si trattava di parlare di artisti italiani che lavoravano con la fotografia, pareva esistessero solo le Verifiche di Ugo Mulas, le opere di Luigi Ghirri e al massimo quelle di Franco Vaccari. In mezzo sembrava estendersi un vasto territorio di nessuno. Da qualche anno, per nostra fortuna, vari curatori hanno cominciato a “riscoprire” le opere di importanti autori che, già a partire dagli anni Settanta, si sono soprattutto interrogati sul linguaggio visivo della fotografia e non tanto sul che cosa fotografare. Sono così state giustamente valorizzate le ricerche di Aldo Tagliaferro, di Davide Mosconi e Silvio Wolf.
E oggi, finalmente, nella magnifica cornice di Palazzo Fortuny a Venezia si può visitare un’ampia mostra antologica dedicata a Franco Vimercati (Franco Vimercati. Tutte le cose emergono dal nulla, a cura di Elio Grazioli, fino al 19 novembre). Una mostra accompagnata da un catalogo splendido, fondamentale per avvicinarsi all’opera di questo autore straordinario, al contempo essenziale e complesso. Stampato in modo egregio (cosa non facile data la qualità di stampa delle opere di Vimercati), con una preziosa intervista di Elio Grazioli realizzata poco prima della prematura scomparsa dell’autore nell’aprile 2001, il catalogo presenta anche, oltre a un testo del curatore, un’antologia critica che include, tra gli altri, testi di Luigi Ghirri, Paolo Fossati e Giuseppe Panza di Biumo, a testimonianza di quanto le opere di Vimercati siano sempre state apprezzate da critici e collezionisti di indubbia competenza e sensibilità (Franco Vimercati: opere 1974-2001, John Eskenazi Publications / Skira Editore, 164 pagine, € 40,00).

Rigoroso fino all’inverosimile, schivo e determinato, Franco Vimercati ha sempre lavorato come un artigiano proteso a creare lavori simili a haiku visivi, essenziali e concentrati, privi della presenza invadente dell’autore (cosa piuttosto rara in un paese come il nostro, dove pare fondamentale che un’opera degna di questo nome debba rispecchiare la prepotente “carica poetica ed espressiva” dell’artista). Che cosa ci mostrano in effetti queste immagini? Semplici oggetti della vita quotidiana ripresi uno a uno, in modo rigorosamente frontale. Oggetti che emergono da un fondo scuro, spesso fotografati in modo seriale procedendo per minime differenze legate al modificarsi della luce. Risale al 1975 una serie di 36 scatti, cioè un intero rullino, di altrettante bottiglie di acqua minerale Levissima. Per ben dieci anni – dal 1983 al 1993 – Vimercati si concentra su una piccola “zuppiera”, fotografandola con un’illuminazione prima più chiara, poi più scura, ruotandola, avvicinandola, quindi allontanandola di poco.
Di primo acchito, seguendo i luoghi comuni che influenzano il nostro modo di interpretare le immagini, viene facile pensare che l’autore fosse proteso a cogliere l’essenza di questa mitica zuppiera un po’ sbrecciata, segnata dal tempo e dall’uso. Invece non è così. Lo stesso Vimercati, in un’intervista (rimasta inedita) che gli feci nel 1997, mi disse: “Prendiamo la zuppiera su cui ho lavorato 10 anni, realizzando circa 84 fotografie. Ogni fotografia era la testimonianza di un lavoro, dei tempi d’esposizione, dello sviluppo della pellicola, della stampa. Avrei potuto cambiare soggetto ma, siccome non mi interessano i soggetti, ho continuato per 10 anni a fotografare la stessa cosa. All’inizio le differenze tra una immagine e l’altra erano minime, poi via via sempre più ampie affinché si capisse che si trattava di lavori sempre diversi”.

Lui, che aveva esposto negli anni Sessanta con Giulio Paolini, e si sentiva un artista vicino ad autori come Enrico Castellani, Ugo Mulas, Robert Ryman, On Kawara o Roman Opalka, voleva che ogni sua opera fosse un’interrogazione analitica e rigorosa sul medium fotografico e sul vedere; intendeva il suo come un lavoro (quasi un lavorìo) che rifletteva sulla fotografia più che sull’oggetto rappresentato. Parafrasando un po’ liberamente Merleau-Ponty si potrebbe dire che per lui “non ciò che il soggetto vede, ma l’enigma del vedere è il vero oggetto della sua fotografia”. Un enigma che Vimercati indaga con tenacia cristallina, giocando sulla minima variazione tra le immagini di una stessa serie e mettendo continuamente in scena lo scarto tra il linguaggio fotografico e la realtà. Il tutto realizzando fotografie nel modo più ortodosso possibile: egli infatti riprende gli oggetti sempre uno ad uno, senza mai creare composizioni, come se non volesse distrazioni di sorta tra lui, le cose e il processo fotografico. Non a caso, quando lo incontrai, mi disse che sentiva il suo lavoro vicino a quello di Thomas Bernhard, in cui la scrittura si protende tenacemente verso la “verità” ma, consapevole di non poterla raggiungere, si moltiplica, arretra e avanza in uno sforzo sordo e inesauribile, sempre votato allo smacco.
Nelle opere di Franco Vimercati non c’è narrazione, eppure la presenza del tempo appare dominante. Un tempo che si prolunga e si dilata immagine dopo immagine: un durare, un trascorrere, che penetra negli intervalli vuoti tra un’immagine e l’altra, ed evidenzia il fare stesso dell’autore nel tempo. Mi raccontò ancora durante il nostro incontro: “Dei tappeti anatolici mi piace l’aspetto araldico e il fatto che rivelino la lentezza della realizzazione. Nel loro essere si avverte come una litania, un fare lentissimo che dura mesi. Il senso dell’opera sta così più nel lavoro che nel risultato finale. Anche le mie 84 zuppiere in 10 anni sono come un tappeto, come un fare dentro l’esperienza profonda della relazione tra me, l’oggetto e la macchina fotografica”. Un concetto, quest’ultimo, che egli ribadisce, seppur in altri termini, anche nel dialogo con Elio Grazioli, là dove dice: “Occorre un’attenzione, una contemplazione anche nell’operare. Pensa alla cerimonia del tè. L’ultima cosa che interessa è proprio il tè”. Ciò che in effetti a lui interessava era operare dentro il processo del tempo: lavorare assecondando, in modo inflessibile e rigoroso, i ritmi della ripetitività e della durata, alla ricerca di una perfezione non virtuosistica ma minimale. Come un pianista proteso a suonare sempre meglio e con minime variazioni lo stesso pezzo. O appunto come un maestro della cerimonia del tè, totalmente concentrato nell’esecuzione perfetta di ogni singolo gesto, così che tutto risulti sempre compiuto con discrezione e semplicità, senza sforzo o tensione. Un esito possibile solo se la mente è stata liberata da ogni pensiero inutile ed è divenuta una cosa sola con il gesto stesso.
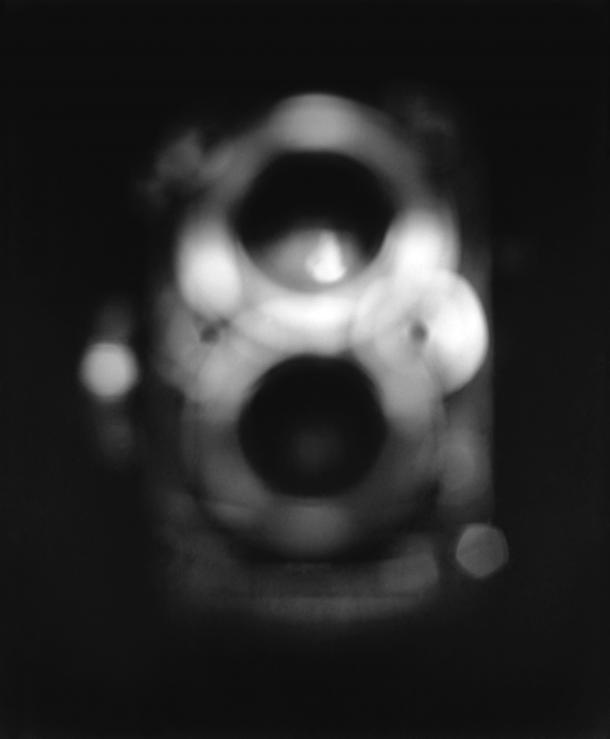
Il rigore concettuale con cui opera Vimercati non lo porta infatti nella direzione di una fotografia sciatta intesa come un puro prelievo di realtà. Se il che cosa racconta o il che cosa mostra è per lui secondario, prioritario diviene invece il “come” e dunque anche la qualità della stampa, la preziosità dell’opera. Nelle ricerche realizzate negli anni Novanta – con gli oggetti di casa visti capovolti, così come appaiono nel visore del banco ottico; oppure sfocati perché la fase della messa fuoco è stata volutamente sottratta – l’operazione che Vimercati persegue rimane pur sempre una riflessione analitica sul processo fotografico. Il risultato però, anziché apparire freddamente cerebrale (come accade a tanta arte concettuale, spesso incapace di procurare la benché minima emozione) è tutto all’opposto intenso, coinvolgente. “Le sculture africane sono frontali, non fanno niente e non vogliono dire niente, stanno e basta. In loro c’è una concentrazione massima delle forma, eppure comunicano”, mi diceva ancora Vimercati, parlando delle amate sculture africane che popolavano il suo salotto. Ebbene, anche le sue immagini sono frontali, essenziali, antidescrittive: pure loro non ci vogliono raccontare niente, ciò non di meno si trasformano in presenze che ci interpellano. Sono come apparizioni che emergono da un vuoto spaziale e temporale, senza rimandare ad alcunché di metafisico, né ad essenze nascoste: indicano solo se stesse, ci rimandano solo alla fotografia che le presenta.









