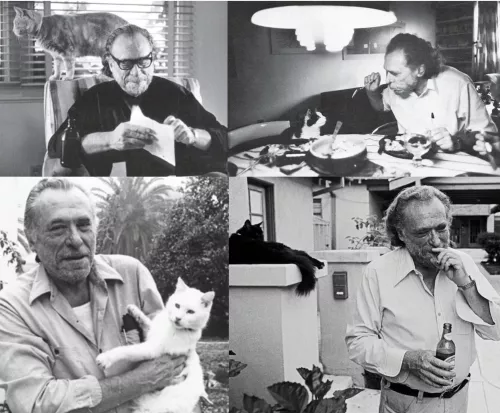Bukowski, lettere e schiamazzi di un gattaro impenitente
Misogino, omofobo, pervertito, alcolizzato. Persino gattaro. Questi alcuni degli attributi normalmente accostati al nome dello scrittore e poeta Charles Bukowski (1920-1994) dai fondamentalisti del politicamente corretto (ma non solo), sia avanti lettera che epigoni. Lui se ne è sempre fregato, continuando, imperterrito, a grattarsi sotto le ascelle, a bere e schiamazzare (non solo letterariamente parlando). Prova ne sia questo epistolario Notti di bevute e schiamazzi. 1960-1967, che Guanda ha appena mandato in libreria – a cura di Steven Moore (che firma anche la postfazione), e che si avvale della traduzione “benemerita” (vista la difficoltà slanghistica del testo originale) di Simona Viciani.
Si tratta di un nutrito scambio di lettere fra il ruvido Bukowski e l’eterea salutista Sheri Martinelli (nata Shirley Burns Brennan, 1918-1996), scrittrice, pittrice, scultrice, modella di Vogue per sbarcare il lunario. Si era fatta un nome come Queen of the Beats: Allen Ginsberg la cita in una sua poesia, Charlie Parker e i musicisti del Modern Jazz Quartet erano ospiti permanenti e rumorosi nel suo appartamento al Greenwich Village a New York. Marlon Brando era un suo ammiratore e Rod Steiger ne collezionava dipinti e sculture. Conobbe Ezra Pound e ne diventò più che “musa” quando: «con una mano mi toccava le tette e con l’altra sfogliava le Metamorfosi di Ovidio» (era il periodo del ricovero-detenzione del poeta – per presunta collusione col nemico durante l’ultima guerra – all’ospedale psichiatrico St. Elizabeth, a Washington).
L’opinione di coloro che frequentavano Pound in quel periodo, e quindi non potevano fare a meno di incontrare Sheri, quotidianamente presente al capezzale letterario del poeta dei Cantos, è spesso diversa e divergente. C’è chi la definisce «una giovane donna bizzarra, alquanto svitata», chi le dà della «manipolatrice, una problematica testa matta», ma anche chi asserisce che Sheri rappresentasse «la vera essenza dell’amore visto come ispirazione», e che avesse salvato la vita a Pound, perlomeno quella creativa.
Per Sheri, Pound – che, come ricorda il curatore, assocerà, nei Cantos, l’amante e allieva a una vasta gamma di figure femminili mitologiche e letterarie, curò il libretto La Martinelli, come la chiamava lui – pubblicato, a Milano, da Vanni Scheiwiller, in cinquecento oggi rarissime copie numerate (1956) – in cui erano riprodotti nove dipinti e due ceramiche. Scrisse il Vate: «Il turbine che ritardò il riconoscimento del mio genio (...) si snoda parallelo all’opera di La Martinelli, che è la prima a mostrare una capacità manifesta nella pittura o nella ceramica che va elogiata come la mia scrittura».

Ma non c’era solo Ezra Pound nella vita di Sheri che, per indole, era abbagliata dalle persone famose, meglio se controverse, ancor più se peccaminose e fuori dagli schemi. Come Anaïs Nin, alla quale, però non sa come presentarsi. Chiede lumi a Gonzalo Moré, il rivoluzionario peruviano amante della scrittrice. Lui le suggerisce di avvicinarla alla fine di una conferenza che la Nin avrebbe tenuto al Mills College. Le due “si riconoscono” a fiuto. Scriverà Anaïs: «Era il fantasma di me più giovane, una donna sognante, con occhi dolci, ardenti, lunghi capelli che le ricadevano sulle spalle. Una voce che tocca il cuore, che cambia di continuo: bassa, felice, triste, grave, ipnotica, sognante». Da quel momento, Sheri diverrà della Nin la più fedele delle groupie.
Scrivere, scrivere, scrivere
Sheri era, dunque, questo e molto altro. Non ultimo, era la direttrice della rivista Anagogic & Paideumic (1959-1970) che pubblicava principalmente poesia Beat: una sorta di fanzine letteraria, ciclostilata a San Francisco, dalla periodicità opinabile, e una struttura editoriale fatta di caratteri impastati, smangiucchiati, con interventi grafici incisi direttamente sulla matrice, il tutto rilegato con spillatrice casalinga.
Nel giugno del 1960, Sheri riceve una lettera da Los Angeles, da un tale Charles Bukowski, che le propone di pubblicare alcuni suoi versi. Lei li legge e risponde con una lettera di cortese rifiuto, soprattutto perché, scrive, è «follemente occupata» e non ha proprio idea di quando uscirà il successivo numero di A&P. Tuttavia lo informa che avrebbe conservato il suo indirizzo nel caso fosse riuscita a metterne insieme un altro.
Se, poi, come le chiedeva, avesse proprio voluto sottoporre i suoi lavori al poeta Robert Stock – componente di punta dell’Anarchist Circle di San Francisco – gli dà il suo indirizzo perché «non voglio prendermi la responsabilità di spedirglieli: Robert potrebbe non risponderti e ti chiederesti dove diavolo è finito il tuo lavoro».
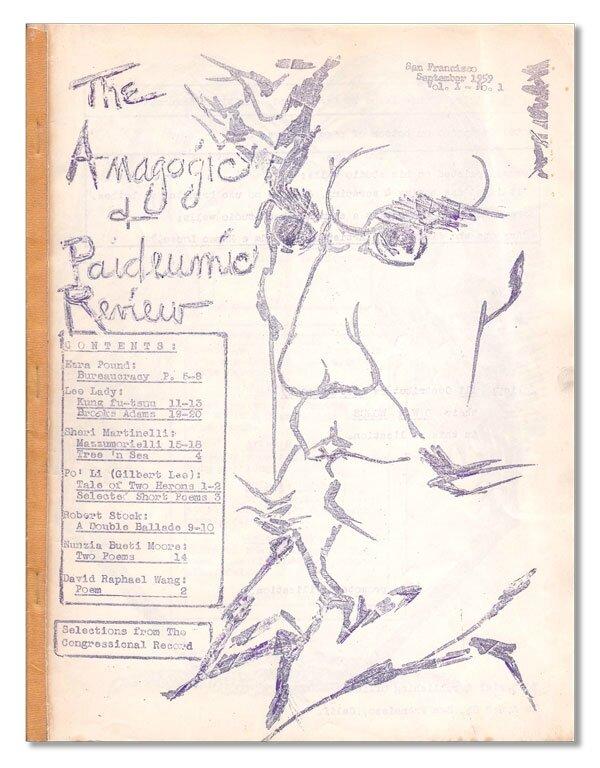
Ma non si limita a questi convenevoli. A proposito delle poesie che Bukowski le aveva mandato, annota: «Non sento potenza nei tuoi lavori. Ti consiglio di continuare a scrivere, di rispolverare in biblioteca greci e latini e scoprirai che la vita non è mai stata tanto diversa». Cita la lezione ricevuta da Pound che le diceva: «Non svuotarmi in testa il tuo bidone di immondizia». Gli suggerisce di leggere Wyndham Lewis. E soprattutto: «Tagliati i baffi; piantala di infastidire gli sbirri; stai sobrio; piantala di capire tutto da solo; lavati i denti; trova un modo per pagare l’affitto». Poi solleva un dubbio: «Ma hai letto la rivista A&P?».
In effetti, la tecnica di Bukowski era quella di inondare le riviste di sue poesie, spesso senza neanche sfogliarle con attenzione per capirne la linea editoriale. «La poesia si manda alle riviste. Riviste piccole», ebbe a spiegare Bukowski a Fernanda Pivano (la conversazione, avvenne anni dopo, nel 1980, e sarà pubblicata, nella sua integrità, e freschezza discorsiva, nel 1982 da Feltrinelli con il titolo programmatico di Quello che importa è grattarmi sotto le ascelle). «Il mio problema è che scrivo troppo e non si può pubblicare tutto. Per esempio, ho appena mandato una sessantina di poesie a una rivista e loro ne hanno potute prendere solo diciannove perché dicono che devono pubblicare anche altri scrittori. Io mando mucchi di poesie in giro. Scrivo troppo, le riviste non riescono a tenermi dietro. E questo è un problema. Così ho tutte queste poesie ferme nelle scatole. E devo dire che sono quasi tutte abbastanza buone. Così sono quello che si chiama prolifico, sono prolifico, prolifico, prolifico. Continuo a scrivere, scrivere, scrivere, scrivere, scrivere. Ed è bello, mi piace».

«L’essenza della poesia è fandonia colpita a scudisciate»
Ma torniamo alla lettera di rifiuto di Sheri Martinelli. Bukowski, stizzito, ma neanche troppo, le risponde: «Cristo, ho letto i tuoi classici, ho sprecato la vita in biblioteca. Leggere ormai non mi serve più a niente, il meccanismo si è fulminato. Non posso cambiare il mio flusso creativo in base alle critiche». E poi: «Non sono un “giovane poeta”. Quest’anno ne compio 40. Scrivo poesie da 5 anni, ma prima: 10 anni da ubriacone; prima ancora, racconti. Oggi stanco, svuotato; corvi volteggiano fuori dalla finestra». Poi, alla fine, aggiunge un poscritto ispirato: «Lascia che i curiosi siano dannati e che i dannati siano curiosi: l’essenza della poesia è fandonia colpita a scudisciate».
E questo è solo l’inizio di uno scambio epistolare, talvolta impertinente, talvolta irritante, senza che i due si incontrino mai, e che andrà avanti per otto anni, a colpi di: «Sei un romantico senza speranza, tu agnellino innocente», «Mia cara non andremo mai d’accordo: continui a fare la precisina con le Parole! Va bene, fai il tuo lavoro e piantala di essere scorbutica con me».
«Se spazzassero via tutta l’umanità non si perderebbe niente»
Al di là di come Bukowski intende la poesia, già in queste lettere, come farà poi spesso, ci tiene a mettere le mani avanti, e chiarire che, nella sua opera, non c’è impegno sociale di sorta (come l’ha sempre interpretata la sinistra, soprattutto europea). Le grandi questioni del mondo non lo interessano, che sia l’ecologia o la bomba atomica.
Ribadirà a una stupita Fernanda Pivano che lo incalzava nell’intervista citata poc’anzi, «Il problema nucleare? Non rimango sveglio la notte a pensarci. Anzi, non ci penso affatto. Sono indifferente alla distruzione della razza umana, non me ne importa niente. Se spazzassero via tutta l’umanità non si perderebbe niente». La salvezza delle balene, del grande leopardo bianco o della pantera nera sono argomenti che non lo appassionano minimamente, non lo riguardano: «Quello che mi importa è andare a piedi fino all’angolo e comprare il giornale, e leggere di uno stupro avvenuto in strada o di una rapina in banca, e magari andare a fare colazione da qualche parte e bere una birra, e andare in giro e guardare un cane o grattarmi sotto le ascelle. Non mi interessano i grandi problemi». Chiaro?
Bukowski non si prende mai sul serio, ricorda l’americanista Alessandro Carrera. Però, pur con le sue ingenuità dozzinali, le sue sbronze miserevoli, prendeva terribilmente sul serio la letteratura, come appare chiaro in queste Notti di bevute e schiamazzi. Anche se il suo concetto di letteratura era, diciamolo pure, molto personale. Molto alcolico. «Se succede qualcosa di brutto bevi per dimenticare. Se succede qualcosa di bello bevi per festeggiare. E se non succede niente bevi per far succedere qualcosa».