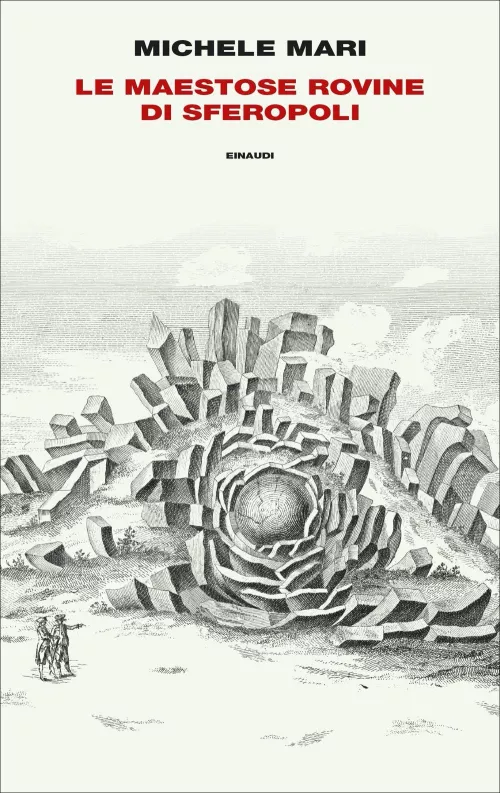Un libro-autoritratto / Michele Mari, Le maestose rovine di Sferopoli
Parlando all’ingrosso, i libri di racconti si dividono in due grandi categorie: le raccolte organiche e le raccolte eterogenee. Le prime sono caratterizzate da un’evidente coesione interna, dovuta a vari fattori: la ricorrenza del personaggio protagonista, la costanza dell’ambientazione, l’omogeneità tematica, il registro stilistico dominante. Le seconde presentano invece connotati programmaticamente variegati. Tanto per esemplificare dall’opera di Calvino, alla prima categoria appartengono Marcovaldo, le Cosmicomiche, Gli amori difficili, Palomar; alla seconda, Ultimo viene il corvo e Ti con zero.
Ovviamente la dicotomia non va assolutizzata: non è difficile immaginare casi intermedi, in cui gli elementi unitari e aggreganti, da un lato, e i fattori centrifughi, dall’altro, tendono a equilibrarsi. Come sarebbe risultato il libro sui cinque sensi, se fosse stato portato a termine il progetto a noi noto come Sotto il Sole giaguaro? Ma l’esempio calviniano suggerisce un’altra considerazione. A loro volta, i libri di racconti non uniformi si possono dividere in due specie: quelli in cui la varietà discende da una sperimentazione in corso, e quelli che invece passano in rassegna modalità espressive mature e consolidate, quasi celebrando un’acquisita poliedricità, una riconosciuta varietà di doti.
È questo il caso dell’ultimo libro di Michele Mari, Le maestose rovine di Sferopoli (Einaudi, pp. 172, € 18,00). Mari è uno scrittore di prestigio, che negli anni si è cimentato in una serie di narrazioni abbastanza diversificate. Qui ne troviamo una sorta di florilegio: quindi, un volume che si direbbe destinato piuttosto ai suoi fedeli estimatori, che non a lettori nuovi. A chi volesse accostarsi per la prima volta all’opera di Mari, io seguiterei a consigliare Tu, sanguinosa infanzia (1997) o Rondini sul filo (1999), Verderame (2007) o Leggenda privata (2017), senza dimenticare Roderick Duddle (2014); ma chi ha già familiarità con lo scrittore milanese non potrà non trovare quest’ultima raccolta davvero godibile. Il titolo è desunto dal primo racconto, Strada provinciale 921, parodia dello stile delle guide turistiche – diciamolo pure, delle guide rosse del Touring Club Italiano (peraltro più che benemerite).
L’inamidata compostezza della descrizione dei luoghi – «Meritano una sosta i borghi di Fargia (cappella del Redentore, con affresco del XIII sec.; collegiata di S. Firmino), Mendola (antichi lavatoi e Pozzo Massimo) e Roccella, dove al civico 10 di via Garibaldi si può visitare la casa natale di Terenzio Santapaola (ingresso a pagamento lun.-ven. 9.00-12.00 e 15.00-18.00, sab. 9.00-12.00)» viene incrinata da bizzarri soprassalti d’umore, che piegano il discorso in direzione del presagio o dell’oroscopo: «Al mattino è d’obbligo una visita a Terraglio di Grotta (SP 956 direzione Marengola), centro di produzione artigianale di terrecotte e ceramiche: presi da un entusiasmo artificialmente autoindotto, acquisterete un enorme orcio-giara pentendovene immediatamente». All’estremo opposto del volume, il venticinquesimo e ultimo pezzo, Vecchi cinema, è invece un veridico repertorio delle sale cinematografiche attive a Milano negli anni Sessanta e Settanta: e in questo caso il piacere della lettura non può che dipendere strettamente dai ricordi personali del lettore (per i concittadini e coetanei di Mari, un caleidoscopio di madeleines).

Uno dei registri più efficaci è quello del fantastico, spesso declinato in chiave horror. Con gli occhi chiusi recupera la forma della narrazione epistolare: il carteggio tra un affittuario e la padrona di casa esibisce un crescendo di confidenza e di suspense che si direbbe quasi una piccola epifania del perturbante (das Unheimliche, appunto, nell’originale formulazione di Freud). Argilla rielabora invece il mito del golem, attingendo implicitamente a motivi fantascientifici, d’altronde sempre meno lontani dalla realtà attuale, dove l’intelligenza artificiale guadagna ogni giorno spazio. Ma interessante è anche lo spunto iniziale, una periodica competizione fra rabbini: temperamento agonistico, Mari riprende volentieri la forma della gara, come in Boletus edulis, resoconto fra il comico e il grottesco della rivalità tra due parroci della Val Seriana, che si contendono il primato di più esperto raccoglitore di funghi porcini della zona.
Un altro territorio frequentato con ottimi risultati da Mari è quello della narrazione di memorie: si veda qui il racconto In cauda, frammento autobiografico sugli anni degli studi alla Statale intriso di citazioni letterarie. Molto presente, a proposito, è anche il gusto per la letteratura di secondo grado. L’esempio più vistoso è Il falcone, riscrittura della novella di Federigo degli Alberighi, nona della quinta giornata del Decameron: attingendo a una vocazione per il pastiche noto ai suoi lettori fin dai tempi del leopardiano Io venìa pien d’angoscia a rimirarti (1990), Mari si cimenta qui nella mimesi della prosa del Boccaccio, capovolgendo il messaggio del racconto originario. Ma il brano più divertente, e divertito, è Variazioni Goldberg: una raccolta di aneddoti eruditi (ovviamente immaginari) che riecheggia Il primo libro delle favole di Carlo Emilio Gadda, sia per il piacere ludico-erudito del travestimento linguistico, sia per l’estrosa bizzarria delle invenzioni.
A volte è tutto risolto in una sola, fulminante riga: «Appena sentivano “Ucci ucci” i bambini battezzati apostasiavano». Quasi sempre l’episodio evoca un personaggio famoso: «Quando il piccolo Robertino Fischer ricevette in regalo un cavallo a dondolo, si spostò immantinente in c6». Occasionalmente, anche due (in termini scacchistici, una forchetta): «Veggendo uno scàrafo sul plancito della cucina il piccolo Franceschino non l’occise. “Non so quale, ma anche tu devi avere la tua utilità”, pensò. L’istesso, alla vista di un topo, Gualtiero Disney». Molte le evocazioni letterarie, come prevedibile («Ogni fiata che iscontrava per via femmina vecchia o laida, Cecco lassavala altrui»), ma anche molti gustosi riferimenti storici («A monsieur de Béchameil, cortigiano, non aggradavano intingoli e salse: nondimeno morì eponimo»).
Un libro minore, dunque, nell’insieme dell’opera di Mari, che tuttavia contiene almeno un paio di racconti fra i migliori che egli abbia scritto; e, nello stesso tempo, un libro-autoritratto, un compendio delle sue predilezioni stilistiche, delle sue maniere e dei suoi modelli, dal racconto dell’orrore alla narrativa umoristica, dalla satira all’autobiografia, dal fantastico-visionario alla parodia. Concludo con un’ultima citazione da Variazioni Goldberg: «Scrivendo Il rosso e il nero Enrico Beyle anticipò di anni 69 l’operato di Eriberto Kilpin, sportivo». E questo valga come viatico per l’anno appena iniziato.