Il canto libero di Giuliano Scabia
Di che cosa è fatta la poesia? Ritmo, metro, verso, strofa. Di che cosa è fatta la poesia di Giuliano Scabia? Di vento, di quel respiro vitale che penetra ritmo, metro, verso, strofa: fiato, voce interna, accordo con il mondo. Ed è fatta di quel battito che dà il piede quando danza o quando vaga per terre lontane e nei paesaggi dell’anima, errando in cerca di qualcosa che non si conosce e che ci sta molto vicino, intonandosi con la propria voce profonda e allargandosi ad ascoltare i suoni delle persone e delle cose intorno.

Scandisce i suoi versi, il suo racconto, questo poeta narratore attore scrittore, accompagnandoli con movimenti delle mani lungo un’immaginaria linea orizzontale, d’orizzonte, e verso una contromisura verticale, l’asse del cielo e degli inferi. Macina con le parole evocazioni, ricordi, cultura, un pezzo della nostra storia recente; salta nell’immaginazione, nell’immaginario. Rimanda al fremito del corpo, al mormorio della terra, perché “metrica – il metro/misura” “è anche il tremito – e la metamorfosi della vita – il suo vento/respiro”.
Lo abbiamo visto ancora una volta a Bologna, nel Dams dove ha insegnato per più di trent’anni, portando i suoi studenti in giro per paesi, montagne, strade della città, lanciando nei dintorni del Settantasette mongolfiere e facendo rinascere poeti, andando con i corpi nei testi, dentro gli scontri e i riflussi, fino agli anni duemila. Nel teatro del Dipartimento delle Arti racconta la sua avventura con la musica, con il suono, in una serata intitolata con una frase di Witold Gombrowicz che bene rappresenta la sua poetica e il suo percorso: Coloro insieme ai quali canti mutano il tuo canto.
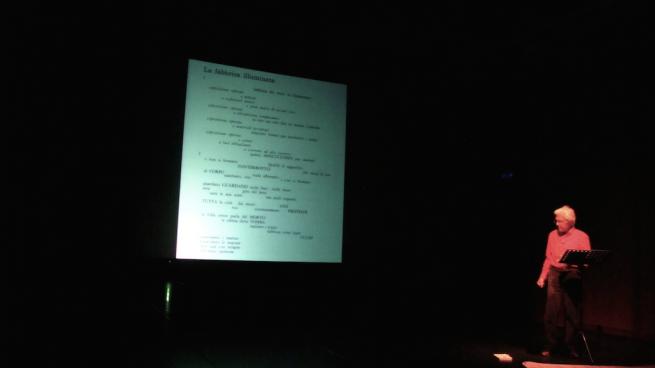
Inizia dicendo che avrebbe voluto leggere l’ultima sua opera, Commedia di matti assassini (ne ha realizzate alcune scene in forma di studio Luca Ronconi l’estate scorsa), la numero novantatré del ciclo del Teatro vagante, che sta componendo dal 1964, da All’improvviso, il testo che con Zip cambiò la drammaturgia introducendo nell’asfittico panorama del teatro italiano di allora gli oggetti, il consumismo, i bagliori della guerra del Vietnam, l’invasione dello spazio, la necessità di creare testi sulla scena (Giuseppe Bartolucci le avrebbe chiamate scritture sceniche). Questo ciclo comprende un numero limitato di testi tradizionali a battuta e didascalia (e spesso le didascalie la fanno da padrone, alterando i rapporti drammatici, sfidando le possibilità di messa in scena secondo i canoni del teatro corrente). È fatto di canovacci (o schemi vuoti, come li ha chiamati Scabia, progetti di azioni da compiere insieme ad altri, siano bambini, operai della Torino fine anni ’60, studenti, matti…), farse, ilarotragedie, quadri, canti (e anche commedie e tragedie, nelle quali parlano stelle, pianeti, comete, buchi neri, cavalli, lupi, scogli, cinghiali, gabbiani…).

Doveva, quindi, leggere una commedia ma, con un espediente che sa di preterizione, dichiara di non sentirsi pronto, perché essa è parte di un disegno complessivo, di un polittico che ancora non gli è chiaro, come una specie di personale Faust, di viaggio nel profondo delle cose, delle esperienze, della sua persona, forma segreta, quête, che non è il tempo di rivelare, viaggio attraverso “testi che, legati insieme, mostrano il viaggio di un poeta/autore travestito da teatro vagante, diavolo, attore, angelus novus, gruppo di attori, zip, cavaliere, cavallo, pedagogo, lupo, ragazzo cantastorie, poeta, mormorio, violoncellista, cinghiale, macellaio, uomo, donna, anno nuovo e altro”.
E allora decide di dare voce a qualcosa di più semplice, partendo dall’ultimo libro, di poemi teatrali e poesie, i Canti del guardare lontano (Einaudi), di spiegare la metrica della sua musica, del suo teatro della poesia, di portare l’ascoltatore nel suo laboratorio sonoro, musicale, dal 1964 al 2014. E scopre di essere uno degli autori italiani che più hanno collaborato con musicisti, da quei Diario italiano e La fabbrica illuminata scritti con Luigi Nono nel 1963-64 a opere composte con Sergio Liberovici, Fabio Vacchi, Carlo De Pirro, Claudio Ambrosini, Mauro Bonifacio, Aldo Sisillo, Mario Brunello, Mario Pagliarani, Luca Paccagnella, Michele Sambin, Gualtiero Bertelli e vari altri.

Narra, spiega, fa ascoltare. Mostra qualche video. Inizia proprio con la collaborazione con Nono, quando trasformò brani di interviste sulla vita di fabbrica, sull’allucinante fusione dell’acciaio a caldo e a freddo all’Italsider di Genova (la madre dell’Ilva di Taranto), quando trattò testimonianze sul disastro della diga del Vajont, le lotte alla Fiat e voci dalle strade di Palermo, in quel Diario italiano in cui il testo era una pre-musica, scomposto in fonemi, in grumi pesanti, stridenti, di vocali e consonanti, e la musica di Nono diventava parola gridata, sussurrata, deformata.
La storia ripercorre il suo teatro fatto di aperture, di partecipazione, di sfida a inventare un insieme, comunità provvisorie nell’epoca della disgregazione, rette da contratti basati sull’immaginazione. Dalla musica, dalla metrica di laboratorio, si passa a quella aperta in cerca di note che vengono dagli interlocutori, bambini, studenti, ricoverati nei manicomi, cittadini. Lampeggia il lavoro nei quartieri di Torino dopo gli scontri dell’Autunno caldo. Ascoltiamo la voce di Rosina, una dei pazienti ricoverati all’ospedale psichiatrico di Trieste di Basaglia, che inventa il motivo della canzone di Marco Cavallo, l’animale azzurro simbolo della liberazione. È un motivo semplice, popolare, come la voce della “matta” in quell’esperienza del 1973 che segnò una data fondamentale per la rottura dei muri dei manicomi. Coloro insieme ai quali canti mutano il tuo canto.

Scorrono poi il Gorilla Quadrumàno, realizzato con gli studenti del Dams sull’Appennino Reggiano, e appare il canto del maggio drammatico dei montanari, e poi la Vera storia di Mira che è anche quella di Porto Marghera, pre-testi anche per ascoltare gli altri, chi sta lontano dalle città, intorno a un Gorilla gigante, Uomo Selvatico che rappresenta qualcosa di lontano e forse di smarrito, come i boschi, la civiltà contadina, le favole, o intorno a un carretto-teatro vagante che le storie le va a cercare nelle periferie dell’industria diffusa, casa per casa, per disseppellirle dall’oblio.

Il palcoscenico si allarga con L’Angelo e il suo Diavolo, e il poeta diventa attore tra le foreste e i paesi del Casentino, Venezia tutta nel carnevale, Perugia, Parigi, fin sopra la torre Eiffel. Ritornano composizioni musicali, che accompagnano storie fantastiche come la Tragedia di Roncisvalle con bestie e i versi del Poeta albero, o laboratori come quelli con gli studenti del Dams sul ritmo dionisiaco di Baccanti e Rane o il suo Dioniso germogliatore, accompagnato magari da un violoncello.
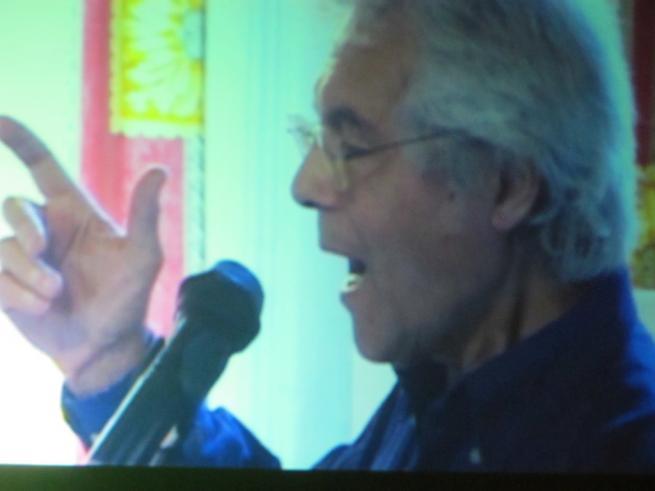
Ricorda e fa ascoltare, il poeta narratore, musiche di noti compositori intrecciate con letture dai suoi romanzi, della famosa saga di Nane Oca nella Pavante Foresta e nel Magico Mondo, sonorizzazioni radiofoniche, dialoghi tra suono e poesia. E spesso lo strumento è ancora il violoncello, con le sue note calde, i suoi vibrati trascinanti, tremito, come quello del verso, del mondo, del vento, del ritmo del ballo.

Scabia rivela la scoperta che il suo teatro vagante è il libro, verità contenuta nei Canti del guardare lontano: lo ha intuito una notte salendo con un gruppo di persone all’osservatorio di Arcetri, guadando con barche il fiume, illuminando la strada con lanternine. Il suo teatro è scena mentale, di possibilità infinite, senza vincoli, che nelle pagine vive e nelle voci che quelle pagine hanno generato rivive. Pagine di venti di vita. Suoni, vibrati come di violoncello, del violoncello del padre Guido, con cui suonò, piccolissimo, senza grande esito e futuro di strumentista. Ecco l’origine di questa ricerca continua di suono, di risonanza, in quel tocco familiare, paterno, che alla fine ascoltiamo, una bella registrazione di una trascrizione di musica indiana di quel musicista giramondo che lo scrittore ha fatto protagonista del suo In capo al mondo. Quel libro fu l’inizio di una nuova epoca per Scabia: dopo la poesia e il teatro, dopo le cronache della dilatazione della scena, il romanzo, la narrazione, nel 1990. La ricerca di un’altra voce, da affidare alla pagina ma prima ben viva dentro, pronta a ritornare fiato nelle letture pubbliche, respiro di un racconto, di una lingua, la propria, quella del corpo sociale mutante, dell’immaginario personale e di un’epoca, privato, collettivo, davanti agli altri, insieme, nei flussi, nell’ascolto instancabile.









