Tanizaki, o il segreto della maestria
Difficile, insidioso, è questo libretto pubblicato in patria (in Giappone) da Tanizaki Jun’ichirō nel 1933 e arrivato alle stampe da noi grazie ad Adelphi solo da poco. Sulla maestria, ovvero geidan, con tanto di ideogramma (un segno composito, che pare fatto di tanti veloci schizzi, di varie anime guizzanti). Una parola che da noi si applica soprattutto agli artigiani, maestria, qui genera varie riflessioni, a partire dall’osservazione degli attori del kabuki, una delle forme teatrali tradizionali giapponesi, trasformandosi nella chiave di un discorso estetico più generale, tra tradizione e innovazione, tra Oriente e Occidente, tra vecchiaia e gioventù, tra classico e contemporaneo.
Tanizaki, scrittore noto in Italia per il romanzo Neve sottile ma soprattutto per La chiave (e per l’adattamento cinematografico “scandaloso” che ne fece Tinto Brass), iniziò a scrivere e si affermò nel periodo dell’innovazione realista e modernista Meiji (1868-1912) e Taishō (1912-1926), e continuò la sua attività letteraria attraverso gli sconvolgimenti degli anni trenta, della guerra, della sconfitta, della ricostruzione.

Bandō Mitsugorō IV e Nakamura Kichiemon I in un dramma di ambientazione storica del 1928
Con quest’opera rivendicava il diritto dell’arte a non essere realista, a guardare alla tradizione, e in particolare a quella forma sublime di creazione cristallizzata in una presenza assoluta d’attore che si acquisiva con un lungo, duro, durissimo, apprendistato. Vero artigianato, il kabuki formava attori all’interno di famiglie con regole molto severe, sottoponendo i bambini a anni e anni (perlomeno dieci) di disciplina fisica rigida, durissima, con esercizi che dovevano modellarne completamente le capacità secondo i canoni tradizionali. A proposito di uno degli attori, inviato dalla sua famiglia in adozione a un’altra di quelle gilde d’arte, il maestro adottivo dice: “Probabilmente non resisterà e morirà, ma se dovesse sopravvivere diventerà un attore d’eccezione”.
Il punto sta in cosa consista quell’eccezione: è fatta di posture extraquotidiane, inflessioni della voce, attitudini, sguardi, segni di un alfabeto antico che si riconoscono in diversi contesti, senza che chi li possiede li ostenti. Tanizaki li ritrova nella foto di un attore pubblicata da un giornale. Li rivede nell’interprete di un film, che si distacca per forza della presenza elegante e possente da tutti gli altri.
Li scova, ancora, in certi interpreti della nuova drammaturgia influenzata dall’Occidente, tanto diversi nella resa scenica dai colleghi che non vengono dal teatro tradizionale. È l’opposto degli attori presi dalla strada che si preferivano in certi teatri votati al naturalismo in Europa e pure in Giappone. Anche per rendere meglio la realtà, che irrompe sullo scorcio del novecento pure sui palcoscenici del Sol Levante, la formazione antica che porta alla maestria è importante.

Ichikawa Danjurō IX nell’aprile del 1896
Tanizaki cerca anche in altri contesti quel carisma simile a uno stigma, quell’abilità forgiata in modo umile, giornalmente, per anni, e condotta a vette che in altri ambiti (quelli del teatro Nō) si sarebbero definiti di incanto sottile, di fiore meraviglioso (da Zeami, attore, maestro e trattatista quattrocentesco del teatro Nō, la tragedia aristocratica giapponese, in un libro, Il segreto del teatro Nō, pubblicato alle origini della Biblioteca Adelphi, nel 1966, con il numero cinque della collana).
Dall’attore del kabuki e da quello del bunraku (teatro di burattini di grandi dimensioni di cui ha scritto Roland Barthes: i fantocci sono manovrati a vista da inservienti che a un certo punto sembrano scomparire o addirittura essere mossi essi stessi dal personaggio di legno), Tanizaki passa a osservare il cinema, quello giapponese e quello occidentale, la letteratura e la pittura. In certi passaggi guarda, dall’esterno, diversi autori americani o europei.
Chaplin è freddo, concettuale, troppo calcolato, smart, come scrive non sappiamo se Tanizaki o la brava traduttrice Gala Maria Follaco, che ci aiuta a entrare in queste pagine dense e insidiose con un regesto dei nomi e un glossario che ci ricostruiscono, almeno in parte, il mondo intricato delle famiglie e delle forme teatrali e letterarie nipponiche. Balzac, come in genere l’Occidente, è frenetico, continuamente con l’assillo del guadagno, con difetti quali “una certa chiassosità della narrazione” e “l’assenza di un coinvolgimento emotivo”, mancanza, agli occhi di Tanizaki, di buona parte della cultura nostra (eccezioni Goethe, Schnitzler, in parte Strindberg e i russi…).

Onoe Baikō nel ruolo di una cortigiana in un dramma di ambientazione storica
Diverso è l’Oriente, dove i giovani sperimentalisti scrivono solo per una élite sotto i quarant’anni, ed essi stessi, raggiunta quell’età, tornano a una contemplazione più distaccata ma anche più calda delle cose: la natura perenne con il maturare torna al centro dell’osservazione, come nelle forme poetiche classiche dei waka e degli haiku. Sembra quasi una ritrattazione dell’autore, un pentimento per la propria stessa giovinezza, ora che si dichiara avviato verso la vecchiaia, quando non ha ancora compiuto cinquant’anni.
Libro strano, di sfiducia nell’effimero del contemporaneo, nella sete di innovazione e di superamento continuo delle avanguardie, a favore di una perennità, di una semplicità, di una povertà da artigiani di attori forgiati nel fisico, trasformati in propaggini delle famiglie, ma capaci di promanare un’aura, una presenza fuori dall’ordinario.
Libro che forse va letto accostandolo a una Bibbia del pensiero teatrale novecentesco come Il teatro e il suo doppio di Artaud. Gli scritti più famosi di questo volume furono compilati dall’attore francese negli stessi anni di Sulla maestria: del 1931 è quello sul teatro balinese, visto all’esposizione coloniale di Parigi; del 1932 e del 1933 sono i due manifesti del teatro della crudeltà; del 1933 Il teatro e la peste.
Anche Artaud inveisce contro il teatro e la letteratura occidentale realistica, politica, sociologica, contro la narrazione e la dittatura del testo (e negli anni venti aveva già rotto con movimenti d’avanguardia come il surrealismo di Breton). Contro il modernismo. A favore di un’arte antica e devastante quanto il contagio inspiegabile della peste, per un teatro alchemico, metafisico.

Matsumoto Koshirō VII nel ruolo del pirata Kezori
La sua scena ideale si doveva privare del dio-verbo, della parola degli innovatori occidentali, e diventare presenza, gesto, rituale. Contagio, ancora. Sappiamo che questi scritti influenzeranno tanta parte del nuovo teatro del dopoguerra, portandolo ad evadere dalle prigioni del senso, della didattica sociale e politica, per ritrovare il nerbo e i nervi dell’opera d’arte, capace di rivelare quell’“altro” che già Rimbaud scopriva nascosto nell’io. L’Occidente si guarda profondamente allo specchio attraverso la scoperta di teatri diversi, lontani, come quelli orientali per l’appunto.
La maestria di cui parla Tanizaki, quel promanare senza voler apparire, frutto di un lavoro lungo, è la tradizione, trasmissione continua e tradimento, estatico modo d’essere che si appella a una qualche essenza preesistente, contro la furia di innovazioni, per nascondere e rivelare insieme un ineludibile vuoto. Apre un’assenza e una persistenza, un tempo extrastorico, partendo dal mistero della presenza traslucente dell’attore kabuki, strana perché insieme trasparente e carnale, corporea e ineffabile. Riporta le arti del corpo al centro, mettendo in dubbio l’approccio razionale.
Incrinando il razionalismo novecentesco, lo sperimentalismo, l’avanguardismo, e quell’altro concetto che tanto ci guida oggi, dello smart, furbo, scattante, adattabile al mutare delle cose. Lì l’adattamento è avvenuto una volta per tutte nella formazione, nell’adeguamento forzato ai segreti di una tradizione che apre la strada per il manifestarsi di un’eleganza antica, la sola, secondo l’autore, che in un mondo di conflitti permette di evadere dalla scena della realtà, della sua rappresentazione e dei suoi ruoli stritolanti, verso regni della quiete, almeno per un po’, per vedere “centuplicarsi il nostro coraggio”.
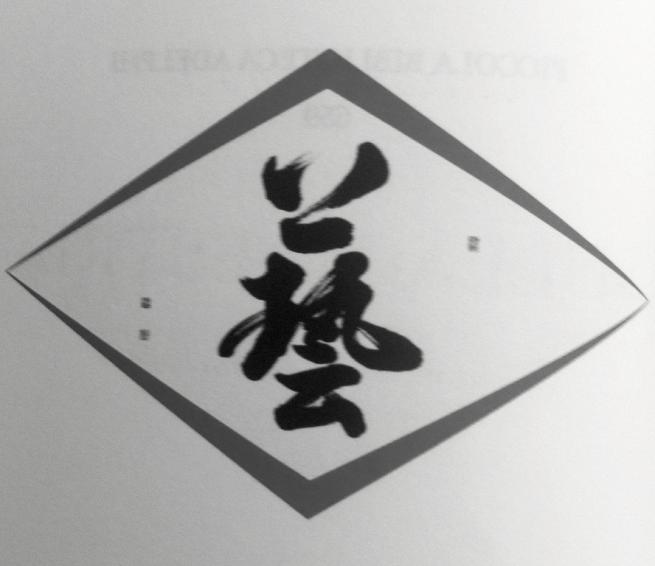
Un’ultima immagine mi rimane, che rimanda a altri conflitti di anni immediatamente precedenti, quelli (semplificando brutalmente) tra il metodo “psicologico” per arrivare al personaggio di Stanislavskij e quello convenzionale, “mascherato”, fisico, circense, biomeccanico delle diversi fasi del pensiero scenico di Vsevolod Mejerchol’d. Scrive degli attori tradizionali Tanizaki: “Quand’anche difettino di intelletto, una volta sul palcoscenico costoro si rivelano dotati di un istinto finissimo. Grazie a quest’ultimo sanno cogliere l’intento dell’autore.
Per loro la comprensione non si realizza nella mente (…) Penetrano il contenuto dall’esterno” (il corsivo è mio). Istinto, calore, intuizione e argini della tradizione contro indagine mentale, psicologica, comprensione; contro quello smart che include anche un elemento di furbizia, di calcolo, di economia. Tanizaki esalta l’umile arcaico artigiano gregario, che attraverso l’applicazione senza particolari picchi di genialità arriva a una qualità altissima, traslucida, di bellezza.
O, solo, a una spiccata dignità, capace di ascoltare non le teorie alla moda ma lo scorrere profondo delle cose, e trasfigurarlo in opera o in presenza. Dal teatro ci avviciniamo a questioni vicine al senso del rapporto tra ciò che siamo stati, ciò che saremo, ciò che forse sembra necessario essere. Alla metafisica dei corpi, all’atletismo del cuore di Artaud. Questo credo sia il segreto per noi ancora interessante della maestria di Tanizaki.









