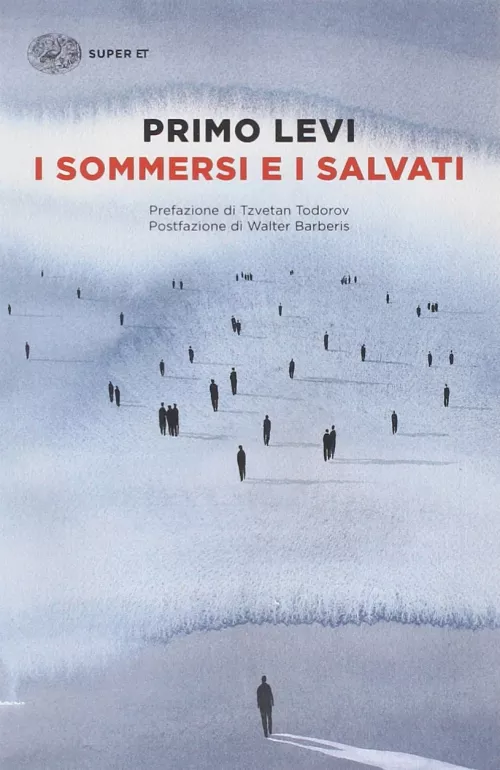Patria
“Patria”: non sarà inutile soffermarsi sul termine. Si colloca vistosamente fuori del linguaggio parlato: nessun italiano, se non per scherzo, dirà mai “prendo il treno e ritorno in patria”. È di conio recente, e non ha senso univoco; non ha equivalenti esatti in lingue diverse dall’italiano, non compare, che io sappia, in nessuno dei nostri dialetti (e questo è un segno della sua origine dotta e della sua intrinseca astrattezza), né in Italia ha avuto sempre lo stesso significato. Infatti, a seconda delle epoche, ha indicato entità geografiche di estensione diversa, dal villaggio dove si è nati e (etimologicamente) dove hanno vissuto i nostri padri, fino, dopo il Risorgimento, all'intera nazione. In altri paesi, equivale press'a poco al focolare, o al luogo natio; in Francia (e talora anche fra noi) il termine ha assunto una connotazione a un tempo drammatica, polemica e retorica: la Patrie è tale quando è minacciata o disconosciuta.
Per chi si sposta, il concetto di patria diventa doloroso ed insieme tende ad impallidire; già il Pascoli, allontanatosi (non poi di molto) dalla sua Romagna, “dolce paese”, sospirava “io, la mia patria or è dove si vive”. Per Lucia Mondella, la patria si identificava visibilmente con le “cime ineguali” dei suoi monti sorgenti dalle acque del lago di Como. Per contro, in paesi e in tempi di intensa mobilità, quali sono oggi gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, di patria non si parla se non in termini politico-burocratici: qual è il focolare, quale “la terra dei padri” di quei cittadini in eterna trasferta? Molti di loro non lo sanno né se ne preoccupano.
Ma l’Europa degli anni 30 era ben diversa. Già industrializzata, era ancora profondamente contadina, o stanzialmente urbanizzata. L’“estero”, per l’enorme maggioranza della popolazione, era uno scenario lontano e vago, soprattutto per la classe media, meno assillata dal bisogno. Di fronte alla minaccia hitleriana, la massima parte degli ebrei indigeni, in Italia, in Francia, in Polonia, nella stessa Germania, preferì rimanere in quella che essi sentivano come la loro “patria”, con motivazioni ampiamente comuni, e anche se con sfumature diverse da luogo a luogo.
Fu comune a tutti la difficoltà organizzativa dell’emigrazione. Erano tempi di gravi tensioni internazionali: le frontiere europee, oggi quasi inesistenti, erano praticamente chiuse, l'Inghilterra e le Americhe ammettevano quote di immigrazione estremamente ridotte. Tuttavia, su questa difficoltà ne prevaleva un’altra di natura interna, psicologica. Questo villaggio, o città, o regione, o nazione, è il mio, ci sono nato, ci dormono i miei avi. Ne parlo la lingua, ne ho adottato i costumi e la cultura; a questa cultura ho forse anche contribuito. Ne ho pagato i tributi, ne ho osservato le leggi. Ho combattuto le sue battaglie, senza curarmi se fossero giuste o ingiuste: ho messo a rischio la mia vita per i suoi confini, alcuni miei amici o parenti giacciono nei cimiteri di guerra, io stesso, in ossequio alla retorica corrente, mi sono dichiarato disposto a morire per la patria. Non la voglio né la posso lasciare: se morrò, morrò “in patria”, sarà il mio modo di morire “per la patria”.
(Primo Levi, I sommersi e i salvati, Einaudi, Torino 1986)
Di seguito i commenti al testo di Levi: