Speciale
Scarabocchi / Tito Faraci: raccontare l’invisibile
Negli anni Novanta, Tito Faraci è stato fra quelli che più hanno contribuito a riportare in primo piano la figura dello sceneggiatore in ambito disneyano. Figura poliedrica (è anche musicista, scrittore e autore radiofonico), Faraci annovera nel proprio curriculum sceneggiature per “Diabolik” e per varie testate bonelliane, “Tex” e “Dylan Dog” su tutte. Ma i risultati più riconoscibili e duraturi – tant’è vero che hanno fatto scuola – li ha ottenuti in casa Disney, innervando l’universo di topi e paperi di uno humour demenziale e di insolite atmosfere hard boiled. Chi scrive ha potuto cogliere “in presa diretta”, a cavallo del millennio, la portata innovativa delle sue trovate sulle pagine di “Ridi Topolino”, “Pk- Paperinik New Adventures” e “Mickey Mouse Mystery Magazine” (esperimento bello e sfortunato, di cui Faraci è stato uno degli artefici insieme a Francesco Artibani). Albi che hanno costituito – accanto alla “serie bianca” di “Zio Paperone”, alle “Grandi Parodie” cartonate e ai numeri monografici dei “Maestri Disney” – una vera e propria palestra di lettura.
Il “Faraci Touch” non aveva però fatto breccia soltanto nei lettori giovani o giovanissimi. Giusto per dirne una, già nel 2000 Einaudi raccoglieva una scelta delle sue storie (disegnate, fra gli altri, da Giorgio Cavazzano, Corrado Mastantuono, Paolo Mottura, Romano Scarpa, Silvia Ziche) nel volume Topolino Noir, accompagnate da una postfazione di Daniele Brolli. Un volume che, a scanso di equivoci, esponeva in copertina, proprio sotto il titolo, la dicitura “Storie scritte da Tito Faraci”. Era la prima volta che un autore Disney italiano veniva gratificato da una antologia libraria.
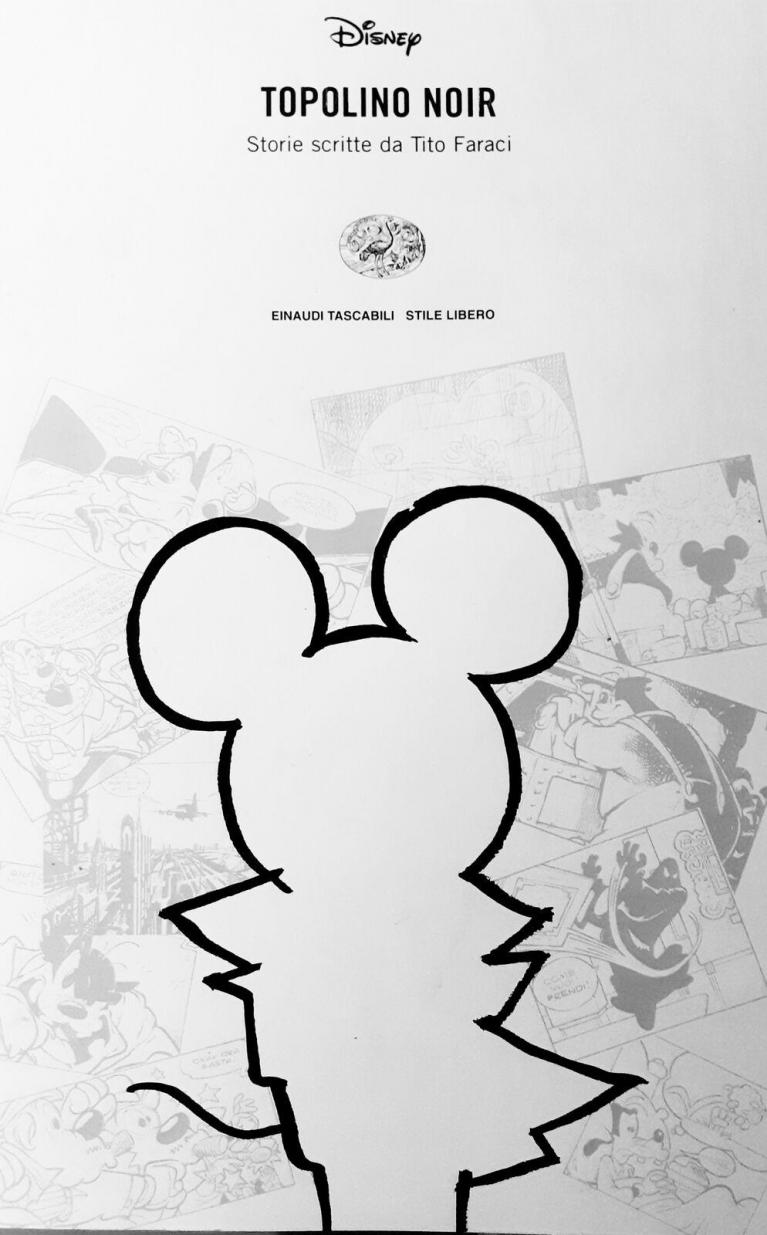
Per questa nuova edizione di Scarabocchi, Faraci, in coppia con Guido Scarabottolo, ha preparato un laboratorio per adulti dal titolo Disegnare l’invisibile. Mi è sembrata l’occasione giusta per ripercorrere insieme a lui alcuni aspetti di una carriera lunga ormai un quarto di secolo.
Nella descrizione dell’incontro che avete pensato per Scarabocchi si legge: “idee, rumori, cose sconvenienti e sensazioni, concetti che non si possono vedere”. Partiamo dai rumori: siamo talmente abituati all’utilizzo delle onomatopee nel fumetto che quasi non ci facciamo caso, mentre si tratta il più delle volte di elementi caratterizzanti. Quanto sono importanti per te?
Mi diverte sempre pensare (e raccontare) che su “Topolino” smack! è un bacio, mentre su “Tex” è un pugno. I rumori nei fumetti spesso sono codificati. Cambiano da serie a serie, a seconda degli universi narrativi. Suonano diversi, nella mente dei lettori.
I rumori seguono scelte narrative: nella vita reale, ma – per dire – anche in un film, siamo circondati da rumori, sempre. Nelle vignette di un fumetto ne isoliamo uno ogni tanto. Serve a sottolineare qualcosa che sta avvenendo, l'unico rumore importante. Determinante, spesso. Una pistola sta sparando se c'è un bang!; fa cilecca se c'è un click. Senza rumore, è soltanto una pistola che non sta facendo niente. Un’automobile, dentro un piazzale vuoto, è sicuramente in moto se fa wroom.
Dai rumori alle sensazioni. In Topolino e il fiume del tempo (1998), che hai sceneggiato con Francesco Artibani per i disegni di Corrado Mastantuono, c’è una dimensione sensoriale ed emotiva insolita per una storia disneyana: mi è capitato di “sentirmi lì”, insieme ai personaggi. Come siete riusciti, a partire dal ricordo di Steamboat Willie, a raggiungere quel livello di intensità?
Quella storia... La ristampano in continuazione. Eravamo così giovani, Francesco Artibani e io. Eravamo in una sorta di continua competizione positiva. In quel caso, abbiamo convogliato le forze: c'erano le mie ossessioni – in particolare, il rapporto fra Topolino e Gambadilegno – e le sue. Ma in realtà è difficile ricordare di chi sia stata un'idea e di chi un'altra: ci scambiavamo continuamente di posto al computer. Uno scriveva, l'altro gironzolava attorno. Ridevamo delle nostre stesse battute. Ci siamo anche commossi, qua e là. Ci ha sempre accomunati sentire i personaggi disneyani come reali, con psicologie complesse, perfino ambivalenti. Raccontare quei personaggi significa raccontare il nostro mondo: assomigliano a noi più di tanti eroi “umani” di altri fumetti.

L’ultima tavola di “Topolino e il fiume del tempo”.
All’opposto del rumore, il silenzio: ci sono molte vignette “mute” in Topolino e il fiume del tempo, come in altre tue storie. Come lo si può rappresentare sulla pagina?
Be’, sceneggiare significa soprattutto dare indicazioni di cosa sarà disegnato, delle immagini che finiranno sulla pagina. In una sceneggiatura, la maggior parte delle parole che scrivo sono descrizioni di inquadrature, ambienti, recitazione, posizione nello spazio di elementi... E i dialoghi, che molti pensano essere la cosa più importante, hanno uno spazio ridotto in confronto al resto. Uno sceneggiature di fumetti ragiona soprattutto per immagini. Le pagine nascono nella mia testa quasi sempre come delle specie di film muti, a cui aggiungo i dialoghi, se servono. Mi sembra sempre una piccola vittoria risolvere una scena senza usare nuvolette.
E veniamo alle “cose sconvenienti”. Nell’ambito del fumetto disneyano, a partire dagli anni ‘90 sei stato uno degli sceneggiatori che si sono spinti più in là, sia come concezione dei personaggi, sia come tipologia di situazioni da mostrare, sia come tipo di humour. La congiuntura era favorevole: soltanto pochi anni prima Don Rosa aveva affrontato nella sua Saga il tabù per antonomasia delle storie Disney, raffigurando il “trapasso” dei genitori di Paperone. C’era una gran voglia di rinnovare certi schemi, di sperimentare soluzioni nuove. Diresti che le cose siano cambiate da allora?
No, non credo che siano molto cambiate. Ci sono dei limiti, chiaro, che si spostano avanti e indietro. Ma in fondo il fumetto Disney dà così tante possibilità di affrontare tematiche che altrove non hanno spazio... Di raccontare la vita delle persone (sì, persone) comuni, con i piccoli e grandi problemi di tutti noi: sbarcare il lunario, mantenere vive le amicizie, rapportarsi con la propria famiglia... Alla fine non è una gran perdita se, per esempio, non puoi mettere un sigaro in bocca a un personaggio.
Vedo ancora molta sperimentazione sulle pagine di “Topolino”: è ancora un laboratorio di idee molto vivace. È vero, quando ho cominciato un certo genere di umorismo era raro – ma, devo dire, non soltanto là. Era qualcosa nell'aria, che stava arrivando. Qualcosa che in parte ho colto e in parte, certo, ho contribuito anch'io a creare.
Sempre a proposito di tabù: rileggendo le storie disneyane del passato, da Gottfredson e Barks a Guido Martina, mi sono reso conto di quanto fossero molto spesso “sconvenienti”: allusioni satiriche, caricature a sfondo politico… per non parlare, ovviamente, degli eccessi di linguaggio e di certe caratterizzazioni che oggi troveremmo inaccettabili. E oggi? Come si comporta uno sceneggiatore?
Gli elementi a cui fai riferimento ci sono ancora. Le storie disneyane a fumetti sono ancora piene di quelle sfumature psicologiche, di quelle contraddizioni e ambiguità. I personaggi non sono cambiati. Anzi, trovo che oggi zio Paperone abbia più profondità e sfaccettature rispetto ai tempi di Martina, e in questo senso si riagganci meglio al modello di Barks.
A volte, poi, non potere rappresentare qualcosa esplicitamente è un vantaggio. Ti fa lavorare sull'evocazione, invece che sulla cruda rappresentazione, spesso meno efficace. Anch'io, nel mio piccolo, credo di essere sempre riuscito – o quasi – a raccontare quello che volevo. Magari attraverso sentieri meno diretti, ma proprio per questo più interessanti.









